Un sito di oltre 480 pagine che descrive tutta l’Isola e che pur non vendendo nulla riceve fino a oltre un migliaio di visitatori ogni giorno


Capoterra dove è nato lo scrittore Sergio Atzeni con il centro e nei dintorni il Santuario di Santa Barbara de Montes
In questa tappa del nostro viaggio, lasciato il Sulcis Iglesiente, entreremo nel Campidano di Cagliari recandoci a visitare Capoterra dove è nato lo scrittore Sergio Atzeni.
Il Campidano di Cagliari
 Il Campidano è la grande pianura della Sardegna sud occidentale compresa tra il golfo di Cagliari e quello di Oristano, ha una lunghezza di circa cento chilometri e presenta la massima altitudine di settanta metri sul mare. Deve le sue origini al colmarsi di una depressione geologica terziaria da parte di sedimenti marini, fluviali e vulcanici. Sono frequenti gli stagni costieri con acque salmastre, nell’angolo nord ovest della Regione sfocia il fiume Tirso, che contribuisce all’irrigazione del Campidano, la rete idrografica è inoltre formata da piccoli Torrenti. La principale risorsa è l’agricoltura e si coltivano specialmente grano, viti, olivi, frutta e agrumi. Il Campidano di Cagliari comprende nella Provincia del Sud Sardegna i comuni di Decimoputzu, Monastir, Nuraminis, Samatzai, San Sperate, Villasor e Villaspeciosa. Comprende, inoltre, nella Città metropolitana di Cagliari i comuni di Assemini, Cagliari, Capoterra, Decimomannu, Elmas, Maracalagonis, Monserrato, Quartu Sant’Elena, Quartucciu, Selargius, Sestu, Settimo San Pietro, Sinnai, Uta. I comuni di Samassi, Serramanna e Serrenti si trovano tra il Monreale ed il Campidano di Cagliari, i comuni di Pula, Villa San Pietro e Sarroch si trovano tra il Sulcis ed il Campidano di Cagliari, così come Soleminis si trova tra il Campidano di Cagliari e il Parteòlla, per cui possono essere considerate appartenenti all’una o all’altra di queste regioni. Geograficamente rappresenta la parte più meridionale della pianura del Campidano, che ha come suo centro principale Cagliari, nonche Quartu Sant’Elena ed i comuni immediatamente a nord ovest del capoluogo sardo. Si affaccia sul mare e comprende la costa orientale del golfo di Cagliari, fino al paese chiamato Villasimius.
Il Campidano è la grande pianura della Sardegna sud occidentale compresa tra il golfo di Cagliari e quello di Oristano, ha una lunghezza di circa cento chilometri e presenta la massima altitudine di settanta metri sul mare. Deve le sue origini al colmarsi di una depressione geologica terziaria da parte di sedimenti marini, fluviali e vulcanici. Sono frequenti gli stagni costieri con acque salmastre, nell’angolo nord ovest della Regione sfocia il fiume Tirso, che contribuisce all’irrigazione del Campidano, la rete idrografica è inoltre formata da piccoli Torrenti. La principale risorsa è l’agricoltura e si coltivano specialmente grano, viti, olivi, frutta e agrumi. Il Campidano di Cagliari comprende nella Provincia del Sud Sardegna i comuni di Decimoputzu, Monastir, Nuraminis, Samatzai, San Sperate, Villasor e Villaspeciosa. Comprende, inoltre, nella Città metropolitana di Cagliari i comuni di Assemini, Cagliari, Capoterra, Decimomannu, Elmas, Maracalagonis, Monserrato, Quartu Sant’Elena, Quartucciu, Selargius, Sestu, Settimo San Pietro, Sinnai, Uta. I comuni di Samassi, Serramanna e Serrenti si trovano tra il Monreale ed il Campidano di Cagliari, i comuni di Pula, Villa San Pietro e Sarroch si trovano tra il Sulcis ed il Campidano di Cagliari, così come Soleminis si trova tra il Campidano di Cagliari e il Parteòlla, per cui possono essere considerate appartenenti all’una o all’altra di queste regioni. Geograficamente rappresenta la parte più meridionale della pianura del Campidano, che ha come suo centro principale Cagliari, nonche Quartu Sant’Elena ed i comuni immediatamente a nord ovest del capoluogo sardo. Si affaccia sul mare e comprende la costa orientale del golfo di Cagliari, fino al paese chiamato Villasimius.
Lungo la costa e poi all’interno verso Capoterra
Con la visita di Sarroch concludiamo il nostro itinerario nel Sulcis Iglesiente, del quale rimane da visitare solo Siliqua che vedremo in una prossima tappa del nostro viaggio. Dal Sulcis Iglesiente entriamo nel Capidano di Cagliari, e da Sarroch ci recheremo a visitare Capoterra.
L’insediamento turistico di Torre degli Ulivi con la sua spiaggia nella frazione Orti su loi
 Lungo la strada che da Sarroch ci porterà a Capoterra si trovano diversi insediamenti turistici e varie spiagge. Dal Municipio di Sarroch, percorsi 5.5 chilometri sulla SS195 Sulcitana, siamo arrivati alla Villa d’Orrì, da dove, proseguendo un altro chilometro e duecento metri, arriviamo a una rotonda, nella quale da sinistra si immette la nuova SS195 Sulcitanabis. Proseguiamo lungo questa strada in direzione nord, e, percorso poco più di un chilometro, si può prendere l’uscita verso destra per l’insediamento turistico di Torre degli Ulivi appositamente segnalata prima della rotatoria cha porta alla spiaggia. Si tratta di un centro residenziale sul mare, nato negli anni ’80 del Novecento nel territorio della frazione Capoterra denominata Orti su loi, che vedremo un poco più avanti. È divisa da un viale alberato che porta al mare, tra settore A a nord, e settore B a sud, ed ha avuto una grande espansione demografica negli anni ’90 con la costruzione di numerose villette a schiera.
Lungo la strada che da Sarroch ci porterà a Capoterra si trovano diversi insediamenti turistici e varie spiagge. Dal Municipio di Sarroch, percorsi 5.5 chilometri sulla SS195 Sulcitana, siamo arrivati alla Villa d’Orrì, da dove, proseguendo un altro chilometro e duecento metri, arriviamo a una rotonda, nella quale da sinistra si immette la nuova SS195 Sulcitanabis. Proseguiamo lungo questa strada in direzione nord, e, percorso poco più di un chilometro, si può prendere l’uscita verso destra per l’insediamento turistico di Torre degli Ulivi appositamente segnalata prima della rotatoria cha porta alla spiaggia. Si tratta di un centro residenziale sul mare, nato negli anni ’80 del Novecento nel territorio della frazione Capoterra denominata Orti su loi, che vedremo un poco più avanti. È divisa da un viale alberato che porta al mare, tra settore A a nord, e settore B a sud, ed ha avuto una grande espansione demografica negli anni ’90 con la costruzione di numerose villette a schiera.
 La spiaggia di Torre degli Ulivi deve il suo nome alla Torre de Su loi ossia Torre degli ulivi, che si trova sul lato del settore B dell’insediamento turistico che si affaccia sulla costa, a dieci metri sul mare, subito dietro la spiaggia e domina il tratto occidentale del golfo di Cagliari. Si tratta di una Torre di avvistamento, del tipo più piccolo, fatta edificare in epoca spagnola dal vicerè di Sardegna don Miguel De Moncada nel 1578. La torre era stata costruita di piccole dimensioni perché la zona di Capoterra era rimasta disabitata fin dal quattordicesimo secolo, dopo che, durante la guerra di conquista catalano aragonese, l’antico villaggio medievale era stato distrutto. Realizzata con blocchi e ciottoli di roccia granitica arrotondati dall’erosione marina e fluviale, ha una struttura con volta a cupola, ed un foro laterale per accedere al terrazzo.
La spiaggia di Torre degli Ulivi deve il suo nome alla Torre de Su loi ossia Torre degli ulivi, che si trova sul lato del settore B dell’insediamento turistico che si affaccia sulla costa, a dieci metri sul mare, subito dietro la spiaggia e domina il tratto occidentale del golfo di Cagliari. Si tratta di una Torre di avvistamento, del tipo più piccolo, fatta edificare in epoca spagnola dal vicerè di Sardegna don Miguel De Moncada nel 1578. La torre era stata costruita di piccole dimensioni perché la zona di Capoterra era rimasta disabitata fin dal quattordicesimo secolo, dopo che, durante la guerra di conquista catalano aragonese, l’antico villaggio medievale era stato distrutto. Realizzata con blocchi e ciottoli di roccia granitica arrotondati dall’erosione marina e fluviale, ha una struttura con volta a cupola, ed un foro laterale per accedere al terrazzo.
La frazione Orti su loi con la piccola chiesa dedicata a Sant’Efisio
L’insediamento turistico di Torre degli Ulivi appartiene alla frazione Orti su loi (altezza metri 12, distanza in linea d’aria circa 7.8 chilometri, non è disponibile il numero di abitanti), alla quale arriviamo cinquecento metri più avanti, lungo la SS195 Sulcitana, prendendo a sinistra alla rotonda. Prendendo, invece, a destra alla rotonda, la strada che porta al Campo Sportivo di Torre degli Ulivi, troviamo quasi subito, alla sinistra della strada, la piccola Chiesa dedicata a Sant’Efisio una Cappella stazionale, eretta sul ciglio della SS195 Sulcitana. Di pianta rettangolare, è stata costruita ai primi del Novecento come dipendenza della vicina villa padronale di un’azienda agricola. Il tetto a doppio spiovente è sorretto da travature lignee, coperto con tegole, e, sulla facciata liscia e disadorna con un campaniletto a vela, sotto la protezione di un piccolo porticato, si apre l’ingresso con arco a tutto sesto. L’unica altra fonte di luce dell’edificio è una finestra ad arco ribassato, sulla parete di fondo. Di particolare pregio il simulacro in legno policromato del Santo titolare, databile al tardo diciottesimo secolo, e un crocifisso di gusto popolaresco, anch’esso ligneo, di poco più recente.
Il Campo da Calcio di Torre degli Ulivi
 Proseguendo per duecento metri dopo la piccola chiesa dedicata a Sant’Efisio, in località Su Spantu, vediamo alla sinistra della strada il Campo da Calcio di Torre degli Ulivi. Si tratta di un campo in terra battuta, che serve la popolazione delle realtà residenziali di Su Spantu Primo, Su Spantu Secondo, e Torre degli Ulivi. Viene gestito dalla parrocchia della Beata Vergine Maria Madre della chiesa, situata nella frazione La Maddalena, che viene utilizzato dalle squadre giovanili.
Proseguendo per duecento metri dopo la piccola chiesa dedicata a Sant’Efisio, in località Su Spantu, vediamo alla sinistra della strada il Campo da Calcio di Torre degli Ulivi. Si tratta di un campo in terra battuta, che serve la popolazione delle realtà residenziali di Su Spantu Primo, Su Spantu Secondo, e Torre degli Ulivi. Viene gestito dalla parrocchia della Beata Vergine Maria Madre della chiesa, situata nella frazione La Maddalena, che viene utilizzato dalle squadre giovanili.
La frazione La Maddalena con la chiesa parrocchiale e la spiaggia di Frutti d’Oro
Ripresa, dalla frazione Orti su loi, la SS195 Sulcitana, la seguiamo per settecento metri, passiamo una rotonda, e, dopo altri trecento metri, alla successiva rotonda, prendiamo a destra la via al Mare, che ci porta nella frazione La Maddalena (altezza metri 2, distanza in linea d’aria circa 7.3 chilometri sul livello del mare, abitanti circa 7.080).
 L’uscita che abbiamo preso per raggiungere la frazione La Maddalena ci porta all’insediamento turistico di Frutti d’Oro appositamente segnalato prima della rotatoria che ci ha portato alla frazione, e che, con la via al Mare, in pocopiù di settecento metri, ci porta alla spiaggia. Si tratta di un centro residenziale nato negli anni ’60 del Novecento, con scuole, la chiesa, la PAlestra comunale, i campi sportivi, la farmacia, il supermercato e l’edicola.
L’uscita che abbiamo preso per raggiungere la frazione La Maddalena ci porta all’insediamento turistico di Frutti d’Oro appositamente segnalato prima della rotatoria che ci ha portato alla frazione, e che, con la via al Mare, in pocopiù di settecento metri, ci porta alla spiaggia. Si tratta di un centro residenziale nato negli anni ’60 del Novecento, con scuole, la chiesa, la PAlestra comunale, i campi sportivi, la farmacia, il supermercato e l’edicola.  La Chiesa della Beata Vergine Maria Madre della chiesa è la parrocchiale inaugurata e consacrata nel 2002, che serve le realtà residenziali denominate Frutti d’Oro, Su Spantu 1, 2 e 3, e Torre degli Ulivi. La chiesa ha l’aspetto di una tenda, a ricordo del primo Santuario offerto al Signore nel deserto del Sinai. La forma semicircolare rappresenta, inoltre, l’abbraccio della comunità intorno all’altare, ed anche il tetto è parte del simbolismo, rimanendo relativamente basso sul presbiterio e prendendo un deciso slancio verticale sopra i fedeli. L’ampio presbiterio è quasi una piazza, con la forma di nave rievocante l’Arca di Noè e la barca di San Pietro. L’altare, isolato solo fisicamente, è stato scolpito in un unico blocco di calcare di oltre tre tonnellate ed ha il basamento costituito da una grande croce, attorno alla quale si impostano le lettere che formano la parola CRISTO.
La Chiesa della Beata Vergine Maria Madre della chiesa è la parrocchiale inaugurata e consacrata nel 2002, che serve le realtà residenziali denominate Frutti d’Oro, Su Spantu 1, 2 e 3, e Torre degli Ulivi. La chiesa ha l’aspetto di una tenda, a ricordo del primo Santuario offerto al Signore nel deserto del Sinai. La forma semicircolare rappresenta, inoltre, l’abbraccio della comunità intorno all’altare, ed anche il tetto è parte del simbolismo, rimanendo relativamente basso sul presbiterio e prendendo un deciso slancio verticale sopra i fedeli. L’ampio presbiterio è quasi una piazza, con la forma di nave rievocante l’Arca di Noè e la barca di San Pietro. L’altare, isolato solo fisicamente, è stato scolpito in un unico blocco di calcare di oltre tre tonnellate ed ha il basamento costituito da una grande croce, attorno alla quale si impostano le lettere che formano la parola CRISTO.
Il Campo da Calcio di Frutti d’Oro
 La SS195 Sulcitana, seguita per settecento metri, passata la prima rotonda, dopo altri trecento metri, alla successiva rotonda, prendiamo a destra la via al Mare. Dopo centocinquanta metri, alla successiva rotonda, prendiamo la prima uscita verso destra, poi, dopo una cinquantina di metri, a sinistra il viale degli albatros, che si dirige verso il mare come la via al Mare. Lo seguiamo per meno di trecento metri, e vediamo, alla sinistra della strada, il Campo da Calcio di Frutti d’Oro. Anche in questo caso, si tratta di un campo in terra battuta, che serve la popolazione della realtà residenziale di Frutti d’Oro. Viene gestito dalla parrocchia della Beata Vergine Maria Madre della chiesa, e viene utilizzato dalle squadre giovanili.
La SS195 Sulcitana, seguita per settecento metri, passata la prima rotonda, dopo altri trecento metri, alla successiva rotonda, prendiamo a destra la via al Mare. Dopo centocinquanta metri, alla successiva rotonda, prendiamo la prima uscita verso destra, poi, dopo una cinquantina di metri, a sinistra il viale degli albatros, che si dirige verso il mare come la via al Mare. Lo seguiamo per meno di trecento metri, e vediamo, alla sinistra della strada, il Campo da Calcio di Frutti d’Oro. Anche in questo caso, si tratta di un campo in terra battuta, che serve la popolazione della realtà residenziale di Frutti d’Oro. Viene gestito dalla parrocchia della Beata Vergine Maria Madre della chiesa, e viene utilizzato dalle squadre giovanili.
La spiaggia de La Maddalena
Procedendo sulla SS195 Sulcitana dalla deviazione per Frutti d’Oro, dopo un chilometro e duecento metri arriviamo alla rotonda di La Maddalena, con la deviazione sulla sinistra per la SP91 che ci porta nel paese chiamato Capoterra. Giriamo invece a destra, in direzione della spiaggia, appositamente segnalata, arrivando alla zona parcheggi, presso le evidenti insegne del noto ristorante Sa Cardiga e su Schironi.
A La Maddalena il ristorante Sa Cardiga e su Schironi suggerito dalla Guida Michelin ed al quale il Gambero Rosso ha assegnato le Due Forchette
alla rotonda di La Maddalena prendiamo a destra verso il mare, seguendo le indicazioni, andiamo ad effettuare una fermata quasi obbligatoria al ristorante Sa Cardiga e su Schironi consigliato dalla Guida Michelin 2023 ed al quale il Gambero Rosso ha assegnato le Due Forchette.
Proseguendo in direzione di Capoterra
Arrivati con la SS195 Sulcitana alla rotonda di La Maddalena, invece di dirigerci a destra verso il mare, prendiamo a sinistra, ed imbocchiamo la SP91 che, dopo cinque chilometri, ci porta all’interno del paese chiamata Capoterra. Dal Municipio di Sarroch a quello di Capoterra, evitando le deviazioni, si percorrono 15.2 chilometri.
Proseguendo verso la Città di Cagliari raggiungiamo il Comune chiamato Capoterra

 La SP91 ci porta a Capoterra (nome in lingua sarda Cabuderra, altezza metri 54 sul livello del mare, abitanti 23.172 al 31 dicembre 2021), un Comune della Città metropolitana di Cagliari, conurbato con il capoluogo. Si tratta di un paese chiamato origine medievale, che si estende nella parte sud orientale della Città metropolitana di Cagliari, sulla costa, al margine delle saline di Santa Gilla, di fronte al golfo degli Angeli, e dista una ventina di chilometri da Cagliari. Gli abitanti vivono per la maggior parte nel capoluogo comunale, la restante parte si distribuisce tra le frazioni diOrti su loi, La Maddalena e di Poggio dei Pini, nonche in numerose case sparse. È raggiungibile tramite la SS195 Sulcitana, che dista soli cinque chilometri dall’abitato. Il suo territorio, classificato di collina, si estende fino al mare, e presenta un profilo geometrico irregolare, con variazioni altimetriche molto accentuate.
La SP91 ci porta a Capoterra (nome in lingua sarda Cabuderra, altezza metri 54 sul livello del mare, abitanti 23.172 al 31 dicembre 2021), un Comune della Città metropolitana di Cagliari, conurbato con il capoluogo. Si tratta di un paese chiamato origine medievale, che si estende nella parte sud orientale della Città metropolitana di Cagliari, sulla costa, al margine delle saline di Santa Gilla, di fronte al golfo degli Angeli, e dista una ventina di chilometri da Cagliari. Gli abitanti vivono per la maggior parte nel capoluogo comunale, la restante parte si distribuisce tra le frazioni diOrti su loi, La Maddalena e di Poggio dei Pini, nonche in numerose case sparse. È raggiungibile tramite la SS195 Sulcitana, che dista soli cinque chilometri dall’abitato. Il suo territorio, classificato di collina, si estende fino al mare, e presenta un profilo geometrico irregolare, con variazioni altimetriche molto accentuate.
Origine del nome
L’antico nome dell’abitato, Cabuderra o Cabuterra, che deriva certamente dal latino Caput Terrae, risale all’epoca romana, e trova la sua giustificazione nella posizione dell’insediamento, che si trova vicino al mare e al vasto stagno di Cagliari.
La sua economia
Il Comune chiamato Capoterra è principalmente un paese agricolo e pastorale, che solo in tempi recenti sta sviluppando, grazie anche alla sua posizione geografica, anche il turismo. Il settore primario è presente con la coltivazione di cereali, frumento, ortaggi, foraggi, olivo, agrumi, uva e altra frutta, e in particolar modo lo sviluppo delle colture in serra, di fiori e ortaggi in generale. Presente anche l’allevamento di bovini, suini, ovini, caprini, equini e avicoli. Non mancano attività industriali, commerciali e artigianali. L’industria è costituita da imprese che operano nei comparti alimentare, dell’abbigliamento, della stampa, della plastica, dei materiali da costruzione, dei laterizi, metallurgico, della produzione e distribuzione di energia elettrica ed edile. Il terziario si compone di una modesta rete distributiva e dell’insieme dei servizi. Le strutture ricettive, che comprendono vari agriturismi, offrono possibilità di ristorazione e di soggiorno.
La tranquillità del luogo e le bellezze dell’ambiente naturale circostante, esercitano un forte richiamo su quanti amano il relax. Agli amanti della buona cucina, Capoterra offre la possibilità di assaporare i piatti tipici locali, come Sa Taccula, la prelibata corona di tordi o merli, che, una volta spennati e fiammeggiati, vengono posti in una pentola a cuocere con del mirto, successivamente restano racchiusi in uno straccio da cucina con le foglie di mirto per una giornata in frigo, e sono pronti per essere consumati.
Brevi cenni storici
Il territorio presenta antiche tracce del periodo nuragico, epoca alla quale risale l’officina litica ed il nuraghe, di cui non resta traccia, della zona di Cuccuru Ibba, altri ruderi di epoca nuragica sono stati ritrovati nelle colline attorno a Baccutinghinu, dove si trova il nuraghe di Monti Arrubiu, ed altre strutture relative a nuraghi si trovano nelle zone di Is Antiogus e Is Cuccureddus. All’epoca punica risale l’insediamento che è stato scoperto nella zona di Su loi. L’antico nome, Cabuderra o Cabuterra, deriva certamente dal latino Caput Terrae, risale, quindi, all’epoca romana. Nel periodo romano l’insediamento, considerato da alcuni studiosi un Oppidum, ossia una Città fortificata priva del confine sacro, proprio invece dell’Urbe, Era localizzato non distante dalla zona litoranea, in prossimità dello stagno di Cagliari, ed i ritrovamenti fanno pensare che l’abitato sorgesse nella località Tanca Sa Canna, tra Santa Vittoria e Mannu su Pezzu. Del periodo romano rinagono antiche sepolture e ricchi corredi, oltre ai resti di alcune costruzioni. In epoca giudicale Capoterra fa parte del Giudicato di Càralis, ed è una villa della curatoria di Nora. Nel 1107 venne donata, insieme ad altri territori, dal giudice Torchitorio, alla chiesa di San Lorenzo di Genova, ma nel 1120 ritorna a far parte del Giudicato di Càralis. Dopo la capitolazione di Santa Igia, il Giudicato di Càralis passa sotto il controllo di Pisa. Nel 1288, i Pisani, dopo la sconfitta navale della Meloria, firmano la pace con Genova, ma non la rispettano, il che costringe i Genovesi a reagire con azioni violente, fra le quali una di queste interessa anche la zona di Capoterra. In seguito il territorio e il villaggio di Capoterra passano, per motivi di matrimonio, sotto il controllo di Mariano II di Arborea. Nel 1323 inizia la conquista aragonese della Sardegna. I pisani scelgono il litorale di Capoterra per un massiccio sbarco di truppe contro l’offensiva militare dell’infante alfonso, unitosi alle truppe di Ugone II d’Arborea, ed il 26 febbraio 1324 gli oltre 1200 cavalieri, sbarcati nel porto di Maddalena, ingaggiano una cruenta battaglia con gli eserciti dell’infante alfonso nella zona di lucocisterna, ma i Pisani subiscono una dura sconfitta. Passata in mano agli Aragonesi, questi la cedono in signoria a Giovanni villana, il quale la vende al Giudicato di Arborea. In seguito ai contrasti tra il Re Pietro IV d’Aragona e il giudice Mariano IV d’Arborea, intorno all’anno 1353 Capoterra viene saccheggiata, incendiata e distrutta dagli uomini del capitano aragonese Berengario Carroz. Il villaggio rimane disabitato per oltre tre secoli. Il territorio disabitato di Capoterra viene ripopolato nel 1655 dal barone don Girolamo Torrellas d’Aragal e Cervellion, inizialmente abitato dai servi e dai familiari dello stesso barone. È un periodo non certo favorevole a causa dell’epidemia di peste che imperversa in Sardegna, ed il primo nucleo di case viene presto chiamato Villa Sant’Efisio, in ringraziamento al Santo che, invocato, libera la Città dalla terribile pestilenza. In breve il villaggio cresce e si ingrossa per l’arrivo di profughi da altri paesi, specie del Logudoro e della Gallura, per interessamento di don Girolamo, che vi trasferisce dal capo di Sopra diverse famiglie che sono sotto minaccia di sterminio per odi familiari. Capoterra, quindi, diviene un rifugio per chi ha pendenze con la giustizia minore, ed intende iniziare una nuova esistenza, tanto che lo storico Vittorio Angius scrive che Nel 1550 questa, come tutte le altre popolazioni del suddetto dipartimento, giaceva estinta, e giacque fino a che nel 1655 don Girolamo Aragall’e Cervellion ebbe conceduto certe buone condizioni ad alcuni uomini del Logudoro e della Gallura, che non s’ardivano ritornare nelle proprie case, ed esporvisi alla vendetta dei loro nemici. Gli ultimi feudatari che controllano Capoterra sono i Zapata. Capoterra cresce, come numero di abitanti ed economicamente, ed oggi è divenuto uno dei comuni della Sardegna che, negli ultimi dieci anni, ha avuto un incremento demografico tra i più alti dell’isola, oltre ad una vistosa trasformazione urbanistica. Nel 2016 viene cambiata la Provincia alla quale appartiene, passando dalla Provincia di Cagliari alla Città metropolitana di Cagliari.
A Capoterra è nato Sergio Atzeni uno tra i più grandi talenti letterari degli ultimi anni
A Capoterra è nato l’importante scrittore Sergio Atzeni, morto prematuramente a soli quarantatre anni, considerato tra i più grandi talenti letterari degli ultimi anni.
Le principali feste e sagre che si svolgono a Capoterra
A Capoterra sono attivi il Gruppo Folk Sa Scabizzada ed il Gruppo Folk Sant’Efisio, i cui componenti si esibiscono nelle principali feste e sagre che si svolgono nel Comune ed anche in altre località. Nelle loro esibizioni è possibile ammirare il costume tradizionale delle donne e degli uomini di Capoterra. È, inoltre, presente il coro polifonico Las Mamas, formato da sole mamme e nato per caso, nel 2008, dopo una recita scolastica dei loro figli. Tra le manifestazioni che si svolgono a Capoterra vanno citati, il 15 gennaio, la festa del Patrono Sant’Efisio, il Santo che la dato il nome al borgo di villa Sant’Efisio, che dal 2003 condivide il ruolo di patrono con Santa Barbara; la domenica di Pasqua la cerimonia di S’Incontru; il primo maggio la processione che accompagna il simulacro di Sant’Efisio da Cagliari a Nora, fa tappa nella piccola chiesa di Sant’Efisio a Su loi; l’ultima domenica di giugno o la prima di luglio, si celebra la festa di Santa Barbara, copatrona con Sant’Efisio; l’ultima domenica di settembre si svolge la festa di San Gerolamo presso l’omonima chiesa campestre; nel mese di ottobre anche a Capoterra si svolgono i festeggiamenti per San Francesco.
La domenica di Pasqua si celebra la cerimonia di S’Incontru
La domenica di Pasqua si svolge S’Incontru, ossia l’Incontro, che coinvolge l’intera popolazione, ripercorrendo l’evento Evangelico dell’annuncio della resurrezione alla Madonna. I simulacri, seguiti dai fedeli, s’incontrano al centro del paese e proseguono con la folla riunita in una sola processione, che cammina su un letto di petali e piante aromatiche. Il saluto tra il Figlio e la Madre viene celebrato con canti religiosi.
Le fermate della processione di Sant’Efisio sulla spiaggia de La Maddalena e nella frazione Orti su loi
 In questa spiaggia, il primo maggio, fa la sua seconda sosta la Processione di Sant’Efisio, lungo il suo tradizionale tragitto da Cagliari a Nora. Il pellegrinaggio arriva da Giorgino nel territorio del Comune di Capoterra a bordo del camion miltare, fino alla spiaggia de La Maddalena, trasferimento in camion che si è reso necessario in quanto, dopo la costruzione del porto canale, è stata interrotta la vecchia strada per Pula. Presso la spiaggia la processione fa una sosta, il cocchio di campagna viene scaricato dal carro militare, ed i fedeli che accorrono dalla vicina Capoterra, paese chiamato cui è patrono, possono porgli i loro omaggi. Poi la processione riparte, ed il pellegrinaggio prosegue riprendendo l’antico percorso sul cocchio trainato dai buoi, per recarsi nella piccola chiesa dedicata a Sant’Efisio in località Orti su loi.
In questa spiaggia, il primo maggio, fa la sua seconda sosta la Processione di Sant’Efisio, lungo il suo tradizionale tragitto da Cagliari a Nora. Il pellegrinaggio arriva da Giorgino nel territorio del Comune di Capoterra a bordo del camion miltare, fino alla spiaggia de La Maddalena, trasferimento in camion che si è reso necessario in quanto, dopo la costruzione del porto canale, è stata interrotta la vecchia strada per Pula. Presso la spiaggia la processione fa una sosta, il cocchio di campagna viene scaricato dal carro militare, ed i fedeli che accorrono dalla vicina Capoterra, paese chiamato cui è patrono, possono porgli i loro omaggi. Poi la processione riparte, ed il pellegrinaggio prosegue riprendendo l’antico percorso sul cocchio trainato dai buoi, per recarsi nella piccola chiesa dedicata a Sant’Efisio in località Orti su loi.
 Presso questa piccola chiesa, ogni anno, il primo maggio fa la sua terza sosta la Processione di Sant’Efisio, lungo il suo tradizionale tragitto che la porta da Cagliari a Nora. Vi arriva dalla spiaggia delLa Maddalena percorrendo la strada statale sino al raccordo con Frutti d’Oro, e compie una breve sosta per far riposare i buoi. Il simulacro di Efisio viene collocato all’interno della piccola chiesa gremita di devoti, e viene celebrata una messa all’aperto, con la benedizione eucaristica, nel piazzale antistante la piccola chiesa dedicata a Sant’Efisio. Poi la processione riparte, ed il pellegrinaggio prosegue sul cocchio trainato dai buoi, per recarsi nella Cappella della prestigiosa Villa d’Orrì, in teritorio di Selargius.
Presso questa piccola chiesa, ogni anno, il primo maggio fa la sua terza sosta la Processione di Sant’Efisio, lungo il suo tradizionale tragitto che la porta da Cagliari a Nora. Vi arriva dalla spiaggia delLa Maddalena percorrendo la strada statale sino al raccordo con Frutti d’Oro, e compie una breve sosta per far riposare i buoi. Il simulacro di Efisio viene collocato all’interno della piccola chiesa gremita di devoti, e viene celebrata una messa all’aperto, con la benedizione eucaristica, nel piazzale antistante la piccola chiesa dedicata a Sant’Efisio. Poi la processione riparte, ed il pellegrinaggio prosegue sul cocchio trainato dai buoi, per recarsi nella Cappella della prestigiosa Villa d’Orrì, in teritorio di Selargius.
Visita del centro di Capoterra
Il centro storico sorge in pianura, alle pendici del sistema montuoso del basso Sulcis, in prossimità del fiume Santa Lucia. L’abitato, interessato da un fenomeno di forte crescita edilizia, mostra un andamento plano altimetrico tipico delle località collinari.
Il Municipio di Capoterra
 Entriamo in Capoterra da sud est, provenendo dalla litoranea con la SP91, che, dopo poco più di cinquecento metri dal cartello segnaletico indicatore del paese all’interno dell’abitato, assume il nome di via Cagliari. Lo seguiamo per altri poco meno di cinquecento metri, ed, arrivati in corrisponenza di quello che era il civico numero 91, troviamo, alla sinistra della strada, la piazza Municipio. Qui si affaccia il grande edificio che ospita la sede del Municipio di Capoterra, con gli uffici destinati ad ospitare i servizi ai cittadini.
Entriamo in Capoterra da sud est, provenendo dalla litoranea con la SP91, che, dopo poco più di cinquecento metri dal cartello segnaletico indicatore del paese all’interno dell’abitato, assume il nome di via Cagliari. Lo seguiamo per altri poco meno di cinquecento metri, ed, arrivati in corrisponenza di quello che era il civico numero 91, troviamo, alla sinistra della strada, la piazza Municipio. Qui si affaccia il grande edificio che ospita la sede del Municipio di Capoterra, con gli uffici destinati ad ospitare i servizi ai cittadini.
Il campo di rugby di Capoterra
 Proseguendo per duecentocinquanta metri lungo la via Cagliari, arriviamo a un incrocio, dove arriva da sinistra la via Giuseppe Garibaldi, e parte a destra la via Trento. Prendiamo quest'ultima, e la seguiamo per 700 metri, fino a trovare, alla sinistra della strada, uno spiazzo con un ampio parcheggio, sulla quale si affaccia il Campo di rugby di Capoterra. Nel 2013 è stato deciso di dotarlo di una tribuna con mille posti a sedere, un impianto fotovoltaico, e si è decisa la sistemazione del manto erboso, per un centro sportivo degno della squadra che gioca in Serie A per due anni consecutivi, con circa Trecento tesserati di tutte l’età. Il paese chiamato Capoterra vanta, infatti, una tradizione rugbystica di tutto rispetto, e la sua società Amatori Rugby Capoterra milita nel campionato italiano di serie A, dove, nel campionato 2012-2013, si è classificata al quarto posto.
Proseguendo per duecentocinquanta metri lungo la via Cagliari, arriviamo a un incrocio, dove arriva da sinistra la via Giuseppe Garibaldi, e parte a destra la via Trento. Prendiamo quest'ultima, e la seguiamo per 700 metri, fino a trovare, alla sinistra della strada, uno spiazzo con un ampio parcheggio, sulla quale si affaccia il Campo di rugby di Capoterra. Nel 2013 è stato deciso di dotarlo di una tribuna con mille posti a sedere, un impianto fotovoltaico, e si è decisa la sistemazione del manto erboso, per un centro sportivo degno della squadra che gioca in Serie A per due anni consecutivi, con circa Trecento tesserati di tutte l’età. Il paese chiamato Capoterra vanta, infatti, una tradizione rugbystica di tutto rispetto, e la sua società Amatori Rugby Capoterra milita nel campionato italiano di serie A, dove, nel campionato 2012-2013, si è classificata al quarto posto.
L’antica casa Melis
Nel territorio comunale di Capoterra si trovano dei reperti storici di notevole rilievo culturale e artistico in stile liberty e tardo-gotico. Tra essi, ripendendo la via Cagliari, centocinquanta metri più avanti rispetto alla via Giuseppe Garibaldi ed alla via Trento, incrociamo il corso Antonio Gramsci, preso il quale verso destra, ossia verso nord, subito all’incrocio tra le due strade, si trova l’Antica casa Melis che si affaccia alla sinistra del corso. Si tratta di una casa campidanese che spicca per dignità architettonica e stato di conservazione, ed è stata costruita nel 1920 dal cavalier Giuseppe Melis. Progettata come dimora di un imprenditore agricolo, attorno a un ampio cortile interno, la casa Melis comprende un’ala residenziale divisa su due piani, e vasti spazi coperti un tempo adibiti a rimesse, stalle e magazzini. Donata dall’erede elio Melis al Comune e attentamente restaurata, essa costituisce oggi la sede di rappresentanza dell’amministrazione comunale e viene utilizzata come centro per manifestazioni culturali.
Qui, nell’antica casa Melis, nel febbraio 2007 è stato proiettato il film Caccia Grossa interamente girato a Capoterra nel 1980 dal regista lello di Palma, che è stato ospite alla prima proiezione.
La chiesa parrocchiale di Sant’Efisio
Dalla via Cagliari, preso il corso Antonio Gramsci verso sinistra, ossia verso sud, percorso meno di un centinaio di metri, si vede alla sinistra della strada la piazza chiesa, nella quale si trova la Chiesa di Sant’Efisio che è la chiesa parrocchiale di Capoterra, il paese che, con Cagliari, è l’unico centro sardo che possieda due Chiese dedicate a Sant’Efisio, la prima è questa parrocchiale nel centro storico, mentre la seconda è la Cappella stazionale di Su loi che abbiamo già descritta. La vecchia chiesa dedicata al patrono che era stata eretta, insieme al borgo di villa Sant’Efisio, alla metà del 1600, voluta dal barone don Girolamo Torrellas come Cappella privata. Nel 1838 il feudAlesimo viene abolito, per cui il barone di Capoterra, privato del suo antico potere sul paese, insiste per rientrare in possesso del locale, che in realtà era la sua Cappella privata. La nuova chiesa viene edificata su progetto dell’ingegner Francesco Immeroni tra il 1855 ed il 1858, in sostituzione della vecchia costruzione, della quale non si conservano tracce, come del resto di tutto il villaggio seicentesco. La chiesa ha una pianta a croce latina. Dal portone di ingresso, inserito in un prospetto a timpano, si accede alla navata centrale, alla quale si incrocia il transetto, e all’incrocio tra navata e transetto è presente una cupola crociata. Più avanti c’è il presbiterio, a forma di abside, al quale si addossano due cappelle laterali. Dalla Cappella laterale di destra si accede al campanile, con un pinnacolo di foggia tardogotica, sul quale svetta la croce.
A Capoterra il 15 gennaio si celebra la Festa di Sant’Efisio, il Santo patrono che ha dato il nome al borgo di villa Sant’Efisio, che dal 2003 condivide il ruolo di patrono con Santa Barbara
Il Cimitero di Capoterra
Proseguendo lungo il corso Antonio Gramsci per circa seicento metri, arrivati in località Corte Piscedda, troviamo alla sinistra della strada gli ingressi del Cimitero di Capoterra, un Cimitero grande nel quale è presente una Cappella cimiteriale.
Il parco urbano con l’Anfiteatro di Capoterra
Di fronte al Cimitero, alla destra della via Antonio Gramsci, tra la precedente via Palermo e la successiva via Corte Piscedda, si trova il Parco urbano di Capoterra, inaugurato nel 2013. Si tratta di una struttura avveniristica in stile moderno, progettata dall’iraniano Shahszad Ma Shayekhi, con lo scopo di creare un luogo di tranquillità e di aggregazione non solo per Capoterra ma anche per tutto il suo hinterland. All’interno è presente un verde parco con punto di ristoro, ed un Teatro all’aperto situato nell’Anfiteatro annesso al parco urbano.
La cittadella sportiva in localtà su Suergiu
 Prima di arrivare al Cimitero ed al parco urbano, dalla via Antonio Gramsci, in corrispondenza di dove da destra arriva la via Palermo, prendiamo verso sinistra la via Ferruccio Serafini, che ci porta in località Su Suergiu. La strada passa intorno e sul retro del Cimitero, e, percorsa per quasi trecento metri, ci porta alla Cittadella sportiva di su Suergiu che ospita diverse strutture sportive, che comprendono un Campo da Calcio, uno da Calcetto, e, sopratutto, in esso sono presenti due campi da Tennis, oltre alle strutture di supporto.
Prima di arrivare al Cimitero ed al parco urbano, dalla via Antonio Gramsci, in corrispondenza di dove da destra arriva la via Palermo, prendiamo verso sinistra la via Ferruccio Serafini, che ci porta in località Su Suergiu. La strada passa intorno e sul retro del Cimitero, e, percorsa per quasi trecento metri, ci porta alla Cittadella sportiva di su Suergiu che ospita diverse strutture sportive, che comprendono un Campo da Calcio, uno da Calcetto, e, sopratutto, in esso sono presenti due campi da Tennis, oltre alle strutture di supporto.
Il nuovo Palazzetto dello Sport
 Da dove la via Cagliari aveva incrociato il corso Antonio Gramsci, proseguiamo lungo essa per settecentocinquanta metri. Prendiamo a sinistra la via Siena, dopo circa duecento metri, alla sinistra della strada, al civico numero 42, troviamo il nuovo Palazzetto dello sport di Capoterra. Nel palazzetto sono presenti due tribune, un campo gioco per calcetto, basketà e volley, ed è presente anche una pAlestra, spogliatoi e bar. È in grado di ospitare 1.000 spettatori, ed ospita partite di calcetto, basketà e volley, oltre ad incontri di karate e di arti marziali. Il principale team di karate e di arti marziali di Capoterra è l’A.S.D Jissen-do karate Capoterra, che occupa la principale posizione in Sardegna per numero di vittorie, ed ha occupato varie volte il podio a livello nazionale.
Da dove la via Cagliari aveva incrociato il corso Antonio Gramsci, proseguiamo lungo essa per settecentocinquanta metri. Prendiamo a sinistra la via Siena, dopo circa duecento metri, alla sinistra della strada, al civico numero 42, troviamo il nuovo Palazzetto dello sport di Capoterra. Nel palazzetto sono presenti due tribune, un campo gioco per calcetto, basketà e volley, ed è presente anche una pAlestra, spogliatoi e bar. È in grado di ospitare 1.000 spettatori, ed ospita partite di calcetto, basketà e volley, oltre ad incontri di karate e di arti marziali. Il principale team di karate e di arti marziali di Capoterra è l’A.S.D Jissen-do karate Capoterra, che occupa la principale posizione in Sardegna per numero di vittorie, ed ha occupato varie volte il podio a livello nazionale.
La zona Santa Rosa con lo stadio comunale
 Circa duecento metri prima di prendere la via Siena, percorsa la via Cagliari per Cinquecentocinquanta metri dopo l’incrocio con il corso Antonio Gramsci, prendiamo a destra la via Belvedere, che, in centocinquanta metri, al civico numero 21, ci fa vedere alla sinistra della strada lo Stadio comunale di Capoterra, che si trova nalla località della lottizzazione Santa Rosa, alla periferia occidentale dell’abitato. Gli spazi di gioco compresi nell’impianto comprendono un Campo da Calcio ed una ppista d’atletica, ed è in grado di ospitare 1.000 spettatori. La principale squadra di calcio della Città è la S.S.C. Capoterra, che milita nel girone A sardo di Prima Categoria.
Circa duecento metri prima di prendere la via Siena, percorsa la via Cagliari per Cinquecentocinquanta metri dopo l’incrocio con il corso Antonio Gramsci, prendiamo a destra la via Belvedere, che, in centocinquanta metri, al civico numero 21, ci fa vedere alla sinistra della strada lo Stadio comunale di Capoterra, che si trova nalla località della lottizzazione Santa Rosa, alla periferia occidentale dell’abitato. Gli spazi di gioco compresi nell’impianto comprendono un Campo da Calcio ed una ppista d’atletica, ed è in grado di ospitare 1.000 spettatori. La principale squadra di calcio della Città è la S.S.C. Capoterra, che milita nel girone A sardo di Prima Categoria.
La piscina comunale
 Dalla via Cagliari, dopo l’incrocio con il corso Antonio Gramsci, proseguiamo per una cinquantina di metri e prendiamo a destra la via Vittorio Emanuele, dopo centocinquanta metri a sinistra la via Cristoforo Colombo, che continua sulla via Amendola. Dopo poco più di trecento metri, prendiamo a destra la via Piemonte, dopo centocinquanta metri continuiamo leggermente verso destra sulla via lombardia, la seguiamo per duecento metri. Poi la strada compie una svolta a sinistra, e, dopo un’ottantina di metri, vediamo alla sinistra della strada la Piscina comunale di Capoterra. Le sue tribune sono in grado di ospitare 150 spettatori.
Dalla via Cagliari, dopo l’incrocio con il corso Antonio Gramsci, proseguiamo per una cinquantina di metri e prendiamo a destra la via Vittorio Emanuele, dopo centocinquanta metri a sinistra la via Cristoforo Colombo, che continua sulla via Amendola. Dopo poco più di trecento metri, prendiamo a destra la via Piemonte, dopo centocinquanta metri continuiamo leggermente verso destra sulla via lombardia, la seguiamo per duecento metri. Poi la strada compie una svolta a sinistra, e, dopo un’ottantina di metri, vediamo alla sinistra della strada la Piscina comunale di Capoterra. Le sue tribune sono in grado di ospitare 150 spettatori.
Visita dei dintorni di Capoterra
Vediamo ora che cosa si trova di più sigificativo nei dintorni dell’abitato che abbiamo appena descritto. Per quanto riguarda le principali ricerche archeologiche effettuate nei dintorni di Capoterra, sono stati portati alla luce i resti del nuraghei semplice Poggio Antonio Murgia; del nuraghe complesso Baccu Tinghinu; del nuraghe Mont'Arbu di tipologia indefinita; mentre non resta più nulla del nuraghe Sa Cruxi Santa, che è stato completamente demolito. Vediamo, ora, che cosa d’altro si trova nei dintorni di Capoterra, oltre alla sua zona costiera, che abbiamo già visto nell’itinerario che ci ha portati da Sarroch a Capoterra.
La chiesa di San Gerolamo de la Murta
Partendo dal Cimitero di Capoterra in direzione sud ovest, verso la frazione Poggio dei Pini, si trova un cartello, dopo un chilometro e seicento metri, che indica una stradina sulla destra. La percorriamo per ottocento metri, poi, seguendo le indicazioni, prendiamo a sinistra, e, dopo quattrocento metri quasi tutti di strada bianca, arriviamo alla Chiesa campestre di San Girolamo de la Murta. Nel 1565 l’arcivescovo di Cagliari, su richiesta del beneficiato della Cattedrale di Cagliari Sisinnio Murro, fa dono a lui e all’eremita frate Francisco Boy, della Chiesa di San Girolamo detta de la Murta, sita nel territorio di Capoterra, che è un eremitaggio attualmente abbandonato, lontano dai centri abitati e conveniente alle intenzioni, agli auspici e ai desideri del detto frate Francisco Boy, affinche entrambi possano Condurvi una vita solitaria e contemplativa. Ma la chiesa, con una vicina sorgente, luogo ideale per una vita di penitenza e contemplazione, doveva essere molto più antica, probabilmente costruita su un preesistente edificio di epoca bizantina. L’iscrizione murata sulla facciata di una casa vicina alla chiesa, attesta la presenza, tra il 1615 ed il 1628, dell’eremita Francisco de Quentia, che godeva di fama di Santità, e che, nel 1620, con le offerte ricavate, realizza una piccola campana. L’impianto attuale della chiesa risale al diciassettesimo secolo, ha linee esterne molto semplici, con un piccolo oculo che si apre sulla facciata, provvista di un campanile a vela in mattoni, che ospita la piccola campana. Nel 1893, l’edificio, che si trovava in stato di totale abbandono adibito ad ovile, viene restaurato e riportato in attività, e l’ultimo restauro del 1994, ha rifatto il pavimento ed il soffitto, crollato in seguito alle forti piogge del 1991. L’unica aula, con copertura lignea, contiene una bella acquasantiera del diciassettesimo secolo, ed una pala d’altare in legno intagliato e dipinto, attribuita al pittore algherese Francesco Pinna, morto a Cagliari nel 1616, considerato il maggiore esponente del tardo manierismo in Sardegna. Si tratta della decima opera finora conosciuta di questo importante artista, a cui l’attribuzione è stata effettuata nel 2003.
L’istituzione della festa di San Gerolamo è recente, e la sua celebrazione si svolge, presso questa chiesa campestre, l’ultima domenica di settembre.
Il Santuario di Santa Barbara de Montes
Partendo dal Cimitero di Capoterra in direzione della frazione Poggio dei Pini, passato il cartello, dopo un chilometro e seicento metri, per la chiesa di San Gerolamo de la Murta, proseguiamo per un altro chilometro sulla strada che viene chiamata 52. Prendiamo a destra la strada 51, dopo cinquecento metri svoltiamo a destra sulla strada 56, dopo altri trecento metri di nuovo a destra sulla strada 62, dopo cento metri a sinistra la strada 59, dopo duecento metri a sinistra la strada 60, dalla quale, dopo cento metri, parte sulla destra la Strada Vicinale di Santa Barbara. In circa un chilometro e duecento metri, arriviamo al borgo storico di Santa Barbara, sulla cui piazza si affacciano varie case, in parte restaurate.
Nel villaggio si trova il Santuario di Santa Barbara de Montes, costruito in stile tardo romanico nel luogo in cui era nato l’antico borgo medioevale che ha dato origine all’attuale centro abitato, e dietro di esso si trova la bellissima villa Devoto. Il Santuario è stato edificato nel 1281 dal futuro arcivescovo Gallo, che è vissuto in eremitaggio in questo luogo. La soglia originaria era rialzata di cinquanta centimetri per evitare allagamenti in caso di pioggia, ed anticamente una scalinata, ormai scomparsa, portava all’ingresso, oggi murato. L’attuale accesso si apre sul fianco sinistro, decorato e con trentacinque cavità circolari per le coppelle ceramiche, che abbellivano e coloravano le murature. Alla fine del sedicesimo secolo la chiesa viene concessa ai frati Minori Conventuali, che la curano fino al 1867. Essi, lungo il fianco settentrionale e davanti, realizzano un porticato con ampie arcate in mattoni, che sorreggevano una copertura lignea, utilizzato come ricovero dei pellegrini. Nel 1739, come ricorda un’epigrafe, viene demolito un ampio tratto della fiancata meridionale, per la realizzazione di una grande Cappella cupolata, nella quale viene collocato il nuovo altare maggiore, e viene spostato il campanile a vela, sopra il loggiato del fianco settentrionale. L’aula, a una sola navata con copertura lignea, è scarsamente illuminata, dato che la monofora che si apriva sulla facciata è stata murata. L’altare maggiore, in stile barocco, è stato realizzato tra il 1739 ed il 1804. La statua della titolare è datata tra la fine del Settecento e gli inizi dell’Ottocento. Lungo le pareti interne vi sono dei sedili in muratura, interrotti dall’altare minore, del 1861. La chiesa, abbandonata con il decadimento del borgo, ha subito un importante recupero nel 1986, con il rifacimento completo del tetto.
La chiesa viene definita un Santuario, ossia un luogo ritenuto sacro dalla tradizione religiosa, per la devozione dei fedeli alla sorgente dove sarebbe stata decapitata la Santa. Racconta la leggenda che Santa Barbara fosse una nobile cagliaritana convertita, che durante le persecuzioni sarebbe stata decapitata verso la fine del terzo secolo nel luogo dove sorge il Santuario, e la sua testa sarebbe caduta nel punto dove ora sgorga la sorgente Sa Scabizzada, che si trova a soli cinquanta metri dalla chiesa, ed è racchiusa all’interno di una Cappella costruitale attorno. I fedeli che si recano al Santuario, prima di bere alla fonte, usano deporre una croce composta da due rami di legno, nei pressi della struttura.
La sera del primo venerdì di luglio, per la Festa di Santa Barbara, compatrona con Sant’Efisio, dopo la messa in parrocchia, il simulacro della Santa viene portato alla sua piccola chiesa. Il sabato viene celebrata una messa solenne ed in serata la statua è riportata in parrocchia. La domenica, una solenne processione attraversa le vie cittadine a conclusione dei riti. In questa festa si può assaporare il tipico gusto della sagra paesana in cui la festa religiosa è occasione di divertimento popolare.
La frazione Poggio dei Pini con la chiesa parrocchiale di Nostra Signora di lourdes
Dove termina la strada 52, prendiamo, questa volta verso sinistra, la strada 51, la seguiamo per Cinquecentocinquanta metri, poi a sinistra la strada 26 che seguiamo per duecento metri, e, di nuovo a sinistra, la strada 24 ci porta nella frazione Poggio dei Pini (altezza metri 64, distanza in linea d’aria circa 4.7 chilometri sul livello del mare, abitanti circa 2.307). La frazione è stata creata negli anni ’60 del Novecento, ma già da prima erano presenti varie abitazioni, dagli inizi delle due guerre mondiali, quando i cittadini andavano a rifugiarsi nei bunker a tale scopo nella zona predisposti.
 Percorsa per Cinquecentocinquanta meetri la strada 51, invece di prendere a sinistra la strada 26, prendiamo a destra la strada 51, la seguiamo per duecento metri, poi svoltiamo a sinistra e imbocchiamo la via Santa Bernadette Soubirous, che in trecentocinquanta metri ci porta di fronte alla Chiesa di Nostra Signora di lourdes che è la parrocchiale della frazione Poggio dei Pini. Inaugurata nel 1985, è realizzata con la pietra ed il cemento, materiali che conferiscono modernità, originalità e nel contempo tradizione, secondo un progetto elaborato su basi strettamente teologiche e simboliche. Il progetto si è rifatto all’Anastatis, ovvero alla Basilica circolare voluta dall’Imperatore Costantino in ricordo della resurrezione di Gesù Cristo, con un deambulatorio anulare individuato da una fila di dodici pilastri, cupola troncoconica a tino rovesciato, e quattro cappelle laterali a forma di croce. L’altare, posto al centro dal cerchio dei pilastri che sorreggendo la volta, richiama i segni dello Zodiaco. Il porticato esterno, infine, raffigura due braccia protese nell’accoglienza fraterna della comunità.
Percorsa per Cinquecentocinquanta meetri la strada 51, invece di prendere a sinistra la strada 26, prendiamo a destra la strada 51, la seguiamo per duecento metri, poi svoltiamo a sinistra e imbocchiamo la via Santa Bernadette Soubirous, che in trecentocinquanta metri ci porta di fronte alla Chiesa di Nostra Signora di lourdes che è la parrocchiale della frazione Poggio dei Pini. Inaugurata nel 1985, è realizzata con la pietra ed il cemento, materiali che conferiscono modernità, originalità e nel contempo tradizione, secondo un progetto elaborato su basi strettamente teologiche e simboliche. Il progetto si è rifatto all’Anastatis, ovvero alla Basilica circolare voluta dall’Imperatore Costantino in ricordo della resurrezione di Gesù Cristo, con un deambulatorio anulare individuato da una fila di dodici pilastri, cupola troncoconica a tino rovesciato, e quattro cappelle laterali a forma di croce. L’altare, posto al centro dal cerchio dei pilastri che sorreggendo la volta, richiama i segni dello Zodiaco. Il porticato esterno, infine, raffigura due braccia protese nell’accoglienza fraterna della comunità.
La prossima tappa del nostro viaggio
Nella prossima tappa del nostro viaggio, passata l’area umida di Santa Gilla arriviamo alla Città di Cagliari La principale Città della Sardegna di cui è capoluogo di Provincia ed anche il capoluogo della Regione.della Città descriveremo la storia e le principali caratteristiche, prima di recarci a visitare il suo centro storico medioevale.
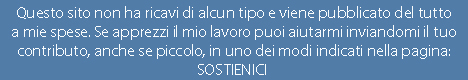
Tutte le foto e riprese sono state effettuate a scopo amatoriale per uso personale senza fini di lucro. Alle nostre foto se ne aggiungono altre inviateci da amici ed alcune tratte da Internet. Alcune informazioni sulle descrizioni dei comuni sono tratte da italiapedia.it, molte descrizioni e foto da wikimapia.org, informazioni sui siti archeologici da tharros.info, descrizoni e foto di chiese da chieseitaliane.chiesacattolica.it, foto di impianti sportivi da sardegnasport.it, altre da siti differenti. È consentito scaricare testi, foto e riprese dell’autore per uso privato senza eliminare i riferimenti. Libri e filmati sono riprodotti per farli conoscere ma non è consentita la riproduzione delle foto di terzi, dei libri, dei filmati e di altro materiale non realizzato dall’autore. È vietato qualsiasi utilizzo commerciale del materiale in assenza di apposita autorizzazione. |
© Claudio de Tisi 2002-2025 - Codice Fiscale DTSCLD44M23F132W



















































