Un sito di oltre 480 pagine che descrive tutta l’Isola e che pur non vendendo nulla riceve fino a oltre un migliaio di visitatori ogni giorno


Serdiana nota per la sua produzione vinicola con nei dintorni il Santuario di Santa Maria di Sibìola
In questa tappa del nostro viaggio, da Donorì ci recheremo a Serdiana paese noto per la sua produzione vinicola, nei cui dintorni si trova la belil Santuario di Santa Maria di Sibìola.
La regione storica del Parteòlla
 A pochi chilometri da Cagliari si sviluppa il territorio del Parteòlla (nome in lingua sarda Partiolla) è una regione confinante con il Campidano, il Sarrabus e il Gerrei. Il Parteòlla è interamente compreso nella Provincia del Sud Sardegna e comprende i comuni: Dolianova, donori, Serdiana, Ussana. Il comune di Soleminis si trova tra il Campidano di Cagliari e il Parteòlla, per cui può appartenere all’una o all’altra di queste regioni, e noi preferiamo attribuirlo alla prima. È un territorio caratterizzato dal una grande varietà del paesaggio, come racconta lo storico sardo Giovanni Fara, che lo descrive in parte montuoso, in parte pianeggiante e coltivato, irrigato da brevi corsi d’acqua. Nel Parteòlla sono praticate l’agricoltura e la pastorizia, e sono particolarmente diffuse le produzioni di olii, vini e formaggi.
A pochi chilometri da Cagliari si sviluppa il territorio del Parteòlla (nome in lingua sarda Partiolla) è una regione confinante con il Campidano, il Sarrabus e il Gerrei. Il Parteòlla è interamente compreso nella Provincia del Sud Sardegna e comprende i comuni: Dolianova, donori, Serdiana, Ussana. Il comune di Soleminis si trova tra il Campidano di Cagliari e il Parteòlla, per cui può appartenere all’una o all’altra di queste regioni, e noi preferiamo attribuirlo alla prima. È un territorio caratterizzato dal una grande varietà del paesaggio, come racconta lo storico sardo Giovanni Fara, che lo descrive in parte montuoso, in parte pianeggiante e coltivato, irrigato da brevi corsi d’acqua. Nel Parteòlla sono praticate l’agricoltura e la pastorizia, e sono particolarmente diffuse le produzioni di olii, vini e formaggi.
In viaggio verso Serdiana
Dal centro di Donorì prendiamo la via Roma, la seguiamo per trecento metri fino a che la strada va ad immettersi sulla via Vittorio Emanuele, la prendiamo verso sinistra fino a che diventa il viale Europa ed esce dall’abitato andando ad immettersi sulla SS387 del Gerrei, la quale, dopo circa sei chilometri, ci porta all’interno dell’abitato di Serdiana. Dal Municipio di Donorì a quello di Serdiana si percorrono esattamente 9.0 chilometri.
A Serdiana saremmo potuti arrivare direttamente da Ussana, evitando la deviazione verso nord che ci aveva portati a Donorì. Dal centro di Serdiana prendiamo verso est la via Roma, che ci porta sulla SS466 di Sibìola, la prendiamo verso sinistra e, in circa sette chilometri, ci porta all’interno dell’abitato di Serdiana. Dal Municipio di Ussana a quello di Serdiana si percorrono 8.3 chilometri.
Il comune chiamato Serdiana

 Il comune di Serdiana (altezza metri 171 sul livello del mare, abitanti 2.647 al 31 dicembre 2021) è un centro di pianura di origine nuragica, che alle tradizionali attività agricole ha affiancato modeste iniziative industriali. Il borgo agricolo è dedito da secoli all’agricoltura e circondato da campi coltivati a vigneti e uliveti. Il paese è raggiungibile con la SS387 del Gerrei e con la SS466 di Sibìola, che portano all’interno dell’abitato. La Stazione ferroviaria di riferimento, intestata a Dolianova e Serdiana, si trova subito ad est dell’abitato, ma già in territorio di Dolianova. Il territorio comunale presenta un profilo geometrico irregolare, con variazioni altimetriche molto accentuate, dato che si raggiungono i 582 metri di quota.
Il comune di Serdiana (altezza metri 171 sul livello del mare, abitanti 2.647 al 31 dicembre 2021) è un centro di pianura di origine nuragica, che alle tradizionali attività agricole ha affiancato modeste iniziative industriali. Il borgo agricolo è dedito da secoli all’agricoltura e circondato da campi coltivati a vigneti e uliveti. Il paese è raggiungibile con la SS387 del Gerrei e con la SS466 di Sibìola, che portano all’interno dell’abitato. La Stazione ferroviaria di riferimento, intestata a Dolianova e Serdiana, si trova subito ad est dell’abitato, ma già in territorio di Dolianova. Il territorio comunale presenta un profilo geometrico irregolare, con variazioni altimetriche molto accentuate, dato che si raggiungono i 582 metri di quota.
Il comune fa parte dell’Associazione nazionale delle Città del Vino e delle città della Terra Cruda
 Questo paese fa parte della Associazione nazionale Città del Vino, il cui obiettivo è quello di aiutare i Comuni a sviluppare intorno al vino, ai prodotti locali ed enogastronomici, tutte quelle attività e quei progetti che permettono una migliore qualità della vita, uno sviluppo sostenibile, più opportunità di lavoro. Le Città del Vino in Sardegna sono ad oggi Alghero, Ardauli, Arzachena, Atzara, Badesi, Benetutti, Berchidda, Bonnanaro, Bono, Bosa, Calangianus, Dolianova, Donori, Dorgali, Galtellì, Jerzu, Loceri, Lotzorai, Luogosanto, Luras, Meana Sardo, Modolo, Monti, Neoneli, Olbia, Oliena, Riola Sardo, Samugheo, San Nicolò di Arcidano, Sant’Antioco, Selargius, Sennori, Serdiana, Sorgono, Sorso, Tempio Pausania, Terralba, Tissi, Uri, Urzulei, Usini.
Questo paese fa parte della Associazione nazionale Città del Vino, il cui obiettivo è quello di aiutare i Comuni a sviluppare intorno al vino, ai prodotti locali ed enogastronomici, tutte quelle attività e quei progetti che permettono una migliore qualità della vita, uno sviluppo sostenibile, più opportunità di lavoro. Le Città del Vino in Sardegna sono ad oggi Alghero, Ardauli, Arzachena, Atzara, Badesi, Benetutti, Berchidda, Bonnanaro, Bono, Bosa, Calangianus, Dolianova, Donori, Dorgali, Galtellì, Jerzu, Loceri, Lotzorai, Luogosanto, Luras, Meana Sardo, Modolo, Monti, Neoneli, Olbia, Oliena, Riola Sardo, Samugheo, San Nicolò di Arcidano, Sant’Antioco, Selargius, Sennori, Serdiana, Sorgono, Sorso, Tempio Pausania, Terralba, Tissi, Uri, Urzulei, Usini.
 Questo paese fa parte della Associazione nazionale delle città della Terra Cruda, nata per promuovere il recupero delle tradizioni e del patrimonio edilizio, naturalistico, artistico e storico delle comunità. Questa associazione comprende, in Sardegna, i comuni di Decimoputzu, donori, Fluminimaggiore, Furtei, Gonnosfanadiga, Guspini, Musei, Nuraminis, Pabillonis, Samassi, Samatzai, San Gavino Monreale, San Sperate, Sardara, Segariu, Selargius, Serramanna, Serrenti, Settimo San Pietro, Solarussa, Soleminis, Ussana, Ussaramanna, Vallermosa, Villa San Pietro, Villacidro, Villamassargia, Villasor.
Questo paese fa parte della Associazione nazionale delle città della Terra Cruda, nata per promuovere il recupero delle tradizioni e del patrimonio edilizio, naturalistico, artistico e storico delle comunità. Questa associazione comprende, in Sardegna, i comuni di Decimoputzu, donori, Fluminimaggiore, Furtei, Gonnosfanadiga, Guspini, Musei, Nuraminis, Pabillonis, Samassi, Samatzai, San Gavino Monreale, San Sperate, Sardara, Segariu, Selargius, Serramanna, Serrenti, Settimo San Pietro, Solarussa, Soleminis, Ussana, Ussaramanna, Vallermosa, Villa San Pietro, Villacidro, Villamassargia, Villasor.
Origine del nome
Il nome non ha chiara origine, ed appartiene verosimilmente allo strato linguistico paleosardo. Secondo il linguista Massimo Pittau, il nome di questo villaggio sarebbe carico di importanti notazioni storiche relative alla Sardegna antica, essendo corradicale con gli altri nomi come Sardara, Sardegna, Sardòri, e corrispondendo in maniera sorprendente al nome della Sardiane, regione che traeva la sua denominazione dalla città di Sárdeis, capitale della lidia, nell’Asia Minore, terra di origine dei Sardi, oltrechché degli Etruschi. Quindi la denominazione di Serdiana serviva a indicare la diversità dei nuovi arrivati rispetto ai gruppi umani precedenti che vivevano ancora in quelle zone. Ma c'è di più, dato che la grande dea Artemide, conosciuta in epoca antica in tutto il mondo mediterraneo, era quasi certamente originaria della lidia, come dimostra anche il fatto che essa era venerata sia ad Efeso come Artemide Efesia, sia a Sárdeis come Artemide sardiana, è molto probabile che i Sardiani o Protosardi, subito dopo il loro arrivo dalla lidia in Sardegna, abbiano fondato un centro denominato Arsemine ossia Asschémini in onore di Artemide Efesia, e un centro denominato Serdiana in onore di Artemide sardiana.
La sua economia
Si tratta di un comune di pianura che, alle tradizionali attività agricole, ha affiancato modeste iniziative industriali. Il settore economico primario è presente con la coltivazione di cereali, frumento, ortaggi, foraggi, vite, olivo, agrumi e frutta. Serdiana è soprattutto noto per la produzione vinicola e per le sue specialità enogastronomiche, e molto importanti sono le sue cantine Argiolas e le sue cantile Pala Vini di Sardegna, famose in tutto il mondo per i loro vini. Il settore primario è presenta anche con l’allevamento di bovini, suini, ovini, caprini ed equini. Il settore secondario è costituito da piccole imprese che operano nei comparti alimentare, dell’estrazione, chimico, dei materiali da costruzione ed edile. Il terziario non assume dimensioni rilevanti. Sebbene non rappresenti una meta particolarmente ambita dal turismo, non è del tutto priva di attrattive, la presenza dell’omonimo stagno, infatti, costituisce un buon motivo di richiamo per quanti amano l’ambiente naturale, con la possibilità di ammirare, nei mesi invernali, i fenicotteri rosa. Le strutture ricettive offrono possibilità di ristorazione ma non di soggiorno.
Brevi cenni storici
Da varie testimonianze archeologiche risulta che la zona viene abitata sino dall’epoca neolitica, come risulta dal ritrovamento di rudimentali lisciatoi, pestelli litici, asce silicee, punte di freccia, schegge di ossidiana e cocci di terracotta. Del periodo nuragico abbiamo solo tracce di quelle che un tempo dovevano essere monumentali strutture; basi nuragiche e segni di insediamento. Al periodo nuragico seguono gli insediamenti fenici e punici, testimoniati dal ritrovamento di vari oggetti punici, come orecchini d’argento, monete, sacche adibite alla conservazione di derrate alimentari; ma la scoperta più importante è costituita da una stele raffigurante il simbolo della dea cartaginese Tanit, trovata nel 1992 in zona Campu Braxiu. Alla dominazione punica succede quella romana, dato che, nel territorio circostante Serdiana, sono stati rinvenuti numerosi reperti quali frammenti ceramici, alcune tombe e si pensa che in questo periodo sia nata Serdiana. Alla presenza romana seguè l’occupazione dei Vandali, che deportano in Sardegna numerosi esuli Cristiani e monaci, la cui presenza aumenta con la dominazione bizantina. Nel Medioevo fa parte del Giudicato di Càralis, nella curatoria di Dolia o Parte Olla. Al 1125 risale la costruzione della chiesa di Santa Maria di Sibìola, quando nel territorio si insediano i monaci vittorini. Nel 1257, dopo la sconfitta del Giudicato di Càralis, passa per breve tempo al Giudicato di Arborea, e dal 1297 alla Repubblica di Pisa, per passare infine nel 1323 sotto il dominio aragonese. Nel 1328, Serdiana viene concessa in feudo, insieme ad altri villaggi, a Clemente Salavert. Nel 1358 la signoria passa ai Mont Pavon, al quale gli abitanti versavano una quota corrispondente alla tassa versata in precedenza al comune di Pisa. In quel periodo Serdiana si spopola completamente a causa della peste, delle carestie e delle guerre. Tra il 1440 e il 1540 si avvicendano diverse famiglie di feudatari. Intorno al 1648 la Sardegna è colpita da siccità e invasione di cavallette, situazione che peggiora ulteriormente con la peste. A Serdiana, si pensa sia stata terminata in questo periodo la costruzione della chiesa di San Salvatore, in particolare la Cappella del rosario, dove si pregava per la fine delle calamità. Inoltre si pensa che in questo periodo sia nata l’usanza del pellegrinaggio della statua di Santa Maria, da Serdiana alla piccola chiesa di Sibìola. Nel 1728, in epoca sabauda, il paese viene incorporato nel Marchesato di San Saverio, e nel 1839 viene riscattato ai Brunengo, ultimi feudatari, con la soppressione del sistema feudale, per cui diviene un comune amministrato da un sindaco e da un consiglio comunale e resta nella Provincia di Cagliari fino alla riforma del 2016, quando il paese viene aggregato alla nuova Provincia del Sud Sardegna.
Principali personaggi nati a Serdiana
A Serdiana sono nati due mosignori, vescovi di Sarrari, che sono stati Agostino Saba a Paolo Carta.
Le principali feste e sagre che si svolgono a Serdiana
 A Serdiana è attiva l’Associazione Folcloristica Santa Maria di Sibìola di Serdiana, nelle cui esibizioni sia nel paese che in altre località è possibile ammirare il costume tradizionale locale. Tra le principali feste e sagre che si svolgono a Serdiana vanno citate, il 20 gennaio, la Festa di San Sebastiano, con l’accensione la sera della vigilia del falò, Su fogadoni, con riferimento non solo al martirio del Santo e ad un simbolo di purificazione, ma anche con un significato legato al mito agrario, dato che dovrebbe propiziare la fecondità della terra e il perpetuarsi della vita; il 2 febbraio, la Festa della Candelora, che celebra la presentazione di Gesù al tempio, durante la quale si benedicono le candele, simbolo di Cristo; la seconda domenica di maggio, la Festa patronale del Santissimo Salvatore, cui segue il lunedì la Festa di Sant’Efisio Martire; la domenica successiva la Festa di Sant’Isidoro patrono degli agricoltori; a fine maggio, la manifestazione Cantine Aperte; la seconda domenica di agosto, si svolge l’evento Calici di stelle, che accoglie con vini d’eccellenza, musica e arte migliaia di visitatori nelle strade del centro storico animate da artigiani, artisti ed espositori; sempre ad agosto, si svolge l’Estate Serdianese, con concerti, manifestazioni cinematografiche e teatrali, spettacoli ed intrattenimento all’aperto nel centro di aggregazione sociale; preceduta da un triduo di preparazione, l’8 settembre si svolge la Festa di Santa Maria Sibìola, a cui i serdianesi sono molto devoti, che si svolge con una toccante cerimonia con la quale la statua della Santa viene condotta in processione fino alla piccola chiesa campestre in cui vengono celebrati i riti sacri, alla quale segue il 9 settembre, la Festa di San Raffaele Arcangelo; nella prima metà di novembre, la Sagra di Santu Sarbadoreddu, che è la seconda festa patronale dedicata al Santissimo Salvatore.
A Serdiana è attiva l’Associazione Folcloristica Santa Maria di Sibìola di Serdiana, nelle cui esibizioni sia nel paese che in altre località è possibile ammirare il costume tradizionale locale. Tra le principali feste e sagre che si svolgono a Serdiana vanno citate, il 20 gennaio, la Festa di San Sebastiano, con l’accensione la sera della vigilia del falò, Su fogadoni, con riferimento non solo al martirio del Santo e ad un simbolo di purificazione, ma anche con un significato legato al mito agrario, dato che dovrebbe propiziare la fecondità della terra e il perpetuarsi della vita; il 2 febbraio, la Festa della Candelora, che celebra la presentazione di Gesù al tempio, durante la quale si benedicono le candele, simbolo di Cristo; la seconda domenica di maggio, la Festa patronale del Santissimo Salvatore, cui segue il lunedì la Festa di Sant’Efisio Martire; la domenica successiva la Festa di Sant’Isidoro patrono degli agricoltori; a fine maggio, la manifestazione Cantine Aperte; la seconda domenica di agosto, si svolge l’evento Calici di stelle, che accoglie con vini d’eccellenza, musica e arte migliaia di visitatori nelle strade del centro storico animate da artigiani, artisti ed espositori; sempre ad agosto, si svolge l’Estate Serdianese, con concerti, manifestazioni cinematografiche e teatrali, spettacoli ed intrattenimento all’aperto nel centro di aggregazione sociale; preceduta da un triduo di preparazione, l’8 settembre si svolge la Festa di Santa Maria Sibìola, a cui i serdianesi sono molto devoti, che si svolge con una toccante cerimonia con la quale la statua della Santa viene condotta in processione fino alla piccola chiesa campestre in cui vengono celebrati i riti sacri, alla quale segue il 9 settembre, la Festa di San Raffaele Arcangelo; nella prima metà di novembre, la Sagra di Santu Sarbadoreddu, che è la seconda festa patronale dedicata al Santissimo Salvatore.
Visita del centro di Serdiana
L’abitato di Serdiana, interessato da un fenomeno di forte crescita edilizia, mostra l’andamento altimetrico tipico delle località pianeggianti. La SS387 del Gerrei arriva da nord a una rotonda, e subito arriva alla rotonda da nord ovest la SS466 di Sibìola, la successiva prima uscita dalla rotonda è la prosecuzione verso sud della SS387 del Gerrei, mentre la seconda uscita è il viale della Repubblica, che porta all’interno dell’abitato di Serdiana.
In piazza Gruxi ’e ferru si trova la Biblioteca comunale intitolata ad Agostino Saba
 Dalla rotonda alla quale sono arrivate la SS387 del Gerrei e la SS466 di Sibìola, prendiamo il viale della Repubblica e lo seguiamo per seicento metri, fino ad arrivare a un incrocio, dopo il quale la strada prosegue con il nome di via Roma. All’incrocio prendiamo verso destra la via Sibìola e, appena iniziata questa strada, alla sua sinistra si apre la piazza Gruxi ’e ferru un’ampia piazza alberata nella quale si svolgono manifestazioni ed eventi, come ad esempio gli spettacoli folcloristici. Sull’angolo tra la via Roma e la via Sibìola, su una colonna in marmo, è presente la croce in metallo che dà il nome alla piazza.
Dalla rotonda alla quale sono arrivate la SS387 del Gerrei e la SS466 di Sibìola, prendiamo il viale della Repubblica e lo seguiamo per seicento metri, fino ad arrivare a un incrocio, dopo il quale la strada prosegue con il nome di via Roma. All’incrocio prendiamo verso destra la via Sibìola e, appena iniziata questa strada, alla sua sinistra si apre la piazza Gruxi ’e ferru un’ampia piazza alberata nella quale si svolgono manifestazioni ed eventi, come ad esempio gli spettacoli folcloristici. Sull’angolo tra la via Roma e la via Sibìola, su una colonna in marmo, è presente la croce in metallo che dà il nome alla piazza.
 Sulla piazza, di fonte alla via Roma, si sviluppa l’edificio, in stile umbertino, delle vecchie Scuole elementari costruito nel 1912, Nell’edificio, ristrutturato dall’amministrazione comunale nel 1992, ha la sua sede la Biblioteca comunale istituita nel 1981, intitolata a Monsignor Agostino Saba. La Biblioteca possiede circa 12mila volumi, è dotata, oltre che delle normali sezioni di narrativa e saggistica, di una ricca e articolata sezione per bambini di età prescolare, per ragazzi, di una sezione specifica della Sardegna e della nuova sezione dedicata alla mediateca. Oltre alla normale attività di consultazione e prestito libri, la Biblioteca organizza incontri di animazione alla lettura per bambini.
Sulla piazza, di fonte alla via Roma, si sviluppa l’edificio, in stile umbertino, delle vecchie Scuole elementari costruito nel 1912, Nell’edificio, ristrutturato dall’amministrazione comunale nel 1992, ha la sua sede la Biblioteca comunale istituita nel 1981, intitolata a Monsignor Agostino Saba. La Biblioteca possiede circa 12mila volumi, è dotata, oltre che delle normali sezioni di narrativa e saggistica, di una ricca e articolata sezione per bambini di età prescolare, per ragazzi, di una sezione specifica della Sardegna e della nuova sezione dedicata alla mediateca. Oltre alla normale attività di consultazione e prestito libri, la Biblioteca organizza incontri di animazione alla lettura per bambini.
La Cantina Pala Vini di Serdiana con un vino premiato dal Gambero Rosso
Dall’incrocio, presa verso destra la via Sibìola, dopo meno di cento metri, svoltiamo a sinistra il via Giuseppe Verdi, che seguiamo per un’ottantina di metri, fino a vedere, alla sinistra della strada, al civico numero 7 della via Giuseppe Verdi, una delle due famose cantine vinicole di Serdiana, la Cantina Pala Vini di Sardegna.
Le Cantine Argiolas di Serdiana con un vino premiato dal Gambero Rosso
Da dove termina il viale della Repubblica, prendiamo la sua prosecuzione verso sud che è la via Roma e la seguiamo per trecento metri, arrivando a vedere, alla destra della strada, al civico numero 28, l’ingresso di un’altra delle due famose cantine vinicole di Serdiana, ossia le Cantine Argiolas.
La chiesa parrocchiale del Santissimo Salvatore
 Da dove dal viale della Repubblica avevamo imboccato la via Roma, la seguiamo per circa duecentocinquanta metri, poi subito dopo il civico numero 24b, una cinquantina di metri prima delle Cantine Argiolas, voltiamo a destra e prendiamo la via Mario de Candia. Dopo una sessantina di metri, la via Mario de Candia arriva di fronte al lato destro della Chiesa del Santissimo Salvatore che è la parrocchiale di Serdiana, il cui ingresso si trova seguendo il lato della chiesa verso sinistra, affacciato nella piazza del Santissimo Salvatore. Questa chiesa è stata edificata in una delle zone più alta del paese, così che potesse esser vista in tutta la sua struttura anche dalla strada statale sottostante. L’impianto è databile nel diciassettesimo o dicottesimo secolo in stile tardo barocco, mentre la facciata è in stile classico, comunque la sua struttura è stata edificata in epoche diverse. Il primo impianto risale al 1610 ed è rappresentato dalla Cappella della Pietà, immediatamente dopo viene costruita la Cappella del Rosario nel 1650, il cupolone è completato nel 1770 e il campanile nel 1844. La facciata è suddivisa in quattro lesene simmetriche sormontate da capitelli, mentre ai lati si trovano due nicchie. Sopra il portale ottocentesco, è presente una finestra a forma di lunetta e la facciata è sormontata da un timpano classicista di forma triangolare. Ai due lati si trovano le cappelle e le cupole sono a pianta ottagonale e culminano con la lanterna. Sul fondo è posizionato il campanile. Le campane della chiesa sono tre e hanno diverse date, la prima è del 1615, la seconda del 1828 e l’ultima del 1915.
Da dove dal viale della Repubblica avevamo imboccato la via Roma, la seguiamo per circa duecentocinquanta metri, poi subito dopo il civico numero 24b, una cinquantina di metri prima delle Cantine Argiolas, voltiamo a destra e prendiamo la via Mario de Candia. Dopo una sessantina di metri, la via Mario de Candia arriva di fronte al lato destro della Chiesa del Santissimo Salvatore che è la parrocchiale di Serdiana, il cui ingresso si trova seguendo il lato della chiesa verso sinistra, affacciato nella piazza del Santissimo Salvatore. Questa chiesa è stata edificata in una delle zone più alta del paese, così che potesse esser vista in tutta la sua struttura anche dalla strada statale sottostante. L’impianto è databile nel diciassettesimo o dicottesimo secolo in stile tardo barocco, mentre la facciata è in stile classico, comunque la sua struttura è stata edificata in epoche diverse. Il primo impianto risale al 1610 ed è rappresentato dalla Cappella della Pietà, immediatamente dopo viene costruita la Cappella del Rosario nel 1650, il cupolone è completato nel 1770 e il campanile nel 1844. La facciata è suddivisa in quattro lesene simmetriche sormontate da capitelli, mentre ai lati si trovano due nicchie. Sopra il portale ottocentesco, è presente una finestra a forma di lunetta e la facciata è sormontata da un timpano classicista di forma triangolare. Ai due lati si trovano le cappelle e le cupole sono a pianta ottagonale e culminano con la lanterna. Sul fondo è posizionato il campanile. Le campane della chiesa sono tre e hanno diverse date, la prima è del 1615, la seconda del 1828 e l’ultima del 1915.
L’interno è caratterizzato da una pianta centrale e il soffitto è in legno e a capriate. Ai lati sorgono sei cappelle costruite in epoche diverse. L’altare maggiore, realizzato in marmi policromi e articolato in piani diversi, presenta alla base due scalini, sulla cima è presente una nicchia sorretta da quattro colonnine di marmo nero con capitelli ionici, ed all’interno della nicchia si trova la statua lignea del Santissimo Salvatore, che rappresenta il Cristo benedicente, avvolto da un ampio manto scuro con bordi dorati e sulla mano sinistra sorregge una sfera simbolo della sua potenza creatrice. L’autore della statua è ignoto ma si pensa possa essere stata eseguita dallo stesso scultore della statua artistica di Santa Maria in Sebiola che è oggetto di particolare venerazione, ossia Antonio lonis di Senorbì.
Ai lati dell’altare sono presenti le due cappelle voltate a botte della Pietà e del Rosario, nella quale l’altare è sovrastato da un dipinto di autore ignoto che rappresenta la deposizione di Cristo dalla croce. A fianco alla Cappella del Rosario si trova il pulpito del 1878 in marmo bianco, appoggiato su una lesena, in stile tardo barocco. Nella Cappella del Sacro Cuore sono conservati i sarcofaghi con i resti di monsignor Agostino Saba e monsignor Paolo Carta. Ai lati dell’ingresso si trovano a sinistra la pila dell’acquasantiera del dodicesimo secolo, in stile romanico, proveniente dalla chiesa di Santa Maria di Sibìola, ed a destra la fonte battesimale, di Scuola genovese, in marmi policromi e legno, con la parte superiore in legno intarsiato e riproduce la scena del Battesimo di Cristo.
 Le principali manifestazioni religiose a Serdiana riguardano la festa del patrono, il Santissimo Salvatore, che si svolge in due periodi dell’anno, a maggio ed a novembre. La festa maggiore si svolge la seconda domenica di maggio, con la Festa patronale del Santissimo Salvatore, caratterizzata da una processione che accompagna il simulacro del Santo per le vie del paese, con i festeggiamenti organizzati dal Comitato de Is Obreris che si occupa dei riti religiosi, degli spettacoli in piazza e di quelli pirotecnici. Il lunedì, al simulacro del Santissimo Salvatore si unisce quello di Sant’Efisio nella Festa di Sant’Efisio Martire, dedicata al patrono della Sardegna, il cui culto è vivo anche in questo paese. La domenica successiva viene festeggiato Sant’Isidoro, protettore degli agricoltori, il cui simulacro veste abiti da contadino e tiene in mano un mazzo di spighe.
Le principali manifestazioni religiose a Serdiana riguardano la festa del patrono, il Santissimo Salvatore, che si svolge in due periodi dell’anno, a maggio ed a novembre. La festa maggiore si svolge la seconda domenica di maggio, con la Festa patronale del Santissimo Salvatore, caratterizzata da una processione che accompagna il simulacro del Santo per le vie del paese, con i festeggiamenti organizzati dal Comitato de Is Obreris che si occupa dei riti religiosi, degli spettacoli in piazza e di quelli pirotecnici. Il lunedì, al simulacro del Santissimo Salvatore si unisce quello di Sant’Efisio nella Festa di Sant’Efisio Martire, dedicata al patrono della Sardegna, il cui culto è vivo anche in questo paese. La domenica successiva viene festeggiato Sant’Isidoro, protettore degli agricoltori, il cui simulacro veste abiti da contadino e tiene in mano un mazzo di spighe.
Nella prima decade di novembre si ripetono i festeggiamenti religiosi con la Sagra di Santu Sarbadoreddu, che è la seconda festa patronale dedicata al Santissimo Salvatore. Abbinata a tale festa, da una decina d’anni, il gruppo folk organizza la Festa dell’Anziano, e la manifestazione si conclude con uno spettacolo variegato, organizzato e interpretato con passione da parte di un gruppo di locali attori dilettanti che riescono, con gli anni, a trovare sempre nuovi spunti per intrattenere il pubblico. La serata del giorno dopo è imperniata su intrattenimenti musicali e sulla tradizionale favata, con degustazione di vini novelli e prodotti tipici locali.
Il Monte Granatico e l’Oratorio del Santissimo Salvatore
Da dove, seguendo la via Mario de Candia, eravamo arrivati di fronte al lato destro della chiesa parrocchiale del Santissimo Salvatore, se seguiamo il lato desto della chiesa verso destra, arriviamo alla sua estremità posteriore, passata la quale si arriva di fronte all’edificio che ospitava il Monte Granatico di Serdiana. La data della sua costruzione non è conosciuta, anche se è probabile che esso sia sorto in seguito alle disposizione del vicerché Lodovico d’Hallot des Hayes che, nel 1767, incentivò l’istituzione dei Monti e ne regolarizzò il funzionamento. I Monti Granatici erano centri di raccolta dei cereali utilizzati come fondo comune e in Sardegna ebbero un ruolo fondamentale per l’economia e la crescita del territorio in quanto avevano lo scopo di combattere il dilagante fenomeno dell’usura. I materiali utilizzati per la costruzione delle pareti di questo edificio sono pietrame e fango, il pavimento era realizzato da un semplice battuto di cemento e il tetto, allora in precarie condizioni, era a due falde, internamente retto da capriate in legno e con l’orditura realizzata in canne, mentre esternamente era rivestito da tegole tipo coppi. Il Monte Granatico è stato acquistato dal comune nel 1984, ed i lavori di restauro non hanno modificato la struttura originaria dell’edificio.
alla destra di questo edificio, sul lato destro della piazza, si vede la facciata con l’ingresso del piccolo Oratorio del Santissimo Salvatore che si trova sulla stessa piazza della chiesa parrocchiale, e che ospita manifestazioni ed eventi organizzati per i frequentatori dell’Oratorio e per il resto della popolazione.
Il Municipio di Serdiana
 Da dove dal viale della Repubblica avevamo imboccato la via Roma, la seguiamo per circa centotrenta metri, poi svoltiamo a sinistra nella via Monsignor Agostino Saba, la seguiamo per appena una settantina di metri, e vediamo, alla destra della strada, al civico numero 10, l’edificio che ospita il Municipio di Serdiana, con la sua sede e con gli uffici che forniscono i loro servizi agli abitanti del paese, ossia gli Affari Generali, l’Assetto del territorio, l’Edilizia Pubblica, l’Edilizia Privata, il Manutentivo e Verde Pubblico, il Finanziario e Tributi, la Polizia locale, ed il Socio Assistenziale, Cultura, Sport e Spettacolo.
Da dove dal viale della Repubblica avevamo imboccato la via Roma, la seguiamo per circa centotrenta metri, poi svoltiamo a sinistra nella via Monsignor Agostino Saba, la seguiamo per appena una settantina di metri, e vediamo, alla destra della strada, al civico numero 10, l’edificio che ospita il Municipio di Serdiana, con la sua sede e con gli uffici che forniscono i loro servizi agli abitanti del paese, ossia gli Affari Generali, l’Assetto del territorio, l’Edilizia Pubblica, l’Edilizia Privata, il Manutentivo e Verde Pubblico, il Finanziario e Tributi, la Polizia locale, ed il Socio Assistenziale, Cultura, Sport e Spettacolo.
La piazza Eroici caduti con il monumento e le lapidi commemorative dei caduti
Passato il Municipio, proseguendo lungo la via Monsignor Agostino Saba, dopo un’ottantina di metri la strada termina, e parte a destra la via Umberto I, a sinistra la via XX Settembre, mentre di fronte si apre una piazza pedonale, che assume il nome di piazza Eroici caduti. Al centro della piazza pedonale si trova il Monumento ai Caduti Di Serdiana in tutte le guerre, un blocco verticale in marmo sovrastato da un elmo in bronzo, e sul quale è appoggiata una divisa militare, anch’essa in bronzo.
Prendendo alla destra la via Umberto I, subito alla destra di questa strada, al civico numero 4, si trova l’edificio che ospita la Scuola materna Eroici caduti di Serdiana, sulla facciata della quale, alla sinistra del portale, si trova una Lapide commemorativa in marmo realizzata tra il 1925 ed il 1935, con incisi i nomi dei caduti della prima guerra mondiale.
La Casa Museo
Dalla via Monsignor Agostino Saba, prendiamo a sinistra la via XX Settembre, un tempo chiamata Bia Mesuidda poichché è situata nel centro storico del paese. Dopo un’ottantina di metri, alla sinistra della strada, al civico numero 13, si trova l’ingresso della Casa Museo che era la Casa Mura Sebastiano e costituisce un Museo Etnografico. Si tratta di una tipica casa a corte, significativa per la sua connotazione storica e la sua configurazione architettonica, che è stata acquistata dal comune nel 1996. Sulla chiave di volta del portale è scolpita la data 1855 che attesta il termine della sua costruzione, anche se l’isolato risulta già perfettamente formato nel 1841, ed il portale, costruito a misura di carro, si affaccia su un piccolo percorso Imperdau. All’interno della corte, in corrispondenza del portale, si trova Su procciu, uno spazio coperto che era adibito alla custodia del calesse, e al di sopra Vi è Su stalli, il locale dove solitamente venivano conservate le provviste familiari. Lo stabile appare lungo e stretto, su due livelli, coperto da un tetto a due falde, e, rispetto all’impianto originario, ha subito alcune modifiche, ma nel complesso conserva ancora la caratteristica di duplice partizione dei cortili, con una Pratza de ananti, destinata all’ambito di relazione con il paese, e una Pratza de pallas, finalizzata agli usi produttivi agricoli. Nel cortile posteriore, a ridosso delle mura di recinzione sono presenti Is lollas, porticati rustici destinati ai lavori agricoli, al ricovero degli animali, e Su magasinu.
all’interno dell’abitazione i locali sono comunicanti tra di loro e qui trovano collocazione alcuni arredi e utensili che riproducono lo stile di vita di una famiglia di grossi proprietari terrieri di fine Ottocento. Percorrendo il vialetto Imperdau, si arriva all’ingresso della casa dove trova posto una cassapanca in legno. Da qui si ha l’accesso per Sa coxina, il cuore della vita familiare, S’apposentu bonu, luogo adibito al ricevimento degli ospiti, mentre dal lato opposto si ha l’accesso a Is apposentusu de croccai, le stanze da letto. Nella parte superiore è allestita una mostra permanente dedicata alla memoria storica relativa al periodo delle due guerre mondiali, con un vasto repertorio fotografico e cimeli bellici.
La casa Carcassona nota anche come Castello Roberti
 Dalla via Monsignor Agostino Saba, prendiamo a destra la via Umberto I e poi, subito a sinistra lla via Giuseppe Garibaldi, che costeggia la piazza Eroici caduti. Percorsa una cinquantina di metri arriviamo a un bivio dove la via Giuseppe Garibaldi prosegue verso destra, mentre prendiamo a sinistra la via Roberti, e, dopo meno di centi meri, quando la strada svolta a destra, vediamo alla sinistra, al civico numero 15, il portale che dà accesso a una delle più importanti strutture del paese, la Casa Carcassona che si sviluppa tra la via Roberti e più a sinistra la via Sant’Antonio. La sua origine risale al diciottesimo secolo, quando l’algherese Efisio Luigi Carcassona ottiene in feudo la villa di Serdiana e il titolo di marchese di San Saverio. Sua figlia Giovanna sposa don Tomaso Nin, ed in seguito la loro figlia luisa sposa il conte Edmondo Roberti di Castelvero, nobile piemontese appassionato archeologo, per cui la casa Carcassona di Serdiana è nota anche come Castello Roberti. Un portale, sul quale è presente lo stemma di famiglia, dà accesso ad un ampio cortile che frontalmente si ripartisce in due zone, in quella a nord vi è un deposito per i mezzi e gli attrezzi agricoli, mentre in quella a sud si scorge un magazzino necessario a contenere i raccolti. In fondo al cortile si trova la costruzione, costituita da un corpo centrale a due piani e da due corpi laterali ad un piano, leggermente più bassi, affiancati da due torri merlate a pianta quadrata. L’edificio presenta le caratteristiche di una casa rurale, più che di un vero e proprio Castello, nonostante le torri merlate.
Dalla via Monsignor Agostino Saba, prendiamo a destra la via Umberto I e poi, subito a sinistra lla via Giuseppe Garibaldi, che costeggia la piazza Eroici caduti. Percorsa una cinquantina di metri arriviamo a un bivio dove la via Giuseppe Garibaldi prosegue verso destra, mentre prendiamo a sinistra la via Roberti, e, dopo meno di centi meri, quando la strada svolta a destra, vediamo alla sinistra, al civico numero 15, il portale che dà accesso a una delle più importanti strutture del paese, la Casa Carcassona che si sviluppa tra la via Roberti e più a sinistra la via Sant’Antonio. La sua origine risale al diciottesimo secolo, quando l’algherese Efisio Luigi Carcassona ottiene in feudo la villa di Serdiana e il titolo di marchese di San Saverio. Sua figlia Giovanna sposa don Tomaso Nin, ed in seguito la loro figlia luisa sposa il conte Edmondo Roberti di Castelvero, nobile piemontese appassionato archeologo, per cui la casa Carcassona di Serdiana è nota anche come Castello Roberti. Un portale, sul quale è presente lo stemma di famiglia, dà accesso ad un ampio cortile che frontalmente si ripartisce in due zone, in quella a nord vi è un deposito per i mezzi e gli attrezzi agricoli, mentre in quella a sud si scorge un magazzino necessario a contenere i raccolti. In fondo al cortile si trova la costruzione, costituita da un corpo centrale a due piani e da due corpi laterali ad un piano, leggermente più bassi, affiancati da due torri merlate a pianta quadrata. L’edificio presenta le caratteristiche di una casa rurale, più che di un vero e proprio Castello, nonostante le torri merlate.
La Cappella dedicata a Sant’Antonio da Padova
all’interno della casa Carcassona, nell’ala est adiacente al magazzino, a fianco della torre, vi è la Cappella dedicata a Sant’Antonio da Padova attualmente di proprietà delle sorelle Angius. Il portone principale è quello antico, e nello spiazzo antistante la piccola chiesa è stato realizzato un giardinetto recintato. Il semplice prospetto a capanna presenta l’originale motivo di un campanile angolare a due vele in cotto. L’interno è quello di una tipica piccola chiesa rurale, costruita in pietra di tufo, con caratteristiche di Cappella ad ala mononavata, con archi a sesto acuto, secondo la tradizione catalana, che fungono non solo da elementi di sostegno della copertura lignea, ma anche di separazione tra il vano presbiteriale e quello in prossimità dell’ingresso, che comunica con l’abitazione, su cui è situato un loggiato di legno padronale, che permetteva ai proprietari del nucleo residenziale di assistere alle funzioni religiose separatamente dal resto della popolazione. Sopra l’altare è situato un dipinto di autore ignoto raffigurante la visione o il sogno di Sant’Antonio, nel fianco sinistro un piccolo pulpito ligneo completo di paravoce, a destra un crocifisso tra due colonne tortili, raccolte superiormente da un elemento orizzontale con motivi a racemo, su cui poggiano la statua di Sant’Antonio e due piccole statue in legno, una del sesto secolo che rappresenta la Vergine Annunziata, e l’altra del diciassettesimo secolo che rappresenta un Vescovo, forse San Demetrio.
La Cappella di Sant’Antonio da Padova si può visitare il 13 giugno, in occasione della festa di Sant’Antonio da Padova, alla quale partecipano numerosissimi fedeli, ed anche su richiesta per ricorrenze particolari.
Il Museo chiamato Sa Domu de Boricu Esì
 Da dove dal viale della Repubblica avevamo imboccato la via Roma, la seguiamo per circa centotrenta metri, poi troviano a sinistra a via Monsignor Agostino Saba che ci porta al Municipio, e dopo centocenti metri troviamo a destra la via Mario de Candia che porta alla chiesa parrocchiale del Santissimo Salvatore. A metà tra questa due strade, prendiamo a sinistra la via Monsignor Paolo Carta, che si dirige verso est, la seguiamo, dopo duecentocinquanta metri la strada prosegue con il nome di via Manno, e, dopo altri Duecentomteri, alla destra della strada, al civico numero 24 della via Manno, si vede una tipica abitazione campidanese, ricca di storia e di tradizione, che ospita il Museo privato chiamato Sa Domu de Boricu Esì. L’abitazione ospita al suo interno una collezione di utensili e attrezzi che fanno parte della cultura agropastorale sarda. Gli utensili in mostra, risalenti al periodo tra l’Ottocento ed i primi del Novecento, sono lo specchio di una società agricola come quella di Serdiana, la cui economia è tuttora basata sull’agricoltura e la pastorizia.
Da dove dal viale della Repubblica avevamo imboccato la via Roma, la seguiamo per circa centotrenta metri, poi troviano a sinistra a via Monsignor Agostino Saba che ci porta al Municipio, e dopo centocenti metri troviamo a destra la via Mario de Candia che porta alla chiesa parrocchiale del Santissimo Salvatore. A metà tra questa due strade, prendiamo a sinistra la via Monsignor Paolo Carta, che si dirige verso est, la seguiamo, dopo duecentocinquanta metri la strada prosegue con il nome di via Manno, e, dopo altri Duecentomteri, alla destra della strada, al civico numero 24 della via Manno, si vede una tipica abitazione campidanese, ricca di storia e di tradizione, che ospita il Museo privato chiamato Sa Domu de Boricu Esì. L’abitazione ospita al suo interno una collezione di utensili e attrezzi che fanno parte della cultura agropastorale sarda. Gli utensili in mostra, risalenti al periodo tra l’Ottocento ed i primi del Novecento, sono lo specchio di una società agricola come quella di Serdiana, la cui economia è tuttora basata sull’agricoltura e la pastorizia.
Grazie alla passione e alla dedizione del proprietario, Salvatore Dessì detto Tore, si ha la possibilità di scoprire quali fossero gli strumenti e le tecniche utilizzate prima dell’avvento della tecnologia nel mondo del lavoro.
Il Cimitero comunale
Passato il Museo chiamato Sa Domu de Boricu Esì, proseguiamo per altri poco più di trecento metri verso est lungo la via Manno, e, poco prima di uscira dall’abitato, si vedono, alla destra della strada, i muri di cinta con i cancelli di ingresso del Cimitero comunale di Serdiana, prima quello del Cimitero vecchio del paese, più avanti quello del Cimitero nuovo.
Per arrivare agli ingressi del Cimitero, è più facile seguire un’altra strada, Dal Museo proseguiamo lungo la via Manno per soli centotrenta metri, poi prendiamo a destra la via Ciusa, che dopo centoventi metri sbocca sulla via Bacaredda, la prendeiamo a sinistra e, in circa centottanta metri, arriviamo al parcheggio, vicino al quale si trovano gli ingressi più comodi del Cimitero.
Il Campo Sportivo comunale
Per visitare gli impianti sportivi, torniamo a dove siamo arrivati nell’abitato di Serdiana con una delle due Strade statali. Raggiunta la rotonda, prendiamo il viale della Repubblica, la seguiamo per trecentocinquanta metri, poi svoltiamo a destra e prendiamo la via Arturo Toscanini, dopo appena una cinquantina di metri svoltiamo a destra in una strada senza nome, lungo la quale, dopo trecentocinquanta metri, si vede alla destra il cancello di ingresso del Campo Sportivo comunale di Serdiana. All’interno, si trova un Campo da Calcio in erba, dotato di tribune in grado di ospitare 700 spettatori. Intorno al campo in erba, si trova una Pista di atletica leggera, nella quale praticare come discipline le Corse su pista, il salto con l’asta, ed il salto in estensione.
alla sinistra del campo in erba, si trova un Campo da Calcio in terra, che non è dotato di tribune. Su retro del campo in erba, è presente un Campo da Calcetto, ossia da Calcio a cinque, con fondo in erba sintetica, e con tribune per una cinquantina di spettatori. É, inoltre, presente un Campo polivlente, con fondo in terra, senza tribune, nel quale praticare come discipline la pallavolo ed il Beaché volley.
Visita dei dintorni di Serdiana
Vediamo ora che cosa si trova di più sigificativo nei dintorni dell’abitato che abbiamo appena descritto. Per quanto riguarda le principali ricerche archeologiche effettuate nei dintorni di Serdiana, sono stati portati alla luce i resti dei nuraghi Bruncu de Is Olias, Cuccuru S’Eremitanu, Is Paulis, Matzeddus, monte Sa Frissa, S’Omu ’e S’Orcu, Sa Turr ’e Casu, Sibìola, su Staini, tutti di tipologia indefinita.
Il Santuario di Santa Maria di Sibìola
 Dal centro di Serdiana prendiamo la strada senza nome che porta al Campo Sportivo comunale, e, dopo duecentocinquanta metri, poco prima del cancello di ingresso del campo, seguiamo le indicazioni che ci fanno prendere una deviazione a sinistra, dopo due chilometri e duecento metri arriviamo a un bivio, dove verso sinistra si va verso lo stagno di Stani Saliu, mentre noi proseguiamo verso destra, e, evitando le deviazioni secondarie, in un chilometro e duecento metri, arriviamo all’ingresso del Parco di Santa Maria di Sibìola. Ci si poteva arrivare anche dalla rotonda alla fine del viale della Repubblica, prendendo la terza uscita, che porta sulla Strada Statale 387 del Gerrei in direzione di Ussana, dopo circa due chilometri e cento metri le indicazioni, fanno svoltare a sinistra sulla strada vicinale che collega donori con Cagliari, seguendola per un chilometro e ottocento metri finché sbocca su una traversale, che porta all’ingresso del parco.
Dal centro di Serdiana prendiamo la strada senza nome che porta al Campo Sportivo comunale, e, dopo duecentocinquanta metri, poco prima del cancello di ingresso del campo, seguiamo le indicazioni che ci fanno prendere una deviazione a sinistra, dopo due chilometri e duecento metri arriviamo a un bivio, dove verso sinistra si va verso lo stagno di Stani Saliu, mentre noi proseguiamo verso destra, e, evitando le deviazioni secondarie, in un chilometro e duecento metri, arriviamo all’ingresso del Parco di Santa Maria di Sibìola. Ci si poteva arrivare anche dalla rotonda alla fine del viale della Repubblica, prendendo la terza uscita, che porta sulla Strada Statale 387 del Gerrei in direzione di Ussana, dopo circa due chilometri e cento metri le indicazioni, fanno svoltare a sinistra sulla strada vicinale che collega donori con Cagliari, seguendola per un chilometro e ottocento metri finché sbocca su una traversale, che porta all’ingresso del parco.
 su una collina, all’interno del parco, si trova il Santuario di Santa Maria di Sibìola, una chiesa romanica costruita dai monaci Benedettini Vittorini del Convento di San Vittore di Marsiglia, nella seconda metà dell’undicesimo secolo al centro del villaggio agricolo d’origine romana di Sibìola, del quale dovette essere l’unico luogo di culto. Secondo alcune informazioni, il villaggio risulta essere disabitato dal 1416, e di esso non è rimasta traccia. Sulle cause della sua scomparsa, non si hanno prove concrete, si potrebbe pensare a guerre, banditismo o carestie ed epidemie. A tale proposito, una leggenda diffusa tra la popolazione di Serdiana racconta che una invasione di mosche giganti, la famosa Sa Musca Maccedda, avrebbe infestato il villaggio e scatenato tremende febbri malariche, ed avrebbe decimato la popolazione, costringendo i superstiti a spostarsi a qualche chilometro di distanza, dove è situata ora Serdiana. In seguito, la chiesa viene data in custodia ad un eremitano, che utilizza alcune stanzette costruite durante l’epidemia di colera del 1912, adibite probabilmente a lazzaretto. Per poi passare, dopo qualche tempo, sotto la tutela del Comune.
su una collina, all’interno del parco, si trova il Santuario di Santa Maria di Sibìola, una chiesa romanica costruita dai monaci Benedettini Vittorini del Convento di San Vittore di Marsiglia, nella seconda metà dell’undicesimo secolo al centro del villaggio agricolo d’origine romana di Sibìola, del quale dovette essere l’unico luogo di culto. Secondo alcune informazioni, il villaggio risulta essere disabitato dal 1416, e di esso non è rimasta traccia. Sulle cause della sua scomparsa, non si hanno prove concrete, si potrebbe pensare a guerre, banditismo o carestie ed epidemie. A tale proposito, una leggenda diffusa tra la popolazione di Serdiana racconta che una invasione di mosche giganti, la famosa Sa Musca Maccedda, avrebbe infestato il villaggio e scatenato tremende febbri malariche, ed avrebbe decimato la popolazione, costringendo i superstiti a spostarsi a qualche chilometro di distanza, dove è situata ora Serdiana. In seguito, la chiesa viene data in custodia ad un eremitano, che utilizza alcune stanzette costruite durante l’epidemia di colera del 1912, adibite probabilmente a lazzaretto. Per poi passare, dopo qualche tempo, sotto la tutela del Comune.
Attestata per la prima volta nel 1338, in un inventario di possedimenti dei Benedettini, non pare comunque essere appartenuta a tale congregazione monastica. La struttura, in conci di arenaria grigia, si presenta con una facciata piana, che è oggi priva del perduto campanile, nella quale si aprono due ingressi arcuati, che hanno in asse una monofora ed una bifora. Al centro della facciata, è inserito un blocchetto con interessante fregio bicromo, che potrebbe essere la raffigurazione del sole. Altri elementi decorativi erano i bacini ceramici di cui rimangono gli incavi d’alloggiamento, e gli archetti che ancora si trovano lungo tutto l’ordine superiore della muratura esterna, taluni impostati su peducci scolpiti con motivi umani, animaleschi e naturalistici. Molto particolare è la scaletta inserita sul fianco settentrionale, formata da mensoloni litici incassati nella muratura.
L’interno, sobrio come si conviene allo stile romanico, è composto da due navate non uguali, entrambe voltate a botte e dotate di absidi con finestrella, separate da quattro basse arcate che poggiano su pilastri con capitelli decorati. Iin fondo alla navata principale si trova l’altare della chiesa, al cospetto del grande crocifisso di legno fissato alla parete, mentre in fondo alla navata di destra, quasi in corrispondenza con l’ingresso laterale, si trova il bell’altare in pietra. L’acquasantiera originaria è stata portata nella chiesa parrocchiale e le due tavole residue del suo retablo quattrocentesco che rappresenta varie scene del Nuovo Testamento, tra le quali il Giudizio Universale, sono conservate oggi nella Pinacoteca nazionale di Cagliari.
 La chiesa viene definita un Santuario, ossia un luogo ritenuto sacro dalla tradizione religiosa, per la devozione dei fedeli alla statua di Santa Maria. Per la Festa di Santa Maria di Sibìola, a cui i serdianesi sono molto devoti, dopo un triduo di preparazione, nel tardo pomeriggio del 7 settembre, a conclusione della messa vespertina in parrocchia, parte la processione verso la chiesa campestre, dove all’arrivo il comitato dei festeggiamenti organizza una cena tradizionale. La mattina del giorno solenne, l’8 settembre, la Santa viene accompagnata in una processione propiziatoria attraverso i campi, per far sì che le avversità atmosferiche non rovinino i raccolti, viene poi ricondotta alla sua sede campestre dove si celebra la messa. Il terzo giorno, al calare del sole, la Santa ritorna in paese in Su Cocciu, un carro trainato da buoi, accompagnata da cavalli, traccas, gruppi folcloristici e da un corteo di persone, molte delle quali giungono da diversi paesi della Sardegna.
La chiesa viene definita un Santuario, ossia un luogo ritenuto sacro dalla tradizione religiosa, per la devozione dei fedeli alla statua di Santa Maria. Per la Festa di Santa Maria di Sibìola, a cui i serdianesi sono molto devoti, dopo un triduo di preparazione, nel tardo pomeriggio del 7 settembre, a conclusione della messa vespertina in parrocchia, parte la processione verso la chiesa campestre, dove all’arrivo il comitato dei festeggiamenti organizza una cena tradizionale. La mattina del giorno solenne, l’8 settembre, la Santa viene accompagnata in una processione propiziatoria attraverso i campi, per far sì che le avversità atmosferiche non rovinino i raccolti, viene poi ricondotta alla sua sede campestre dove si celebra la messa. Il terzo giorno, al calare del sole, la Santa ritorna in paese in Su Cocciu, un carro trainato da buoi, accompagnata da cavalli, traccas, gruppi folcloristici e da un corteo di persone, molte delle quali giungono da diversi paesi della Sardegna.
Il 9 settembre è dedicato alla Festa di San Raffaele Arcangelo, che è festeggiato nel paese, il cui simulacro viene portato in processione lungo le vie dell’abitato, insieme a quello di Santa Maria di Sibìola. Alla processione seguono le cerimonie solenni e le manifestazioni civilii.
Lo stagno salato noto con il nome di su Staini Saliu
 Dal centro di Serdiana prendiamo la strada senza nome che porta al Campo Sportivo comunale, e, dopo duecentocinquanta metri, poco prima del cancello di ingresso del campo, seguiamo le indicazioni che ci fanno prendere una deviazione a sinistra, dopo due chilometri e duecento metri arriviamo a un bivio, dove verso destra si va verso la chiesa di Santa Maria di Sibìola, mentre noi proseguiamo verso sinistra. Evitando le deviazioni secondarie, in due chlometri e duecento metri, raggiungiamo un piccolo bacino di acque debolmente salmastre denominato Su Staini Saliu ossia lo stagno salato, che occupa una superficie di oltre 225mila metri quadrati ed ha una profondità di quasi due metri. Il fondo è composto da un substrato di origine inorganica impermeabile, per cui con l’evaporazione, soprattutto nel periodo estivo, viene favorita la formazione di strati di sale. Le rive dello stagno hanno in parte mantenuto le caratteristiche naturali delle acque palustri, infatti sono ricce di tamerici, di giuchi e di erba corallina. Nel periodo primaverile e autunnale, grazie alle condizioni ambientali e alla presenza di pozze d’acqua dimorano diverse specie di uccelli come anatidi, trampolieri, cavalieri d’Italia, gabbiani, avocette, garzette e anche i fenicotteri rosa, uccelli dall’aspetto esotico. Si tratta di un importante ambiente naturale incontaminato.
Dal centro di Serdiana prendiamo la strada senza nome che porta al Campo Sportivo comunale, e, dopo duecentocinquanta metri, poco prima del cancello di ingresso del campo, seguiamo le indicazioni che ci fanno prendere una deviazione a sinistra, dopo due chilometri e duecento metri arriviamo a un bivio, dove verso destra si va verso la chiesa di Santa Maria di Sibìola, mentre noi proseguiamo verso sinistra. Evitando le deviazioni secondarie, in due chlometri e duecento metri, raggiungiamo un piccolo bacino di acque debolmente salmastre denominato Su Staini Saliu ossia lo stagno salato, che occupa una superficie di oltre 225mila metri quadrati ed ha una profondità di quasi due metri. Il fondo è composto da un substrato di origine inorganica impermeabile, per cui con l’evaporazione, soprattutto nel periodo estivo, viene favorita la formazione di strati di sale. Le rive dello stagno hanno in parte mantenuto le caratteristiche naturali delle acque palustri, infatti sono ricce di tamerici, di giuchi e di erba corallina. Nel periodo primaverile e autunnale, grazie alle condizioni ambientali e alla presenza di pozze d’acqua dimorano diverse specie di uccelli come anatidi, trampolieri, cavalieri d’Italia, gabbiani, avocette, garzette e anche i fenicotteri rosa, uccelli dall’aspetto esotico. Si tratta di un importante ambiente naturale incontaminato.
In territorio di Soleminis si trova la Cappella campestre di San Marziale
Non lontano da Serdiana, si trova una Cappella campestre che appartiene però a Soleminis, pur essendo molto distante a nord ovest dal suo abitato, ed invece vicino a quello di Serdiana. Dal centro di Serdiana, lungo la via Roma raggiungiamo l’ingresso delle Cantine Argiolas, e proseguiamo verso sud, lungo la strada che, dopo duecentocinquanta metri, prosegue con il nome di via Cagliari. Seguita per seicentocinquanta metri, troviamo a sinistra la deviazione per l’Agriturismo Santu Marcialis, che raggiungiamo in poco più di cinquecento metri. Accanto all’Agriturismo, è presente la Cappella dedicata a Santu Marcialis ossia a San Marziale che, pur essendo molto vicino a Serdiana, si trova però in territorio di Soleminis.
Questa piccola chiesa campestre è stata costruita agli inizi del ventunesimo secolo, su iniziativa di devoti di Soleminis interessati a rivitalizzare il culto del Santo, al quale, come ricordano, doveva essere intitolata la scomparsa chiesa parrocchiale del villaggio medievale di Solomura.
La Cantina Audarya con un vino premiato dal Gambero Rosso
alla fine verso nord del viale della Repubblica, arrivati alla rotonda, prendiamo la terza uscita, che porta sulla SS466 di Sibìola diretta ad ovest verso Ussana e, percorsi appena quattrocentocinquanta metri, subito dopo il cartello che indica il chilometro 10.1, vediamo alla sinistra della strada l’ingresso della tenuta nella quale si trova la Cantina Audarya.
La Cantina Antonella Corda con un vino premiato dal Gambero Rosso
Proseguiamo sulla SS466 di Sibìola diretta ad ovest verso Ussana per circa tre chilometri e trecento metri e, subito prima del cartello che indica il chilometri 6.8, si trova alla sinistra della strada l’ingresso della tenuta nella quale si trova la Cantina Antonella Corda.
I ruderi della chiesa campestre di Santa Lucia

 alla fine verso nord del viale della Repubblica, arrivati alla rotonda, prendiamo la seconda uscita, che porta sulla SS387 del Gerrei diretta a nord verso Donorì e, dopo circa cinque chilometri, prendiamo l’ultima deviazione a sinistra prima di incrociare la linea ferroviaria, che è la strada vicinale di Corte Maccioni. Percorsi seicentocinquanta metri, prendiamo a sinistra la strada bianca che costeggia la strada ferrata, la seguiamo per quasi due chilometri e troviamo, alla destra della strada bianca, i Ruderi della chiesa campestre di Santa Lucia che era stata edificata alla fine del quattordicesimo secolo, della quale oggi rimangono solo pochi resti della facciata, dopo il crollo avvenuto negli anni novanta del secolo scorso.
alla fine verso nord del viale della Repubblica, arrivati alla rotonda, prendiamo la seconda uscita, che porta sulla SS387 del Gerrei diretta a nord verso Donorì e, dopo circa cinque chilometri, prendiamo l’ultima deviazione a sinistra prima di incrociare la linea ferroviaria, che è la strada vicinale di Corte Maccioni. Percorsi seicentocinquanta metri, prendiamo a sinistra la strada bianca che costeggia la strada ferrata, la seguiamo per quasi due chilometri e troviamo, alla destra della strada bianca, i Ruderi della chiesa campestre di Santa Lucia che era stata edificata alla fine del quattordicesimo secolo, della quale oggi rimangono solo pochi resti della facciata, dopo il crollo avvenuto negli anni novanta del secolo scorso.
I resti della Stazione ferroviaria di Is Mizas
Percorso un altro chilometro sulla strada bianca, che si allontana verso nord dalla attuale linea ferroviaria, si trovano i resti della Stazione ferroviaria di Is Mizas che era una fermata lungo il vecchio tracciato della ferrovia che collegava Cagliari con Isili. La fermata è stata realizzata in posizione isolata, nelle campagne tra Serdiana e donori, dalle Ferrovie Complementari della Sardegna, e risulta in uso negli anni sessanta del Novecento, sebbene come fermata a richiesta. Passata nel 1989 alle Ferrovie della Sardegna, la struttura rimane operativa sino agli anni novanta, periodo in cui sulla linea che collega Cagliari con Isili sono stati eseguiti vari interventi di rettifica del tracciato, uno dei quali ha portato alla costruzione della attuale variante a sud della fermata di Is Mizas, e questa fermata rimane, quindi, isolata dalla ferrovia, e dismessa con l’attivazione del nuovo tracciato, venendo successivamente disarmata e abbandonata.
La prossima tappa del nostro viaggio
Nella prossima tappa del nostro viaggio, da Serdiana ci recheremo a Dolianova nota per la sua produzione vinicola, olivicole e casearia, che visiteremo con il suo centro costituito dall’unione degli antichi comuni di Sicci San Biagio e Dolia San Pantaleo, con la Cattedrale di San Pantaleo, e con i suoi dintorni nei quali si trova il complesso nuragico S’Omu e S’Orcu.
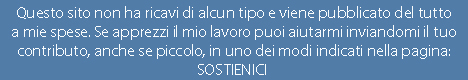
Tutte le foto e riprese sono state effettuate a scopo amatoriale per uso personale senza fini di lucro. Alle nostre foto se ne aggiungono altre inviateci da amici ed alcune tratte da Internet. Alcune informazioni sulle descrizioni dei comuni sono tratte da italiapedia.it, molte descrizioni e foto da wikimapia.org, informazioni sui siti archeologici da tharros.info, descrizoni e foto di chiese da chieseitaliane.chiesacattolica.it/chieseitaliane, foto di impianti sportivi da sardegnasport.it, altre da siti differenti. È consentito scaricare testi, foto e riprese dell’autore per uso privato senza eliminare i riferimenti. Libri e filmati sono riprodotti per farli conoscere ma non è consentita la riproduzione delle foto di terzi, dei libri, dei filmati e di altro materiale non realizzato dall’autore. È vietato qualsiasi utilizzo commerciale del materiale in assenza di apposita autorizzazione. |
© Claudio de Tisi 2002-2025 - Codice Fiscale DTSCLD44M23F132W













































































