Un sito di oltre 480 pagine che descrive tutta l’Isola e che pur non vendendo nulla riceve fino a oltre un migliaio di visitatori ogni giorno


La Città di Porto Torres che è stata la capitale del Giudicato di Logudoro con la Basilica dei Santi Gavino Proto e Gianuario
In questa tappa del nostro viaggio, entreremo nella Nurra con la visita di Porto Torres che è stata la capitale del Giudicato di Logudoro, con la Basilica dei Santi Gavino, Proto e Gianuario e con i resti archeologici presenti all’interno della città.
La Regione storica della Nurra
 La Nurra, l’antica Nure, che costituiva un’antica curatoria del Giudicato di Torres, è una Regione della Sardegna posta all’estremità nord occidentale dell’Isola, la quale forma un quadrilatero compreso tra il golfo dell’Asinara a nord est ed il Mar di Sardegna ad ovest, delimitata dal Rio Mannu a est e dai rilievi del Logudoro a sud est. I comuni che fanno parte della Nurra sono: Alghero, Olmedo, Porto Torres, Stintino, e numerose frazioni del comune di Sassari. Si tratta di una zona prevalentemente pianeggiante scarsamente popolata, il cui territorio conserva traccia degli insediamenti sparsi dei pastori e contadini, che abitavano in ricoveri di bestiame denominati Cuiles. I punti più alti sono il monte Forte di 464 metri e il monte Doglia di 437 metri. L’economia è basata sull’agricoltura, favorita da importanti opere di bonifica, la pastorizia, la pesca ed il turismo balneare. Importante è stato anche lo sfruttamento minerario della zona, ossia le estrazioni di piombo e zinco ad Argentiera, e minerali di ferro a Canaglia.
La Nurra, l’antica Nure, che costituiva un’antica curatoria del Giudicato di Torres, è una Regione della Sardegna posta all’estremità nord occidentale dell’Isola, la quale forma un quadrilatero compreso tra il golfo dell’Asinara a nord est ed il Mar di Sardegna ad ovest, delimitata dal Rio Mannu a est e dai rilievi del Logudoro a sud est. I comuni che fanno parte della Nurra sono: Alghero, Olmedo, Porto Torres, Stintino, e numerose frazioni del comune di Sassari. Si tratta di una zona prevalentemente pianeggiante scarsamente popolata, il cui territorio conserva traccia degli insediamenti sparsi dei pastori e contadini, che abitavano in ricoveri di bestiame denominati Cuiles. I punti più alti sono il monte Forte di 464 metri e il monte Doglia di 437 metri. L’economia è basata sull’agricoltura, favorita da importanti opere di bonifica, la pastorizia, la pesca ed il turismo balneare. Importante è stato anche lo sfruttamento minerario della zona, ossia le estrazioni di piombo e zinco ad Argentiera, e minerali di ferro a Canaglia.
In viaggio verso la Città di Porto Torres
Dalla costiera di Sorso, superato il bivio che porta a Platamona, la SP51 prosegue e, passata la torre Abbacurrente, a circa tre chilometri e ottocento metri da Platamona, arriviamo a una rotonda. Sulla destra prosegue la strada costiera che porta alla spiaggia di Balai, ma è una strada a senso unico in direzione in uscita da Porto Torres, mentre, se prendiamo verso sinistra entriamo nella via Libero Grassi, e continuando, invece, dritti, entriamo nella periferia di Porto Torres percorriamo via Tramontana, che, dopo settecento metri, continua su via Benedetto Croce, e che, dopo seicento metri, si immette sul lungomare di Balai. Lo prendiamo verso sinistra e lo seguiamo fino a che diventa la via del Mare, che ci porta al Porto turistico ed alla Torre del Porto, che descriveremo più avanti. Dal Municipio di Sorso quello di Porto Torres abbiamo percorso 25,7 chilometri, mentre da Platamona al Municipio di Porto Torres si percorrono circa 7 chilometri.
La Città di Porto Torres

 La Città di Porto Torres (nome sassarese Poltu Torra, altezza metri 21 sul livello del mare, abitanti 21.224 al 31 dicembre 2021 comprese le sue diverse frazioni, che si trovano tutte sull’isola Asinara) si sviluppa nella parte centro occidentale del territorio della provincia di Sassari, nel Golfo dell’Asinara, e si trova ai confini con il comune di Sassari. È il principale porto della Sardegna nord occidentale, da molti preferito in agosto ad Olbia per il minor traffico all’uscita dal porto. Anche alla ripartenza si raggiunge il porto in tempi accettabili, mentre per arrivare ad Olbia occorrono a volte molte ore. Porto Torres è anche il punto di arrivo, o di origine, dipende dai punti di vista, della SS131 di Carlo Felice, la principale via di comunicazione che percorre da a sud nord tutta l’isola. La linea ferroviaria che collega la stazione di Ozieri Chilivani con quella di Porto Torres, ha un proprio scalo sul posto, e la Città dispone di un proprio porto. Il territorio Comunale, classificato di pianura, comprensivo delle isole marittime Piana e Isolotto, ha un profilo geometrico irregolare, con accentuate variazioni altimetriche, e comprende la località Asinara, isola amministrativa situata a ovest dell’omonimo golfo, per anni sede di un Istituto carcerario di massima sicurezza ora smantellato. Divenuta parco nazionale, è caratterizzata dalla tipica vegetazione mediterranea, ossia lentisco, mirto, rosmarino, e, popolata da circa Trecento mufloni, ospita diverse specie di uccelli, tra i quale la rondine di mare, il Falco Pellegrino e l’uccello delle tempeste.
La Città di Porto Torres (nome sassarese Poltu Torra, altezza metri 21 sul livello del mare, abitanti 21.224 al 31 dicembre 2021 comprese le sue diverse frazioni, che si trovano tutte sull’isola Asinara) si sviluppa nella parte centro occidentale del territorio della provincia di Sassari, nel Golfo dell’Asinara, e si trova ai confini con il comune di Sassari. È il principale porto della Sardegna nord occidentale, da molti preferito in agosto ad Olbia per il minor traffico all’uscita dal porto. Anche alla ripartenza si raggiunge il porto in tempi accettabili, mentre per arrivare ad Olbia occorrono a volte molte ore. Porto Torres è anche il punto di arrivo, o di origine, dipende dai punti di vista, della SS131 di Carlo Felice, la principale via di comunicazione che percorre da a sud nord tutta l’isola. La linea ferroviaria che collega la stazione di Ozieri Chilivani con quella di Porto Torres, ha un proprio scalo sul posto, e la Città dispone di un proprio porto. Il territorio Comunale, classificato di pianura, comprensivo delle isole marittime Piana e Isolotto, ha un profilo geometrico irregolare, con accentuate variazioni altimetriche, e comprende la località Asinara, isola amministrativa situata a ovest dell’omonimo golfo, per anni sede di un Istituto carcerario di massima sicurezza ora smantellato. Divenuta parco nazionale, è caratterizzata dalla tipica vegetazione mediterranea, ossia lentisco, mirto, rosmarino, e, popolata da circa Trecento mufloni, ospita diverse specie di uccelli, tra i quale la rondine di mare, il Falco Pellegrino e l’uccello delle tempeste.
Origine del nome
Il suo nome compare, nella documentazione più antica, come Turris Libisonis. Il primo elemento deriva certamente dalla voce protosarda Tyrsis, ad indicare una torre, mentre il secondo è di origine oscura, e sembra avere dei riscontri in antichi toponimi quali Libisiosa, Libya o Libyssa.
La sua economia
L’economia di Porto Torres è basata sull’agricoltura, con la produzione di cereali, frumento, ortaggi e foraggi, e sull’allevamento di bovini, suini, ovini, caprini, equini e avicoli. L’industria è costituita da numerose aziende che operano nei compartialimentare, della pesca e della piscicoltura, tessile, della fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, chimico, plastica, edile e della produzione di energia elettrica. Particolarmente significativa è l’attività di scambi commerciali portuali, da e verso l’Italia settentrionale, e verso molti Paesi stranieri. La sua particolare posizione geografica, che la vede collocata nell’affascinante scenario marino del Golfo dell’Asinara, la rende indiscussa meta turistica e base ideale per effettuare interessanti escursioni nei dintorni. Particolarmente attraenti sono le spiagge di San Gavino a Mare e di Balai, oltre che la vicina Platamona, in territorio di Sorso, con l’omonimo stagno che ospita esemplari di folaghe e germani reali. L’apparato ricettivo offre possibilità di ristorazione e di soggiorno.
Brevi cenni storici
 Per quanto riguarda la sua storia, la città, che sorge su un promontorio calcareo al centro del golfo dell’Asinara, stato un importante scalo commerciale gi in epoca fenicia e successivamente punica, anche se sono poche le tracce lasciate da queste popolazioni. Nonostante l’area geografica si presenti come una costa lineare e senza insenature utili per la realizzazione di un porto, l’isola dell’Asinara ripara questo tratto di mare dai venti predominanti di ponente e di maestrale, rendendo quindi l’area perfetta per un approdo marittimo. È quindi probabile che esistesse un legame tra l’isola dell’Asinara, che era chiamata l’isola di Ercole dai Romani, e il culto di Melqart, l’Ercole fenicio punico. I Fenici erano soliti frequentare le coste sarde poich composte da suolo fertile e ricche di minerali. Nei loro punti di approdo stabilivano piccoli mercati dove venivano scambiate le più svariate merci. Di queste installazioni alcune finivano per svilupparsi fino a diventare veri e propri villaggi e, secondo alcune teorie, questo ultimo passaggio avvenne proprio nel territorio di Porto Torres. Alcuni ammennicoli rinvenuti raffigurano il dio Bes, altri ritrovamenti sono una stele punica in tufo, una coppa greca del sesti secolo avanti Cristo, rasoi e varie vettovaglie.
Per quanto riguarda la sua storia, la città, che sorge su un promontorio calcareo al centro del golfo dell’Asinara, stato un importante scalo commerciale gi in epoca fenicia e successivamente punica, anche se sono poche le tracce lasciate da queste popolazioni. Nonostante l’area geografica si presenti come una costa lineare e senza insenature utili per la realizzazione di un porto, l’isola dell’Asinara ripara questo tratto di mare dai venti predominanti di ponente e di maestrale, rendendo quindi l’area perfetta per un approdo marittimo. È quindi probabile che esistesse un legame tra l’isola dell’Asinara, che era chiamata l’isola di Ercole dai Romani, e il culto di Melqart, l’Ercole fenicio punico. I Fenici erano soliti frequentare le coste sarde poich composte da suolo fertile e ricche di minerali. Nei loro punti di approdo stabilivano piccoli mercati dove venivano scambiate le più svariate merci. Di queste installazioni alcune finivano per svilupparsi fino a diventare veri e propri villaggi e, secondo alcune teorie, questo ultimo passaggio avvenne proprio nel territorio di Porto Torres. Alcuni ammennicoli rinvenuti raffigurano il dio Bes, altri ritrovamenti sono una stele punica in tufo, una coppa greca del sesti secolo avanti Cristo, rasoi e varie vettovaglie.
 Durante il periodo della dominazione romana, viene probabilmente fondata con il nome di Turris Libisonis da Giulio Cesare, nel 46 avanti Cristo in occasione del suo soggiorno in Sardegna, o da Ottaviano, tramite il suo legato Marco Lurio. Comunque, dal 46 avanti Cristo viene elevata al rango di colonia di cittadini Romani, e dotata di numerosi edifici, quali templi, basiliche, terme e strade. Dalla sua fondazione, deriva anche il nome della vicina Regione, Romangia, da Romanìa, per l’elevato tasso di latinizzazione del territorio. Nel corso del tempo diviene uno dei più importanti scali marittimi dell’Isola, da dove vengono imbarcate le granaglie ed i prodotti agricoli che vanno ad alimentare il mercato dell’Urbe.
Durante il periodo della dominazione romana, viene probabilmente fondata con il nome di Turris Libisonis da Giulio Cesare, nel 46 avanti Cristo in occasione del suo soggiorno in Sardegna, o da Ottaviano, tramite il suo legato Marco Lurio. Comunque, dal 46 avanti Cristo viene elevata al rango di colonia di cittadini Romani, e dotata di numerosi edifici, quali templi, basiliche, terme e strade. Dalla sua fondazione, deriva anche il nome della vicina Regione, Romangia, da Romanìa, per l’elevato tasso di latinizzazione del territorio. Nel corso del tempo diviene uno dei più importanti scali marittimi dell’Isola, da dove vengono imbarcate le granaglie ed i prodotti agricoli che vanno ad alimentare il mercato dell’Urbe.
 In periodo romano l’abitato aveva una vasta area di necropoli, che è stata tradizionalmente suddivisa dagli studiosi in tre settori, ossia la necropoli meridionale o di San Gavino, la necropoli orientale o di Balai o dello Scoglio lungo, la necropoli occidentale o di Marinella. La distinzione ha, però, un valore solo indicativo che si riferisce alla zona in cui le sepolture sono venute alla luce rispetto al centro urbano, dato che si ritiene che la necropoli si estendesse senza soluzione di continuità, non è, quindi, possibile identificare un punto di separazione, specialmente per i settori meridionale e orientale, mentre quella occidentale è separata dalle altre dal letto del Rio Mannu. Durante il quinto secolo la Città viene assediata dai Vandali e successivamente dominata dai Bizantini, con il crollo dell’impero di Roma anch essa decade ed inizia a ripopolarsi solo nel decimo secolo.
In periodo romano l’abitato aveva una vasta area di necropoli, che è stata tradizionalmente suddivisa dagli studiosi in tre settori, ossia la necropoli meridionale o di San Gavino, la necropoli orientale o di Balai o dello Scoglio lungo, la necropoli occidentale o di Marinella. La distinzione ha, però, un valore solo indicativo che si riferisce alla zona in cui le sepolture sono venute alla luce rispetto al centro urbano, dato che si ritiene che la necropoli si estendesse senza soluzione di continuità, non è, quindi, possibile identificare un punto di separazione, specialmente per i settori meridionale e orientale, mentre quella occidentale è separata dalle altre dal letto del Rio Mannu. Durante il quinto secolo la Città viene assediata dai Vandali e successivamente dominata dai Bizantini, con il crollo dell’impero di Roma anch essa decade ed inizia a ripopolarsi solo nel decimo secolo.
 In seguito, nel periodo medioevale, grazie ai fiorenti rapporti commerciali con Genova e Pisa, riacquisisce l’antico lustro e diviene capitale del Giudicato di Logudoro, nome che deriva dal sardo Locu de Torres, prima del trasferimento della capitale a Sassari, per poi decadere in concomitanza con lo sviluppo di quest’ultima città. Governata dal giudice Barisone I di Lacon-Gunale, che fà insediare localmente i monaci Benedettini di montecassino, i quali contribuiscono alla bonifica e alla coltivazione delle sue terre. Dopo il succedersi di diversi giudici, nel 1200 subentra la famiglia dei Doria, che non solo prende il potere, ma incita anche i sassaresi alla rivolta contro i precedenti governatori. Sotto i Doria, però, il borgo decade a causa delle invasioni barbariche e delle guerre contro gli Aragonesi. In seguito alla dominazione aragonese, nel 1441 viene trasferita la sede dell’arcidiocesi da Porto Torres a Sassari, ed il paese perde la sua iniziale vitalità anche a causa della diffusione della malaria. Dipendente da Sassari per lungo tempo, divenne comune autonomo nel 1842. In epoca moderna, durante la prima metà del Novecento, all’economia prevalentemente legata all’agricoltura e in parte alla pesca, si aggiunge l’esportazione di minerali di ferro estratto nella vicina miniera di Canaglia, già utilizzata in età romana. Successivamente, vengono potenziate le strutture portuali e l’industria pesante, anche a danno del territorio circostante che ne risulta gravemente danneggiato.
In seguito, nel periodo medioevale, grazie ai fiorenti rapporti commerciali con Genova e Pisa, riacquisisce l’antico lustro e diviene capitale del Giudicato di Logudoro, nome che deriva dal sardo Locu de Torres, prima del trasferimento della capitale a Sassari, per poi decadere in concomitanza con lo sviluppo di quest’ultima città. Governata dal giudice Barisone I di Lacon-Gunale, che fà insediare localmente i monaci Benedettini di montecassino, i quali contribuiscono alla bonifica e alla coltivazione delle sue terre. Dopo il succedersi di diversi giudici, nel 1200 subentra la famiglia dei Doria, che non solo prende il potere, ma incita anche i sassaresi alla rivolta contro i precedenti governatori. Sotto i Doria, però, il borgo decade a causa delle invasioni barbariche e delle guerre contro gli Aragonesi. In seguito alla dominazione aragonese, nel 1441 viene trasferita la sede dell’arcidiocesi da Porto Torres a Sassari, ed il paese perde la sua iniziale vitalità anche a causa della diffusione della malaria. Dipendente da Sassari per lungo tempo, divenne comune autonomo nel 1842. In epoca moderna, durante la prima metà del Novecento, all’economia prevalentemente legata all’agricoltura e in parte alla pesca, si aggiunge l’esportazione di minerali di ferro estratto nella vicina miniera di Canaglia, già utilizzata in età romana. Successivamente, vengono potenziate le strutture portuali e l’industria pesante, anche a danno del territorio circostante che ne risulta gravemente danneggiato.
Nel 1960 Porto Torres viene elevata al rango di città
Dopo la costituzione della Repubblica Italiana, Porto Torres nel 1960 viene elevata da Giovanni Gronchi al rango di Città con Decreto del Presidente della Repubblica del 16 febbraio 1960.
In ricordo di Andrea Parodi
A Porto Torres mi sembra doveroso ricordare Andrea Parodi, per molto tempo voce del gruppo musicale Tazenda e successivamente solista dotato di voce particolarissima e ricca di sfumature.
Le principali feste e sagre che si svolgono a Porto Torres
A Porto Torres, tra le altre, sono attive l’Associazione Culturale Musicale Intragnas, e l’Associazione Culturale Etnos Gruppo Folk Li Bainzini, durante le cui esibizioni è possibile ammirare il costume tradizionale delle donne e degli uomini di Porto Torres. È attivo anche il Coro Polifonico Turritano, fondato a Porto Torres nel 1959 dal Maestro don Antonio Sanna che lo ha diretto per 37 anni, considerato uno tra i migliori cori amatoriali italiani.
Tra le principali principali feste e sagre che si svolgono a Porto Torres vanno citati la Festa di Sant’Antonio Abate il 16 e 17 gennaio, con l’accensione del falò la sera del 16; in occasione del carnevale, le manifestazioni del Carnevale in Centro; il 25 aprile, la Festa di Santu Bainzeddu, che è la Festa dei Massai ossia degli agricoltori, una giornata di celebrazione popolare all’insegna della spiritualità, della convivialità e delle tradizioni; a inizio giugno, la Sagra del pesce, una ricorrenza gastronomica molto attesa e partecipata che propone una grande frittura a base di pescato locale nell’ottica della promozione della cultura culinaria della zona; la Festha Manna, che è la festa dei Santi Gavino, Proto e Gianuario, che ha inizio il quarantacinquesimo giorno dopo Pasqua, si svolge la domenica di Pentecoste, e si conclude il lunedì successivo; il 10 giugno, la Festa della Madonna Consolata; a fine luglio o inzio agosto, le manifestazioni del Carnevale Estivo Turritano; a inizio dicembre, la Parata di Natale, che una delle manifestazioni del Natale Turritano, ossia del Natale a Porto Torres.
Iniziamo la visita di Porto Torres
L’abitato, interessato da forte espansione edilizia, si estende lungo la splendida costa dell’Asinara e sulle lievi ondulazioni dell’immediato entroterra. Iniziamo la visita della Città arrivando dalla Marina di Sorso alla rotonda dalla quale parte la via della Tramontana, dove si trova il cartello segnaletico che indica l’ingresso nell’abitato.
La chiesa parrocchiale dello Spirito Santo
Percorsa la via della Tramontana per settecento metri, prendiamo a sinistra la via della Libertà e la seguiamo per quattrocentocinquanta metri, per poi prendere verso sinistra la strada che, in un centinaio di metri, ci porta alla Chiesa dello Spirito Santo che è una nuova chiesa di Porto Torres, istituita come parrocchia nel 1974. Alcuni anni prima, don Salvatore Ruiu aveva iniziato l’opera pastorale nel cosiddetto Villaggio Satellite, un quartiere nato nella periferia di Porto Torres per ospitare le famiglie, che avevano subito diverse alluvioni nella zona prossima alla Basilica di San Gavino. Si trattava di giovani famiglie, in prevalenza operai, che avevano iniziato a popolare quella che sarebbe diventata la zona a maggior densità abitativa della cittа. Le prime attività liturgiche si iniziano a svolgere con grande entusiasmo in locali di ripiego, in scantinati, porticati delle case popolari o nelle piazze del quartiere. Nel 1993 il comune decide di destinare alla parrocchia una grande sala alla quale don Salvatore, con l’aiuto della comunità, riesce a donare le sembianze di una chiesa. Ed infine, il 19 giugno 2016, viene inaugurata la nuova chiesa, e nel suo braccio destro si possono distinguere sette aperture rivolte ad oriente che, opportunamente realizzate in maniera differente, ossia con una diversa policromia dei vetri, indicano i sette doni dello Spirito Santo. Esternamente il complesso è giuocato sulla contrapposizione del cemento armato, della pietra e delle superfici bianche che definiscono i volumi di abside, battistero e casa dal parroco. La facciata curva dell’edificio in cemento a faccia vista lisciato è caratterizzata da due setti rivestiti di pietra trachitica prominenti, quasi due braccia che accolgono i fedeli. Analogo setto in pietra trachitica costituisce un muro con funzione di campanile, che penetra nell’aula liturgica mettendo in relazione esterno ed interno, evidenziando alla sua sinistra il volume del Battistero, tagliato in spigolo da vetrate a tutta altezza, e scindendosi in tre pilastri simbolici dei tre martiri turritani sul cui culto si fonda la comunità locale.
Superato l’imponente portale in legno e bronzo, e l’atrio a bussola, lo sguardo abbraccia di fronte l’altare in asse con l’ingresso, e dietro a questo, sospeso sullo sfondo dell’abside, il Crocifisso. Guardando a sinistra verso il fondo dell’aula è l’elemento che evidenzia la dedicazione della chiesa, allo Spirito Santo, dato che su una parete ciclopica di metri otto per cinque di altezza a grandi blocchi di pietra di Orosei è rappresentata la Pentecoste, che scherma la manica lunga ove sono i locali adibiti alla pastorale. L’area presbiteriale, enfatizzata dalla parete curvilinea, moderna riproposizione dell’abside, è illuminata da una grande vetrata che riceve la luce da oriente.
Il Palazzetto dello Sport
Proseguendo per altri trecento metri lungo la via della Libertà, che lascia alla sua sinistra il Villaggio Satellite, prendiamo a destra il viale delle Vigne che si dirige verso nord ovest. Lo seguiamo per un’ottantina di metri poi svoltiamo a sinistra nella via Antonelli e, dopo centosettanta metri, di nuovo a sinistra nella via Palladio, nella quale dopo altri centosettanta metri, passata la piazza Walter Frau, si vede alla sinistra della strada, al civico numero 4, l’ingresso del Palazzetto dello Sport di Porto Torres'intestato ad Alberto Mura, atleta e organizzatore di eventi di boxe, scomparso nell’ottobre 2012.
All’interno del Palazzetto dello sport è presente un Campo sportivo polivalente, dotato di tribune in grado di ospitare 1200 spettatori, con fondo in materiali sintetici vari, nel quale è possibile praticare come discipline Calcetto ossia calcio a cinque, Ginnastica, Pallacanestro, e Pallavolo.
Gli impianti sportivi della Scuola Media Brunelleschi
Dal viale delle Vigne avevamo preso a sinistra la via Antonelli e, dopo centosettanta metri, avevamo preso a sinistra la via Palladio che ci aveva portati al Palazzetto dello Sport. Passata la via Palladio, proseguiamo ancora con la via Antonelli e, dopo centotrenta metri, prendiamo a sinistra la via Filippo Brunelleschi, lungo la quale, dopo poco più di un centinaio di metri, si vede alla sinistra della strada l’ingresso dellla Scuola Media Brunelleschi.
Il nuovo Campo Sportivo di Porto Torres
 Da dove con la via della Libertà eravamo arrivati nel viale delle Vigne, lo seguiamo invece verso sinistra in direzione sud est e, in cinquecento metri, arrivimo al parcheggio in piazza Cagliari 1970, intitolata allo scudetto ottenuto grazie a Gigi Riva, nella quale si trova l’ingresso degli impianti del Nuovo Campo Sportivo di Porto Torres. Questi impianti comprendono il Campo da Calcio, con fondo in erba naturale, dotato di tribune in grado di ospitare 3.000 spettatori. La squadra di calcio principale, il Porto Torres calcio, dopo aver militato per alcuni anni in Serie D, è retrocessa nel campionato di Eccellenza al termine della stagione 2013-14, e in quello di Promozione al termine della stagione successiva. A livello giovanile si distinguono la Polisportiva Dilettantistica Quartieri Riuniti e la S.G.S. Turritana. Intorno al campo da gioco, è presente una Pista di altetica, nella quale è possibile praticare come discipline Atletica leggera, Corse su pista, Salto in alto, Salti in estensione, Salto con l’asta, Lancio del disco, Lancio del peso, Lancio del martello, e Lancio del giavellotto.
Da dove con la via della Libertà eravamo arrivati nel viale delle Vigne, lo seguiamo invece verso sinistra in direzione sud est e, in cinquecento metri, arrivimo al parcheggio in piazza Cagliari 1970, intitolata allo scudetto ottenuto grazie a Gigi Riva, nella quale si trova l’ingresso degli impianti del Nuovo Campo Sportivo di Porto Torres. Questi impianti comprendono il Campo da Calcio, con fondo in erba naturale, dotato di tribune in grado di ospitare 3.000 spettatori. La squadra di calcio principale, il Porto Torres calcio, dopo aver militato per alcuni anni in Serie D, è retrocessa nel campionato di Eccellenza al termine della stagione 2013-14, e in quello di Promozione al termine della stagione successiva. A livello giovanile si distinguono la Polisportiva Dilettantistica Quartieri Riuniti e la S.G.S. Turritana. Intorno al campo da gioco, è presente una Pista di altetica, nella quale è possibile praticare come discipline Atletica leggera, Corse su pista, Salto in alto, Salti in estensione, Salto con l’asta, Lancio del disco, Lancio del peso, Lancio del martello, e Lancio del giavellotto.
Sono presenti anche il Campo da Calcio numero 2, con fondo in terra battuta, dotato di tribune in grado di ospitare 150 spettatori; ed il Campo da calcio numero 3, con fondo in materiali cementizi, dotato anch’esso di tribune per 150 spettatori.
All’interno di questo complesso sportivo è presente anche una Palestra al chiuso, senza tribune per gli spettatori, nella quale è possibile praticare diverse discipline, tra le quali soprattutto il pugilato.
Gli impianti sportivi della Scuola Elementare Bellieni
Entrati in piazza Cagliari 1970, la percorriamo tutta svoltando a sinistra ed entriamo nella piazza don Milani, la principale piazza del Villaggio Satellite, che si trova a sud est rispetto alla chiesa parrocchiale dello Spirito Santo. Nella piazza don Milani si affaccia la Scuola Elementare Bellieni del Villaggio Satellite.
All’interno di questo complesso scolastico è ospitata una Palestra, dotata di tribune in grado di ospitare quasi centocinquanta spettatori, nella quale è possibile praticare come discipline la Pallacanestro e la Pallavolo. Ed inoltre, accanto alla palestra, è presente anche un Campo da calcetto, ossia da calcio a cinque, dotato di tribune in grado di ospitare circa un centinaio di spettatori.
Gli impianti sportivi del Tennis Club Porto Torres
Raggiunta con la via delle Vigne la piazza Cagliari 1970, proseguiamo verso sud est lungo la via delle Vigne e, dopo circa trecento metri, arriviamo a una rotonda, dove prendiamo la prima uscita che ci porta in via dei Corbezzoli, lungo la quale, dopo un centinaio di metri si vede alla sinistra l’ingresso degli impianti sportivi del Tennis Club Porto Torres.
All’interno di questo complesso sportivo sono presenti quattro Campi da tennis, dei quali due coperti, un Campo da Mini tennis, una PAlestrina, e le strutture accessorie oltre a un’ampia area verde per il relax.
L’importante Hotel Libyssonis con i suoi impianti sportivi
Dalla piazza Cagliari 1970 continuiamo lungo la prosecuzione del viale delle Vigne, fino a una rotonda dove prendiamo la seconda uscita, che è la via dei Corbezzoli, percorsi centosettanta metri svoltiamo a destra in via del Lentischio, dove, dopo un’ottantina di metri, alla sinistra della strada si trova l’Hotel Libyssonis, un altro Hotel nel quale abbiamo soggiornato nelle nostre permanenze a Porto Torres.
All’interno della struttura dell’Hotel Libyssonis sono presenti diversi impianti sportivi. La Piscina dell’Hotel Libyssonis è costituita da due impianti, una piccola piscina esterna vicina all’ingresso, ed una grande piscina interna, non dotata di tribune, nella quale è possibile praticare nuoto in tutti gli stili. Nella Palestra interna dell’Hotel Libyssonis, anch’essa senza tribune, è possibile praticare diverse attività ginnico motorie.
La chiesa parrocchiale dedicata al Cristo Risorto
Dalla via della Libertà, dove avevamo preso a sinistra la strada che ci aveva condotti fino alla chiesa dello Spirito Santo, prendiamo ora, invece, verso destra la via Sandro Pertini e la seguiamo per settecento metri, fino a che questa strada sbocca sulla via Balai, dove alla destra si sviluppa la piazza Fancesco Petrarca. Alla destra di questa piazza, nel largo David Maria Turoldo, si trova la Chiesa del Cristo Risorto che è un’altra delle nuove chiesa parrocchiali di Porto Torres realizzata per soddisfare le esigense degli abitanti del quartiere Borgona. La prima pietra della nuova chiesa parrocchiale è stata posta nel 1970. Il progetto originario, redatto dal geometra Francesco Parodi, aveva subito alcune modifiche.
Il Cristo sopra l’altare è opera dello scultore e ceramista Giuseppe Silecchia, nato a Porto Azzurro nel 1927, che si trasferisce a Sassari con la famiglia durante la prima adolescenza. All’interno della chiesa è possibile ammirare sette dipinti, sei dei quali realizzati da una compagine di artisti di Porto Torres, nata nei primi anni settanta del Novecento, denominata Gruppo dei 7 e formata da sei pittori e da un fotografo. Del gruppo facevano parte i pittori Pia Ruggiu, Vittorio Cardone, Antonio Schiaffino, Paolo Battistella, Lino Proli, Ignazio Rum e il fotografo e serigrafico Maurizio Ruzzeddu. Oltre a un altro dipinto nella cappella alla sinistra dell’altare e un quadro eseguito in tempi recenti da un giovane pittore di Porto Torres.
È del 2024 l’inaugurazione dell’opera d’arte pittorica Verbo Dipinto, che attraverso i quattro evangelisti racconta la storia di Gesù, un’opera di trenta metri che scorre lungo le pareti della navata, realizzata dall’artista sassarese Jacopo Scassellati.
Il Cimitero Comunale di Porto Torres
Presa dalla via Balai, alla sinistra della chiesa del Cristo Risorto, la via Lodovico Ariosto, la seguiamo per un centinaio di metri, poi prendiamo a destra la via Romagnosi, che conduce verso est e proseguirà fino a portarci all’incrocio con la via Benedetto Croce, che è la prosecuzione della via della Tramontana. Percorsa la via Romagnosi per appena poco più di un centinaio di metri, vediamo alla destra della strada l’ingresso del Cimitero di Porto Torres, che si sviluppa tra la via Romagnosi a nord, e la via Balai a sud.
La palestra dell’Istituto Comprensivo N.1
Dalla chiesa parrocchiale del Cristo Risorto, prendiamo la via Balai che si dirige verso sud ovest, la seguiamo e, dopo circa duecentoquaranta metri, arriviamo a una rotonda dove prendiamo la prima uscita, che ci porta sulla via Principe di Piemonte che si dirige verso nord, lungo la quale, dopo circa duecento metri alla destra, in corrispondenza dei civici numero 27 e 29, si trova la sede dell’Istituto Comprensivo N.1 di Porto Torres.
Questo complesso, all’interno del quale sono presenti diversi istituti scolastici, dispone di una Palestra che non dispone di tribune, che contiene un campo sportivo polivalente nel quale è possibile praticare come discipline la Pallacanestro e la Pallavolo.
Il Teatro Comunale Andrea Parodi
 Dalla via Balai, arrivati alla rotonda, prendiamo ora la terza uscita che ci porta sulla via Principe di Piemonte che si dirige verso sud, dopo una quarantina di metri svoltiamo a destra e prendiamo la via Giacomo Matteotti. Percorsa una settantina di metri si vede alla destra della strada, al civico numero 77, il Teatro Comunale Andrea Parodi. La struttura, nata inizialmente come cinema, è stata edificata da privati all’inizio degli anni settanta del Novecento per ospitare spettacoli, concerti e proiezioni cinematografiche. Denominato inizialmente Teatro Olimpia, è stato in seguito intitolato alla memoria del celebre cantante Andrea Parodi, nato a Porto Torres nel 1955. Di proprietà del comune di Porto Torres, ospita regolarmente attività culturali polivalenti e spettacoli dal vivo.
Dalla via Balai, arrivati alla rotonda, prendiamo ora la terza uscita che ci porta sulla via Principe di Piemonte che si dirige verso sud, dopo una quarantina di metri svoltiamo a destra e prendiamo la via Giacomo Matteotti. Percorsa una settantina di metri si vede alla destra della strada, al civico numero 77, il Teatro Comunale Andrea Parodi. La struttura, nata inizialmente come cinema, è stata edificata da privati all’inizio degli anni settanta del Novecento per ospitare spettacoli, concerti e proiezioni cinematografiche. Denominato inizialmente Teatro Olimpia, è stato in seguito intitolato alla memoria del celebre cantante Andrea Parodi, nato a Porto Torres nel 1955. Di proprietà del comune di Porto Torres, ospita regolarmente attività culturali polivalenti e spettacoli dal vivo.
La Torre civica con le strutture del Porto commerciale
Arrivando da Platamona, iniziamo la visita del centro storico della Città arrivando alla rotonda dalla quale parte la via della Tramontana, dove si trova il cartello segnaletico che indica l’ingresso nell’abitato.
Il Porto commerciale e Turistico
 Percorsa per settecento metri, la via della Tramontana prosegue sulla via Benedetto Croce, che, in seicento metri, ci porta sul lungomare di Balai. Preso verso sinistra, il lungomare di Balai ci porta, in circa ottocento metri, direttamente davanti al Porto commerciale, chiamato anche Porto civico, destinato alle navi Ro/Ro ossia Roll-on/Roll-off, ossia navi da carico specializzate nel trasporto di veicoli e merci su ruote, passeggeri e merci e al traffico da diporto. Nel secondo dopoguerra sono stati effettuati significativi lavori di modifica e adeguamento del porto cittadino, lavori che sono terminati solo nei primi anni del duemila. Fino a qualche anno fa attraccavano qui anche tutti i traghetti provenienti dal continente, che ora tendono ad approdare il porto Industriale.
Percorsa per settecento metri, la via della Tramontana prosegue sulla via Benedetto Croce, che, in seicento metri, ci porta sul lungomare di Balai. Preso verso sinistra, il lungomare di Balai ci porta, in circa ottocento metri, direttamente davanti al Porto commerciale, chiamato anche Porto civico, destinato alle navi Ro/Ro ossia Roll-on/Roll-off, ossia navi da carico specializzate nel trasporto di veicoli e merci su ruote, passeggeri e merci e al traffico da diporto. Nel secondo dopoguerra sono stati effettuati significativi lavori di modifica e adeguamento del porto cittadino, lavori che sono terminati solo nei primi anni del duemila. Fino a qualche anno fa attraccavano qui anche tutti i traghetti provenienti dal continente, che ora tendono ad approdare il porto Industriale.
Il Porto commerciale si sviluppa intorno ad un’insenatura, nella quale a delimitare verso est il bacino del Porto commerciale si trova la banchina di Levante, chiamata anche banchina alti fondali. Nell’ultimo decennio sulla banchina si sono effettuati lavori per l’adattamento della stessa alle nuove grandi navi. A lavori ultimati sarà la banchina destinata all’attracco delle navi da crociera. Più ad ovest si sviluppa la parte più vecchia del porto, con la banchina del molo antico. Questa porzione risale all’epoca romana e, successivamente, è stata utilizzata come scalo durante il Regno di Sardegna. In seguito il molo è stato attrezzato per l’imbarco di minerali ferrosi che, per mezzo di una teleferica, venivano trasportati fino ad esso dalle torri poste sul fiume. Per questo motivo la parte ovest del molo antico è chiamata banchina della teleferica. Su quest'ultima sorge il palazzo della sanità marittima e, a breve, si svilupperà anche il mercato ittico. Attualmente vi attracca il traghetto per l’isola dell’Asinara. Mentre la parte est del molo antico viene chiamata banchina dogana o banchina Segni. L’estremità massima del Porto commerciale verso ovest è chiamata banchina di ponente. Attualmente sono in corso lavori di ampliamento che, terminati i quali, consentiranno l’ormeggio di tre navi di grosse dimensioni. Uno dei tre moli consentirà di attraccare navi di dimensioni superiori ai 300 metri di lunghezza.
All’interno del Porto commerciale, ad ovest rispetto alla banchina di Levante, si sviluppa anche il Porto turistico, che la parte del porto dove ormeggiano i pescherecci della marineria locale e le barche da diporto. Dispone di approdi per 400 barche di fino a quaranta metri di lunghezza, è dotato di un circolo nautico e dispone in banchina di tutti i principali servizi, come acqua, elettricit e servizi igienici.
La Torre del Porto chiamata comunemente la Torre Aragonese
Nella nostra visita della Città partiamo, quindi, dal Porto commerciale. All’uscita del porto possiamo ammirare la ben conservata Torre del Porto, chiamata comunemente la Torre Aragonese, situata a due metri di altezza sul mare nella piazza Cristoforo Colombo, che è considerata uno dei monumenti simbolo del territorio. Edificata in epoca spagnola, probabilmente nel 1325 per volontà dell’ammiraglio aragonese Carroz, che aveva conquistato il territorio in quel periodo. Aveva la funzione di avvistamento e di protezione del centro cittadino, situato, all’epoca, nella zona di Monte Agellu. Ha una struttura in calcare, è alta circa quattordici metri e larga tredici, completamente intonacata, ed è unica nel suo genere perché non si tratta di una torre circolare, come le altre, ma ha una forma ottagonale. Si sviluppa su tre livelli, l’ultimo dei quali una terrazza con caditoie. Il piano terra si compone di due camere, con una complessa volta a nervature ed un pilastro centrale. Al secondo piano si arriva con una scala all’interno della sala, ed al terrazzo con una scala interna alla muratura. L’edificio è stato adibito nei secoli a diverse funzioni, come sede doganale, baluardo contro gli attacchi barbareschi, controllo sanitario e faro.
Il 7 gennaio 2010 un gruppo di lavoratori cassintegrati della Vinyls e disoccupati dell’Eurocoop hanno preso possesso della torre Aragonese di Porto Torres, seguiti il 25 febbraio da un altro gruppo che ha preso possesso della diramazione centrale del vecchio carcere, a Cala d’Oliva sull’isola Asinara. Da quel giorno sono rimasti sull’isola e sul presidio per 17 mesi, fino a quando il 6 giugno 2011 una commissione di operai è stata ricevuta dal Presidente della Repubblica, ed ha posto così termine all’occupazione dell’isola e smobilitato il presidio sulla Torre di Porto Torres. Dopo di che sono rimasti in attesa di un incontro col governo, ma senza troppe illusioni. Alla loro simbolica occupazione è dedicata una lapide posta di fronte alla torre, e che abbiamo fotografato per ricordare il loro sforzo ed i loro sacrifici.
Vicino alla Torre Aragonese si trovava la stazione ferroviaria di Porto Torres piazza Cristoforo Colombo
 Il vecchio capolinea della tratta ferroviaria realizzata nel 1872 come collegamento diretto tra la rete delle Ferrovie dello Stato ed il Porto commerciale e turistico, si trovava nella Stazione di Porto Torres piazza Cristoforo Colombo, che era situata dove il corso Vittorio Emanuele termina nella piazza, nei pressi della Torre Aragonese. Le origini dello scalo risalgono agli anni trenta del Novecento, quando le Ferrovie dello Stato decidono di affiancare allo scalo di Porto Torres Marittima una fermata che permetta di espletare il servizio viaggiatori a breve distanza dagli approdi dei traghetti. Come sede viene scelta l’area compresa tra i vecchi uffici della dogana e la torre costiera, e il nuovo impianto viene attivato nel 1937. Nel dopoguerra la fermata di Porto Torres Piazza Cristoforo Colombo continua ad essere impiegata per i servizi viaggiatori, ed in particolare diviene il capolinea settentrionale del Turritano, il treno espresso che collega sino agli anni novanta il nord ovest della Sardegna con Cagliari. Nell’ultimo quarto del secolo l’impianto diviene anche il termine della ferrovia dopo la dismissione dei binari che portano a Porto Torres Marittima. Nel 2004, la volont di riqualificare l’area della Torre Aragonese porta alla scelta di dismettere la fermata di piazza Cristoforo Colombo, le cui strutture vengono smantellate per consentire i lavori di riqualificazione dell’area.
Il vecchio capolinea della tratta ferroviaria realizzata nel 1872 come collegamento diretto tra la rete delle Ferrovie dello Stato ed il Porto commerciale e turistico, si trovava nella Stazione di Porto Torres piazza Cristoforo Colombo, che era situata dove il corso Vittorio Emanuele termina nella piazza, nei pressi della Torre Aragonese. Le origini dello scalo risalgono agli anni trenta del Novecento, quando le Ferrovie dello Stato decidono di affiancare allo scalo di Porto Torres Marittima una fermata che permetta di espletare il servizio viaggiatori a breve distanza dagli approdi dei traghetti. Come sede viene scelta l’area compresa tra i vecchi uffici della dogana e la torre costiera, e il nuovo impianto viene attivato nel 1937. Nel dopoguerra la fermata di Porto Torres Piazza Cristoforo Colombo continua ad essere impiegata per i servizi viaggiatori, ed in particolare diviene il capolinea settentrionale del Turritano, il treno espresso che collega sino agli anni novanta il nord ovest della Sardegna con Cagliari. Nell’ultimo quarto del secolo l’impianto diviene anche il termine della ferrovia dopo la dismissione dei binari che portano a Porto Torres Marittima. Nel 2004, la volont di riqualificare l’area della Torre Aragonese porta alla scelta di dismettere la fermata di piazza Cristoforo Colombo, le cui strutture vengono smantellate per consentire i lavori di riqualificazione dell’area.
Sul lungomare in piazza Cristoforo Colombo si trova l’Hotel Elisa
Affacciato sulla piazza Cristoforo Colombo, di fronte alla torre Aragonese, al civico numero 6 della via del Mare e ad angolo con il corso Vittorio Emanuele II, si trova l’Hotel Elisa, una buona sistemazione per chi arriva a Porto Torres per imbarcarsi verso il continente, nel quale abbiamo soggiornato spesso nelle nostre permanenze a Porto Torres.
Il Museo del Porto
 Proprio di fronte all’uscita del Porto, passata la piazza Cristoforo Colombo, si sviluppa la XX Settembre, alla destra della quale si trova la piazza della Dogana, dove è presente l’imbarco dei traghetti per l’isola Asinara. Da questa piazza parte la via Antonietta Bassu, che segue la costa verso ovest, ed in questa via, alla sinistra al civico numero 1, è presente il Museo del Porto, fondato nel 2008 da Assovela Porto Torres. L’edificio che ospita il Museo del Porto, conosciuto nel passato col nome di Stazione della Piccola, è un tipico stabile industriale dei primi anni del Novecento e faceva parte delle strutture della vecchia ferrovia inaugurata nel 1872. Il suo nome derivava del fatto che la stazione era nata come ufficio spedizioni e magazzino per per le merci non deperibili, che potevano viaggiare a piccola velocit . Il Museo del Porto vuole essere un contributo per la conservazione della memoria della Città portuale attraverso una raccolta di immagini, filmati e testimonianze, che documentano prima e seconda metà del Novecento, i cambiamenti sociali, e lo sviluppo del porto turritano. Le proiezioni e il plastico centrale sono racchiusi da vetrate con la forma dello scafo di una nave. Il plastico riproduce l’abitato di Porto Torres nel primo Novecento, e il Porto industriale del secondo Novecento.
Proprio di fronte all’uscita del Porto, passata la piazza Cristoforo Colombo, si sviluppa la XX Settembre, alla destra della quale si trova la piazza della Dogana, dove è presente l’imbarco dei traghetti per l’isola Asinara. Da questa piazza parte la via Antonietta Bassu, che segue la costa verso ovest, ed in questa via, alla sinistra al civico numero 1, è presente il Museo del Porto, fondato nel 2008 da Assovela Porto Torres. L’edificio che ospita il Museo del Porto, conosciuto nel passato col nome di Stazione della Piccola, è un tipico stabile industriale dei primi anni del Novecento e faceva parte delle strutture della vecchia ferrovia inaugurata nel 1872. Il suo nome derivava del fatto che la stazione era nata come ufficio spedizioni e magazzino per per le merci non deperibili, che potevano viaggiare a piccola velocit . Il Museo del Porto vuole essere un contributo per la conservazione della memoria della Città portuale attraverso una raccolta di immagini, filmati e testimonianze, che documentano prima e seconda metà del Novecento, i cambiamenti sociali, e lo sviluppo del porto turritano. Le proiezioni e il plastico centrale sono racchiusi da vetrate con la forma dello scafo di una nave. Il plastico riproduce l’abitato di Porto Torres nel primo Novecento, e il Porto industriale del secondo Novecento.
Il Museo oggi ospita la Mostra dedicata alla vela latina, denominata La cultura turritana del mare, con modellini di barche e strumenti molto antichi usati per la costruzione delle imbarcazioni a vela latina. Queste ultime, infatti, sono la memoria della tradizione marinaresca della citt e della sua antica economia, una memoria da salvaguardare e tramandare, essendo stato il motore trainante dell’economia turritana fino al 1950 circa. Nella Mostra è esposta una vera filuga portotorrese circondata da modellini di barche, strumenti e macchinari antichi per la costruzione di imbarcazioni.
Il Museo ospita anche il Memoriale della Corazzata Roma e delle navi Vivaldi e Da Noli, per ricordare i circa 1700 uomini di mare che morirono in seguito all’affondamento delle tre imbarcazioni nel Golfo dell’Asinara, il 9 settembre del 1943.
Di fronte al Museo del Porto si trova l’incompiuto Terminal Crociere
 Di fronte al Museo del Porto, alla destra della via Antonietta Bassu, si può vedere il Terminal Crociere, una tensostruttura che rappresenta una delle opere incompiute più datate, la cui funzionalità resta ancora tutta da chiarire. Lavori a singhiozzo, interrotti anche per lunghi periodo e poi ripresi, un andazzo andato avanti così per una diecina di anni. Il terminal passeggeri, in costruzione presso lo scalo di Porto Torres, continua a far discutere. Non solo per sua forma paragonata ad una stazione spaziale che male si sposa con le restanti opere infrastrutturali del porto, ma anche perché i lavori per la realizzazione dell’edificio iniziati nel 2010 procedono a rilento, e a distanza di oltre dieci anni resta ancora una incompiuta di cui non si conosce la vera destinazione. L’opera era stata finanziata per creare un naturale ricongiungimento tra il porto civico e la stazione marittima, realizzata però al di fuori dall’area demaniale di competenza Comunale.
Di fronte al Museo del Porto, alla destra della via Antonietta Bassu, si può vedere il Terminal Crociere, una tensostruttura che rappresenta una delle opere incompiute più datate, la cui funzionalità resta ancora tutta da chiarire. Lavori a singhiozzo, interrotti anche per lunghi periodo e poi ripresi, un andazzo andato avanti così per una diecina di anni. Il terminal passeggeri, in costruzione presso lo scalo di Porto Torres, continua a far discutere. Non solo per sua forma paragonata ad una stazione spaziale che male si sposa con le restanti opere infrastrutturali del porto, ma anche perché i lavori per la realizzazione dell’edificio iniziati nel 2010 procedono a rilento, e a distanza di oltre dieci anni resta ancora una incompiuta di cui non si conosce la vera destinazione. L’opera era stata finanziata per creare un naturale ricongiungimento tra il porto civico e la stazione marittima, realizzata però al di fuori dall’area demaniale di competenza Comunale.
La Stazione Marittima Nino Pala
Dopo il Museo del Porto, proseguendo con la via Antonietta Bassu verso ovest per poco più di un centinaio di metri, al civico numero 6, si raggiunge la Stazione Marittima di Porto Torres, davanti alla quale è presente l’imbarco traghetti per l’isola Asinara. La Stazione Marittima è stata intestata al palombaro Antonio detto Nino Pala, che apparteneva a una famiglia di palombari, lavoro difficile ma sempre fatto con amore e perizia dopo il conseguimento della specializzazione quando faceva il militare nella scuola di La Spezia, e che il 3 luglio del 1950, durante i lavori di sistemazione della banchina antistante la nuova stazione marittima, cadeva prematuramente sul lavoro subacqueo all’età di 26 anni.
La Stazione Marittima si trova in posizione baricentrica rispetto alla stazione ferroviaria e alle banchine di ormeggio dei traghetti che servono i collegamenti in regime di continuità territoriale con la Penisola e il collegamento regionale con l’isola Asinara.
I resti del Porto antico di Turris Libisonis
 Nell’area al di sotto della gradonata tra il molo sud e la Stazione Marittima, grazie alle indagini della Soprintendenza per i Beni Archeologici nei primi anni duemila, sono state rinvenute diverse strutture di epoca romana, che costituiscono i resti del Porto antico di Turris Libisonis, collegabili alle attività dell’importante stuttura portuale della colonia di Turris Libisonis. Queste includono costruzioni portuali, edifici con pavimenti a mosaico, impianti di canalizzazione, pozzi e resti della rete stradale che collegava il porto con i settori urbani, i magazzini, i quartieri artigianali e commerciali e le ville rurali dell’antica Turris Libisonis. Un’area espositiva è stata creata per proteggere e mostrare i reperti ai visitatori, la quale di recente è stata utilizzata anche per mostre temporanee d’arte e diverse iniziative culturali. Il progetto di valorizzazione prevede un percorso lungo una passerella in legno, vetrine per reperti trovati durante i lavori, e spazi per manufatti più grandi. Altre scoperte sono state fatte durante la costruzione di nuove strade tra i moli. L’area è stata utilizzata per mostre ed eventi.
Nell’area al di sotto della gradonata tra il molo sud e la Stazione Marittima, grazie alle indagini della Soprintendenza per i Beni Archeologici nei primi anni duemila, sono state rinvenute diverse strutture di epoca romana, che costituiscono i resti del Porto antico di Turris Libisonis, collegabili alle attività dell’importante stuttura portuale della colonia di Turris Libisonis. Queste includono costruzioni portuali, edifici con pavimenti a mosaico, impianti di canalizzazione, pozzi e resti della rete stradale che collegava il porto con i settori urbani, i magazzini, i quartieri artigianali e commerciali e le ville rurali dell’antica Turris Libisonis. Un’area espositiva è stata creata per proteggere e mostrare i reperti ai visitatori, la quale di recente è stata utilizzata anche per mostre temporanee d’arte e diverse iniziative culturali. Il progetto di valorizzazione prevede un percorso lungo una passerella in legno, vetrine per reperti trovati durante i lavori, e spazi per manufatti più grandi. Altre scoperte sono state fatte durante la costruzione di nuove strade tra i moli. L’area è stata utilizzata per mostre ed eventi.
La Stazione ferroviaria di Porto Torres Marittima
Dall’ingresso della Stazione Marittima, proseguendo dopo una settantina di metri la via Antonietta Bassu termina sboccando sulla via del Ponte Romano. Se la prendiamo verso sinistra, dopo un’altra settantina di metri si vede alla destra della strada la Stazione di Porto Torres Marittima, una fermata ferroviaria al servizio del comune di Porto Torres, capolinea della linea ferroviaria che la collega con Ozieri Chilivani. La linea ferroviaria, della quale questa con il nome di Stazione di Porto Torres era la stazione terminale, è nata nella seconda metà del diciannovesimo secolo, ad opera della Compagnia Reale delle Ferrovie Sarde, che ha completato la tratta tra il 1872, anno di apertura del collegamento tra Sassari e Porto Torres, e il 1874, con l’apertura della tratta tra Ozieri in seguito identificata col nome della frazione Chilivani, e Ploaghe. L’importanza di questo collegamento è stato sottolineata da un viaggio in treno, tra Cagliari e Sassari, di Re Umberto I e della Regina Margherita nel 1899. Nel 1920 la gestione passa al gruppo delle Ferrovie dello Stato, che tra l’altro 1937 decidono di affiancare allo scalo di Porto Torres Marittima la Stazione di piazza Cristoforo Colombo, vicino alla Torre Aragonese, che permetta di espletare il servizio viaggiatori a breve distanza dagli approdi dei traghetti. Lo scalo continua ad essere usato con regolarit , venendo sostituito da un nuovo impianto nel 1991, quando nella zona di Fontana Vecchia viene inaugurata la nuova Stazione di Porto Torres, e viene quindi dismesso nel decennio successivo. Anche la fermata in piazza Cristoforo Colombo viene dismessa nel 2004, e le sue strutture vengono smantellate per consentire i lavori di riqualificazione dell’area.
La stazione in via del Porto Romano viene, poi, riattivata nel dicembre 2016 con il nome di Stazione di Porto Torres Marittima, essendo posta dinanzi ai vicini locali della stazione marittima turritana, mentre l’impianto nella zona di Fontana Vecchia che è la principale stazione di Porto Torres, per evitare possibili equivoci, viene rinominata Stazione di Porto Torres Centrale.
Il Faro di Porto Torres
 Passata la Stazione di Porto Torres Marittima, procediamo in direzione sud con la via del Ponte Romano per poco più di un centinaio di metri, poi svoltiamo a destra e prendiamo la via delle Terme che, dopo una settantina di metri, incrocia la via Petronia. Svoltiamo a destra e procediamo in direzione ovest con la via Petronia che, dopo quasi duecento metri, termina ad angolo con la via Mario Paglietti. Di fronte a noi alla destra si vede il Faro di Porto Torres, il cui indirizzo è al civico numero 17 della via Mario Paglietti. Si tratta di un Faro a ottica fissa con funzione di segnalamento marittimo, costituito da una torretta su un edificio a due piani bianco. Oggi il faro si erge su una collina che domina la zona occidentale della Città di fronte al porto. Il segnalamento marittimo era collocato precedentemente sulla Torre Aragonese, a pianta ottagonale, situata presso l’area portuale.
Passata la Stazione di Porto Torres Marittima, procediamo in direzione sud con la via del Ponte Romano per poco più di un centinaio di metri, poi svoltiamo a destra e prendiamo la via delle Terme che, dopo una settantina di metri, incrocia la via Petronia. Svoltiamo a destra e procediamo in direzione ovest con la via Petronia che, dopo quasi duecento metri, termina ad angolo con la via Mario Paglietti. Di fronte a noi alla destra si vede il Faro di Porto Torres, il cui indirizzo è al civico numero 17 della via Mario Paglietti. Si tratta di un Faro a ottica fissa con funzione di segnalamento marittimo, costituito da una torretta su un edificio a due piani bianco. Oggi il faro si erge su una collina che domina la zona occidentale della Città di fronte al porto. Il segnalamento marittimo era collocato precedentemente sulla Torre Aragonese, a pianta ottagonale, situata presso l’area portuale.

 Il progetto del faro è stato commissionato nel 1959 dalla Marina Militare Italiana all’ingegner Vivanetà dell’Ufficio del Genio Civile Opere Marittime di Cagliari, ed il faro è stato realizzato dal 1960 al 1965. Il Faro e la vecchia Dogana sono stati raffigurate in un dipinto del pittore argentino Héctor Nava, nato a Buenos Aires nel 1873, il quale tra il 1920 e il 1923 soggiornò in Sardegna visitando anche Porto Torres. Il pittore rimase colpito dal Faro e nel 1921 rappresentò in un suo dipinto una veduta di Porto Torres, con il faro e la vecchia dogana. Il torrione, che appare oggi isolato all’interno di uno spazio anonimo e irrisolto, dopo la sconsiderata demolizione dell’elegante edificio della dogana, era allora ad esso legato da una settecentesca addizione a scalettatura.
Il progetto del faro è stato commissionato nel 1959 dalla Marina Militare Italiana all’ingegner Vivanetà dell’Ufficio del Genio Civile Opere Marittime di Cagliari, ed il faro è stato realizzato dal 1960 al 1965. Il Faro e la vecchia Dogana sono stati raffigurate in un dipinto del pittore argentino Héctor Nava, nato a Buenos Aires nel 1873, il quale tra il 1920 e il 1923 soggiornò in Sardegna visitando anche Porto Torres. Il pittore rimase colpito dal Faro e nel 1921 rappresentò in un suo dipinto una veduta di Porto Torres, con il faro e la vecchia dogana. Il torrione, che appare oggi isolato all’interno di uno spazio anonimo e irrisolto, dopo la sconsiderata demolizione dell’elegante edificio della dogana, era allora ad esso legato da una settecentesca addizione a scalettatura.
Visita del centro storico
Proprio di fronte all’uscita del Porto, passata la piazza XX Settembre, inizia il Corso Vittorio Emanuele II che è la denominazione che assume all’interno del centro abitato la SS131 di Carlo Felice, la quale si dirige verso sud ovest ed è la principale strada commerciale della città. In essa, come sul lungomare davanti al Porto commerciale, si svolge la passeggiata serale degli abitanti e dei turisti che visitano in gran numero la città.
Verso il centro della città
 Lungo il corso Vittorio Emanuele si trovano numerose agenzie turistiche ed agenzie marittime, oltre a bar, pasticcerie, ristoranti e negozi. Al civico numero 18 e 20 si trova la sede della Banca Nazionale del Lavoro, sotto la quale si conservano resti dell’abitato antico, venuti in luce nei saggi effettuati negli anni 1978 e 1979, sotto la direzione di Françoise Villedieu, in occasione dei lavori di ricostruzione della sede del palazzo. Gli scavi hanno messo in luce gli horrea, ossia i magazzini pubblici annonari realizzati agli inizi del terzo secolo ed utilizzati sicuramente per immagazzinare le merci in arrivo. Questi edifici, probabilmente provvisti di copertura lignea, ospitavano notevoli quantità di anfore contenenti vino, olio ed altri prodotti importati a Turris Libisonis e destinati alla vendita locale.
Lungo il corso Vittorio Emanuele si trovano numerose agenzie turistiche ed agenzie marittime, oltre a bar, pasticcerie, ristoranti e negozi. Al civico numero 18 e 20 si trova la sede della Banca Nazionale del Lavoro, sotto la quale si conservano resti dell’abitato antico, venuti in luce nei saggi effettuati negli anni 1978 e 1979, sotto la direzione di Françoise Villedieu, in occasione dei lavori di ricostruzione della sede del palazzo. Gli scavi hanno messo in luce gli horrea, ossia i magazzini pubblici annonari realizzati agli inizi del terzo secolo ed utilizzati sicuramente per immagazzinare le merci in arrivo. Questi edifici, probabilmente provvisti di copertura lignea, ospitavano notevoli quantità di anfore contenenti vino, olio ed altri prodotti importati a Turris Libisonis e destinati alla vendita locale.
Una fermata in una pasticceria di qualità
Arrivati a Porto Torres, come ogni anno ci permettevamo una concessione alla golosità. Proprio all’inizio del corso, poco più avanti rispetto alla Banca Nazionale del Lavoro, al civico numero 38, facevamo una fermata quasi obbligatoria alla Pasticceria Acciaro, una volta gestita direttamente da Giuseppe Acciaro, che poi la ha data in gestione ad altri, che la hanno trasformata in un bar normale. Un bar storico, a Porto Torres, inaugurato da Giovannino Acciaro nel 1949 come offelleria, termine arcaico che indicava una pasticceria, e da allora non aveva mai chiuso i battenti se non per qualche breve periodo di ferie. Per anni la Pasticceria Acciaro è stata per i portorresi il punto di riferimento per i dolci della domenica o per la torte che venivano ordinate per feste e ricorrenze, ma anche gelateria che richiamava buongustai dall’intero territorio.
La chiesa parrocchiale della Beata Vergine della Consolata
Passata la pasticceria, incrociamo sulla destra la via del Ponte Romano. Tra questa e la successiva via Ampsicora, si apre uno slargo, chiamato piazza della Consolata, nel quale sulla destra si affaccia la Chiesa parrocchiale della Beata Vergine della Consolata, mentre di fronte, all’altro lato del corso Vittorio Emanuele II, si apre la piazza Umberto I, nella quale sulla sinistra si trova il palazzo che ospita gli uffici del Municipio. La chiesa è stata edificata in stile neoclassico nel 1826 su progetto dell’architetto Giuseppe Cominotti per volontà dell’arcivescovo di Sassari Carlo Tommaso Arnosio. La prima pietra viene posta il 22 febbraio 1826 e l’anno successivo, il 30 dicembre, aviene la sua consacrazione da parte dell’arcivescovo turritano alla presenza del Magistrato civico di Sassari. È uno dei luoghi di culto storici della Città insieme alla Basilica di San Gavino. Frutto di un progetto ambizioso, la chiesa si integra armonicamente nel tessuto urbano, distinguendosi per il suo stile sobrio ma elegante. Sulla facciata, al di sopra del portale di ingresso, è presente un grande mosaico nel quale è rappresentata la Vergine con il bambino.
All’interno i visitatori possono ammirare le decorazioni e gli elementi liturgici che adornano l’ambiente, testimoni della devozione dei fedeli e della raffinatezza artistica dell’epoca. Appena entrati, sul pavimento un mosaico posizionato nel 1928 ricorda il centenario della sua costruzione, L’interno si presenta a navata unica, ed al termine nel presbiterio, sotto un arco con una volta stellata, è presente l’altare, impostato su un basso gradino, che consta di una mensa rettangolare sostenuta da due colonnine dai capitelli a fogliami, nel quale la lastra di fondo presenta tre archi acuti, ciechi, su paraste, con i pennacchi adorni di motivi a giglio stilizzato. Sopra l’altare, sulla parete di fondo, è presente un quadro di Cesare Vacca che rappresenta la Madonna con Bambino tra San Carlo Borromeo ed una Santa martire, nel quale la Madonna con il capo avvolto in un manto azzurro, il Bimbo tra le braccia, appare fra nubi e cherubini, e la adorano San Carlo Borromeo, in ginocchio, ed una Santa martire dalla veste gialla, che, con una mano al petto, trattiene con l’altra l’ampio mantello celeste.
La chiesa viene definita un Santuario, ossia un luogo ritenuto sacro dalla tradizione religiosa, per la devozione dei fedeli alla statua della Madonna col Bambino che è conservata al suo interno. La Vergine, dai capelli castani spartiti in due bande sulla fronte, vestita di un abito e di un mantello dorati, allarga le braccia in segno di adorazione verso il Bimbo, che non mostra di sorreggere ma che appare ugualmente trattenuto dal suo braccio. Il Bimbo indossa una tunica dorata e leva la mano nel gesto della benedizione, mentre l’altra mano teneva forse il globo, che ora è però scomparso.
Il vecchio Campo da Calcio di Porto Torres'intestato ad Angelo Occone
All’arrivo a Porto Torres, avevamo preso la via della Tramontana, poi, dopo settecento metri, la via della Libertà, e, dopo quattrocentocinquanta metri, a sinistra la via delle Vigne, che ci aveva portati al nuovo Campo Sportivo di Porto Torres, che ha sostituito il vecchio Campo da Calcio.
Per raggiungere il vecchio Campo Comunale da Calcio di Porto Torres, passata la piazza della Consolata dopo una trentina di metri prendiamo la parallela alla via Ampsicora, che è la via Petronia, la seguiamo in direzione ovest per centocinquanta metri e vediamo, alla sinistra della strada, l’ingresso del vecchio Campo da Calcio, con fondo in terra battuta, che era dotato di tribune in grado di ospitare 600 spettatori.
Il vecchio Campo da Calcio è intestato ad Angelo Occone, il nuotatore di Porto Torres che percorreva i 100 metri in 55 secondi, e voleva abbattere il muro del minuto in questa distanza in acqua dolce, ma che venne ucciso da un suo collega, sopra un peschereccio ormeggiato nel molo, all’ora del pranzo, colpito di taglio con una pala al fianco.
Il piazza Umberto I il palazzo del Municipio di Porto Torres
 Torniamo alla piazza della Consolata, sulla quale si affaccia la chiesa parrocchiale della Beata Vergine della Consolata. Di fronte adessa, alla sinistra del corso Vittorio Emanuele II, si apre un ampio slargo alberato denominato piazza Umberto I, che ospita tra l’altro il palazzo municipale. Si tratta di una piazza quadrata che parte dalla via del Ponte Romano e si sviluppa fino alla via Amsicora, la quale è anche sede delle principali manifestazioni di intrattenimento culturali e turistiche organizzate durante l’anno e quindi costituisce una sorta di biglietto da visita della città. A Porto Torres sull’ampio slargo della piazza Umberto I si affaccia un grande palazzo che ospita il Municipio di Porto Torres. Il progetto del nuovo municipio è stato redatto nel 1958 da Vico Mossa, importante architetto nato a Serramanna nel 1914, e l’edificio è stato costruito tra il 1967 ad il 1974.
Torniamo alla piazza della Consolata, sulla quale si affaccia la chiesa parrocchiale della Beata Vergine della Consolata. Di fronte adessa, alla sinistra del corso Vittorio Emanuele II, si apre un ampio slargo alberato denominato piazza Umberto I, che ospita tra l’altro il palazzo municipale. Si tratta di una piazza quadrata che parte dalla via del Ponte Romano e si sviluppa fino alla via Amsicora, la quale è anche sede delle principali manifestazioni di intrattenimento culturali e turistiche organizzate durante l’anno e quindi costituisce una sorta di biglietto da visita della città. A Porto Torres sull’ampio slargo della piazza Umberto I si affaccia un grande palazzo che ospita il Municipio di Porto Torres. Il progetto del nuovo municipio è stato redatto nel 1958 da Vico Mossa, importante architetto nato a Serramanna nel 1914, e l’edificio è stato costruito tra il 1967 ad il 1974.  Nella parete sinistra all ingresso del Palazzo Comunale è situata una lapide in marmo in ricordo dei Caduti di Porto Torres nella Grande Guerra, che reca incisi i nominativi di 66 Caduti portotorresi nella prima guerra mondiale. Di forma rettangolare, la lapide è appoggiata su un piedistallo anch esso in marmo, che reca incisa la data della probabile inaugurazione ossia il 28 giugno 1925. Nel palazzo municipale si trovano la sua sede e gli uffici in grado di fornire i loro servizi ai cittadini. Si tratta degli uffici dell’Area programmazione, bilancio, tributi, partecipazioni, sistemi informativi, ed innovazione, che si occupa di Gestione del bilancio di previsione, dei tributi comunali e di tutti gli adempimenti correlati; dell’Area ambiente, protezione civile, e polizia locale, che si occupa di igiene ambientale, rifiuti, verde pubblico, acqua destinata al consumo umano e acqua di balneazione; dell’Area affari generali, legale e contenzioso, politiche sociali, sport, cultura, turismo, e pubblica istruzione, che assicura il supporto agli organi di governo dell’ente e alle attivit del Segretario Generale nell’azione amministrativa; dell’Area lavori pubblici, manutenzioni, urbanistica, edilizia privata, e transizione ecologica, che assicura la realizzazione delle nuove opere pubbliche di natura edilizia ed impiantistica; della Segreteria generale, anticorruzione, e trasparenza, che una struttura di supporto al segretario generale nell’esplicazione degli adempimenti correlati alla prevenzione della corruzione; dell’Area politiche del personale, che si occupa dell’Area Politiche del personale.
Nella parete sinistra all ingresso del Palazzo Comunale è situata una lapide in marmo in ricordo dei Caduti di Porto Torres nella Grande Guerra, che reca incisi i nominativi di 66 Caduti portotorresi nella prima guerra mondiale. Di forma rettangolare, la lapide è appoggiata su un piedistallo anch esso in marmo, che reca incisa la data della probabile inaugurazione ossia il 28 giugno 1925. Nel palazzo municipale si trovano la sua sede e gli uffici in grado di fornire i loro servizi ai cittadini. Si tratta degli uffici dell’Area programmazione, bilancio, tributi, partecipazioni, sistemi informativi, ed innovazione, che si occupa di Gestione del bilancio di previsione, dei tributi comunali e di tutti gli adempimenti correlati; dell’Area ambiente, protezione civile, e polizia locale, che si occupa di igiene ambientale, rifiuti, verde pubblico, acqua destinata al consumo umano e acqua di balneazione; dell’Area affari generali, legale e contenzioso, politiche sociali, sport, cultura, turismo, e pubblica istruzione, che assicura il supporto agli organi di governo dell’ente e alle attivit del Segretario Generale nell’azione amministrativa; dell’Area lavori pubblici, manutenzioni, urbanistica, edilizia privata, e transizione ecologica, che assicura la realizzazione delle nuove opere pubbliche di natura edilizia ed impiantistica; della Segreteria generale, anticorruzione, e trasparenza, che una struttura di supporto al segretario generale nell’esplicazione degli adempimenti correlati alla prevenzione della corruzione; dell’Area politiche del personale, che si occupa dell’Area Politiche del personale.
Davanti al palazzo Comunale si trova il Monumento ai Caduti del mare

 Entrando nella piazza, alla destra in una aiuola antistante il palazzo Comunale, è presente un’area monumentale nella quale si trova il Monumento ai Caduti del mare, realizzato dallo scultore e ceramista Giuseppe Silecchia, nato a Porto Azzurro nel 1927, che si trasferisce a Sassari con la famiglia durante la prima adolescenza, dove si diploma all’Istituto d’Arte. Si tratta di un monumento, che è stato inaugurato il 25 maggio 1980, edificato su commissione dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, Gruppo Giovanni Solinas, di Porto Torres, eretto dai marinai d’Italia per assolvere al nobile impegno di devozione verso tutti i fratelli d’arma che immolarono la loro vita in mare per salvaguardare la patria. Sulla fronte del monumento, affissa su un blocco marmoreo, è presente una struttura lignea che rappresenta il corpo di un caduta tra le onde del mare, preceduta da un’ancora.
Entrando nella piazza, alla destra in una aiuola antistante il palazzo Comunale, è presente un’area monumentale nella quale si trova il Monumento ai Caduti del mare, realizzato dallo scultore e ceramista Giuseppe Silecchia, nato a Porto Azzurro nel 1927, che si trasferisce a Sassari con la famiglia durante la prima adolescenza, dove si diploma all’Istituto d’Arte. Si tratta di un monumento, che è stato inaugurato il 25 maggio 1980, edificato su commissione dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, Gruppo Giovanni Solinas, di Porto Torres, eretto dai marinai d’Italia per assolvere al nobile impegno di devozione verso tutti i fratelli d’arma che immolarono la loro vita in mare per salvaguardare la patria. Sulla fronte del monumento, affissa su un blocco marmoreo, è presente una struttura lignea che rappresenta il corpo di un caduta tra le onde del mare, preceduta da un’ancora.
Sul retro del palazzo Comunale in via Libio 53 sono state trovate Tombe ipogeiche di epoca romana
Sul retro del palazzo Comunale passa la via Libio, e lungo questa strada sul retro della piazza Umberto I, nel 2000 dopo la demolizione di una vecchia palazzina per far spazio a un condominio privato al civico numero 53 della via Libio, viene scoperto casualmente un affascinante complesso archeologico, costituito da diverse Tombe ipogeiche di epoca romana, che erano collocate nel settore orientale della necropoli di Turris Libisonis, nelle vicinanze di un nuovo tratto della cinta muraria recentemente indagato. Tali rinvenimenti, non ancora del tutto studiati e riapprofonditi solamente con una nuova campagna di scavo ufficiale nel 2016, rientrano nel più ampio complesso ipogeico dell’antica Città romana. Il sito è oggi localizzato nel piano seminterrato dell’edificio ad angolo tra la via Libio e la via Amsicora.
Il complesso monumentale è composto da due grandi camere ipogeiche con diverse tombe ad arcosolio di epoca romana, scavate nel calcare affiorante, e da altre sepolture ad inumazione. Interessante la ricca decorazione su intonaci dipinti sulle pareti delle sepolture, in una delle quali è rappresentata una biga in corsa con auriga e cavalli, simile a una raffigurazione presso l’Ipogeo di Tanca Borgona, scavato nel 1947 da Giovanni Lilliu.
La sede politica del Municipio ospitata nel Palazzo del Marchese
 L’edificio che ospita il Municipio, come già detto, si trova il piazza Umberto I, ma la sede politica del Municipio di Porto Torres è stata trasferita più avanti, lungo il corso Vittorio Emanuele II, sulla destra al civico numero 65, nel Palazzo del Marchese, uno dei più importanti edifici di pregio presenti in città. Affacciato sul corso, era stato costruito nella prima metà dell’Ottocento, appartenuto al ramo nobiliare dei Marchesi di San Saturnino, con capostipite il diplomatico don Raimondo de Quesada, primo Marchese di San Saturnino, Giudice della Reale Udienza e Segretario di Stato e di Guerra. Affittato nel 1854 e sucessivamente acquistato dal nascente comune di Porto Torres, dopo alterne vicende, l’edificio, nuovamente di proprietà privata, è stato riacquistato dal comune di Porto Torres negli anni novanta del Novecento, per diventare la sua sede di rappresentanza. L’immobile, di impianto neoclassico, ha corpo principale con pianta rettangolare di circa 580 metri quadrati di superficie coperta, un cortile interno e alcuni corpi accessori.
L’edificio che ospita il Municipio, come già detto, si trova il piazza Umberto I, ma la sede politica del Municipio di Porto Torres è stata trasferita più avanti, lungo il corso Vittorio Emanuele II, sulla destra al civico numero 65, nel Palazzo del Marchese, uno dei più importanti edifici di pregio presenti in città. Affacciato sul corso, era stato costruito nella prima metà dell’Ottocento, appartenuto al ramo nobiliare dei Marchesi di San Saturnino, con capostipite il diplomatico don Raimondo de Quesada, primo Marchese di San Saturnino, Giudice della Reale Udienza e Segretario di Stato e di Guerra. Affittato nel 1854 e sucessivamente acquistato dal nascente comune di Porto Torres, dopo alterne vicende, l’edificio, nuovamente di proprietà privata, è stato riacquistato dal comune di Porto Torres negli anni novanta del Novecento, per diventare la sua sede di rappresentanza. L’immobile, di impianto neoclassico, ha corpo principale con pianta rettangolare di circa 580 metri quadrati di superficie coperta, un cortile interno e alcuni corpi accessori.
 L’edificio si sviluppa su due piani per circa dieci metri di altezza. Il piano terra, con una grande sala in posizione centrale, presenta una scenografica scala attraverso la quale si raggiunge il primo piano con al centro un salone principale. Il prospetto principale, sul corso Vittorio Emanuele II è l’unico caratterizzato da ornamenti di chiara ispirazione ottocentesca su intonaco liscio. Infatti i tre ingressi, due laterali e uno centrale, sono inquadrati da una coppia di lesene che terminano su altrettanti capitelli, che solo nei laterali proseguono fino al cornicione dal quale sporgono dando luogo ad un ulteriore capitello di coronamento. In quello centrale, il principale dei tre, le due lesene, presenti solo nel piano nobile, poggiano sulla cornice orizzontale, modanata da linee semplici, del portone principale e si bloccano alla prima fila di capitelli. Ad ogni ingresso al piano terra corrisponde un balcone con portafinestra al primo piano. Orizzontalmente le aperture sono enfatizzate da architravi dalle modanature sottili e aggettanti.
L’edificio si sviluppa su due piani per circa dieci metri di altezza. Il piano terra, con una grande sala in posizione centrale, presenta una scenografica scala attraverso la quale si raggiunge il primo piano con al centro un salone principale. Il prospetto principale, sul corso Vittorio Emanuele II è l’unico caratterizzato da ornamenti di chiara ispirazione ottocentesca su intonaco liscio. Infatti i tre ingressi, due laterali e uno centrale, sono inquadrati da una coppia di lesene che terminano su altrettanti capitelli, che solo nei laterali proseguono fino al cornicione dal quale sporgono dando luogo ad un ulteriore capitello di coronamento. In quello centrale, il principale dei tre, le due lesene, presenti solo nel piano nobile, poggiano sulla cornice orizzontale, modanata da linee semplici, del portone principale e si bloccano alla prima fila di capitelli. Ad ogni ingresso al piano terra corrisponde un balcone con portafinestra al primo piano. Orizzontalmente le aperture sono enfatizzate da architravi dalle modanature sottili e aggettanti.
La Biblioteca Comunale di Porto Torres
 Proseguendo per corso Vittorio Emanuele II, arriviamo a un bivio, dove, invece di proseguire lungo il corso, prendiamo a sinistra la via Sassari, che è la prosecuzione della SS131 di Carlo Felice. Lungo questa strada, al civico numero 8, si trova l’edificio nel quale ha sede la Biblioteca Comunale, intitolata ad Antonio Pigliaru, attiva dal 1979, partendo con un patrimonio di 1.500 volumi ereditati dalla Pro Loco di Porto Torres. La biblioteca offre i suoi numerosi servizi gratuitamente a tutti i suoi iscritti. Il prestito di libri, riviste e fumetti, materiale multimediale si effettua anche a domicilio per chi non può recarsi in biblioteca. Tramite la biblioteca è possibile iscriversi alla piattaforma di prestito digitale MLOL’con un’ampia offerta di e-book, film, audiolibri, quotidiani e riviste, musica etc. La biblioteca offre regolarmente attività di promozione della lettura per bambini, ragazzi e adulti anche in adesione a campagne nazionali sul libro e la lettura e collabora e promuove iniziative culturali sul territorio insieme alle Rete della lettura cittadina.
Proseguendo per corso Vittorio Emanuele II, arriviamo a un bivio, dove, invece di proseguire lungo il corso, prendiamo a sinistra la via Sassari, che è la prosecuzione della SS131 di Carlo Felice. Lungo questa strada, al civico numero 8, si trova l’edificio nel quale ha sede la Biblioteca Comunale, intitolata ad Antonio Pigliaru, attiva dal 1979, partendo con un patrimonio di 1.500 volumi ereditati dalla Pro Loco di Porto Torres. La biblioteca offre i suoi numerosi servizi gratuitamente a tutti i suoi iscritti. Il prestito di libri, riviste e fumetti, materiale multimediale si effettua anche a domicilio per chi non può recarsi in biblioteca. Tramite la biblioteca è possibile iscriversi alla piattaforma di prestito digitale MLOL’con un’ampia offerta di e-book, film, audiolibri, quotidiani e riviste, musica etc. La biblioteca offre regolarmente attività di promozione della lettura per bambini, ragazzi e adulti anche in adesione a campagne nazionali sul libro e la lettura e collabora e promuove iniziative culturali sul territorio insieme alle Rete della lettura cittadina.
La Basilica dei Santi Gavino Proto e Gianuario
 Torniamo su corso Vittorio Emanuele II, alla biforcazione, dove il corso prosegue sulla destra, mentre sulla sinistra si sviluppa la via Sassari. Proseguendo sul corso Vittorio Emanuele II per trecento metri, arriviamo in piazza Guglielmo Marconi e, svoltando a sinistra, alla sommità di un colle chiamato Monte Agellu dal latino agellus che indica un piccolo campo o un cimitero, ci troviamo di fronte la bellissima Basilica dei Santi Gavino Proto e Gianuario il più grande e principale monumento romanico della Sardegna che si affaccia sul parco di San Gavino. La chiesa ha ricevuto l’appellativo di Basilica, denominazione onorifica che il papa concede a edifici religiosi particolarmente adeguati al ruolo che ricoprono per importanza e valore artistico, quindi grandi e capaci di accogliere moltissime persone. Secondo la tradizione Gonnario Comita, giudice del Logudoro, avrebbe deciso di costruire una chiesa in onore di Gavino dopo che il Santo, apparsogli in sogno, gli aveva promesso di guarirlo dalla grave malattia che lo affliggeva, a patto che egli ritrovasse le sue reliquie e quelle di Proto e Gianuario, e conferisse loro degna sepoltura. Il giudice avrebbe rinvenuto i corpi dei Martiri turritani in prossimit dell’attuale chiesetta di Balai, dove erano stati martirizzati, e li avrebbe fatti trasferire in una apposita chiesa. I lavori di costruzione, iniziati intorno al 1060 da maestranze pisane chiamate da Comita su un sepolcreto pagano utilizzato anche dai Cristiani, sarebbero proseguiti durante il giudicato di Torchitorio Barisone de Lacon-Gunale, figlio di Gonnario Comita, e la chiesa sarebbe stata inaugurata non più tardi del 1082, sotto l’arcivescovo Costantino di Castra. Era una normale chiesa realizzata, secondo un’antica regola liturgica anteriore all’anno mille, con l’abside ad occidente e la facciata rivolta ad oriente, una regola che si ritrova in alcune fra le Chiese romaniche più antiche in Sardegna, opposta alla prassi liturgica corrente che vuole il sacerdote celebrare rivolto verso oriente. È stata successivamente ampliata nel dodicesimo secolo, eliminando la facciata e raddoppiando in lunghezza la chiesa, che è stata chiusa con l’abside orientale.
Torniamo su corso Vittorio Emanuele II, alla biforcazione, dove il corso prosegue sulla destra, mentre sulla sinistra si sviluppa la via Sassari. Proseguendo sul corso Vittorio Emanuele II per trecento metri, arriviamo in piazza Guglielmo Marconi e, svoltando a sinistra, alla sommità di un colle chiamato Monte Agellu dal latino agellus che indica un piccolo campo o un cimitero, ci troviamo di fronte la bellissima Basilica dei Santi Gavino Proto e Gianuario il più grande e principale monumento romanico della Sardegna che si affaccia sul parco di San Gavino. La chiesa ha ricevuto l’appellativo di Basilica, denominazione onorifica che il papa concede a edifici religiosi particolarmente adeguati al ruolo che ricoprono per importanza e valore artistico, quindi grandi e capaci di accogliere moltissime persone. Secondo la tradizione Gonnario Comita, giudice del Logudoro, avrebbe deciso di costruire una chiesa in onore di Gavino dopo che il Santo, apparsogli in sogno, gli aveva promesso di guarirlo dalla grave malattia che lo affliggeva, a patto che egli ritrovasse le sue reliquie e quelle di Proto e Gianuario, e conferisse loro degna sepoltura. Il giudice avrebbe rinvenuto i corpi dei Martiri turritani in prossimit dell’attuale chiesetta di Balai, dove erano stati martirizzati, e li avrebbe fatti trasferire in una apposita chiesa. I lavori di costruzione, iniziati intorno al 1060 da maestranze pisane chiamate da Comita su un sepolcreto pagano utilizzato anche dai Cristiani, sarebbero proseguiti durante il giudicato di Torchitorio Barisone de Lacon-Gunale, figlio di Gonnario Comita, e la chiesa sarebbe stata inaugurata non più tardi del 1082, sotto l’arcivescovo Costantino di Castra. Era una normale chiesa realizzata, secondo un’antica regola liturgica anteriore all’anno mille, con l’abside ad occidente e la facciata rivolta ad oriente, una regola che si ritrova in alcune fra le Chiese romaniche più antiche in Sardegna, opposta alla prassi liturgica corrente che vuole il sacerdote celebrare rivolto verso oriente. È stata successivamente ampliata nel dodicesimo secolo, eliminando la facciata e raddoppiando in lunghezza la chiesa, che è stata chiusa con l’abside orientale.
Nel quindicesimo secolo la chiesa subisce corposi rifacimenti che introducono elementi tipici dello stile gotico catalano, come attestato da un’epigrafe datata al 1492. La Basilica, realizzata in stile romanico pisano arcaico, ha quindi pianta lungitudinale a tre navate, divise da arcate su ventidue colonne di spoglio e tre coppie di pilastri cruciformi. Mancando la facciata, nella Basilica si entra da un portale doppio gigliato in stile gotico catalano sulla fiancata meridionale, ed anche da due portali semplici, uno nello stesso stile e l’altro in stile romanico, sul lato opposto.
 Nella chiesa, di lato al portale principale, sono presenti le prime riproduzioni conosciute dello stemma del Giudicato di Torres. La Basilica romanica di San Gavino di Porto Torres è uno dei monumenti più significativi dell’intero patrimonio artistico sardo. La grandiosità dell’esterno cede il passo al fascino discreto dell’interno, appena rischiarato dalla luce che proviene dalle monofore a feritoia e si riflette nelle colonne e nei capitelli marmorei prelevate da antichi edifici di età romana e bizantina. All’interno in corrispondenza dell’abside occidentale, quello che apparteneva alla prima chiesa, si trova l’altare. In corrispondenza di quello orientale è invece presente un il catafalco ligneo con le statue dei tre martiri ed una bella statua equestre seicentesca in legno di San Gavino. Il Santuario è anche un’importante meta devozionale, per via del culto millenario tributato ai martiri locali Gavino, Proto e Gianuario.
Nella chiesa, di lato al portale principale, sono presenti le prime riproduzioni conosciute dello stemma del Giudicato di Torres. La Basilica romanica di San Gavino di Porto Torres è uno dei monumenti più significativi dell’intero patrimonio artistico sardo. La grandiosità dell’esterno cede il passo al fascino discreto dell’interno, appena rischiarato dalla luce che proviene dalle monofore a feritoia e si riflette nelle colonne e nei capitelli marmorei prelevate da antichi edifici di età romana e bizantina. All’interno in corrispondenza dell’abside occidentale, quello che apparteneva alla prima chiesa, si trova l’altare. In corrispondenza di quello orientale è invece presente un il catafalco ligneo con le statue dei tre martiri ed una bella statua equestre seicentesca in legno di San Gavino. Il Santuario è anche un’importante meta devozionale, per via del culto millenario tributato ai martiri locali Gavino, Proto e Gianuario.
Nel 1614 l’arcivescovo Antonio Manca di Cedrelles ha ordinato scavi all’interno della Basilica alla ricerca delle reliquie dei tre martiri turritani. Il risultato di questi scavi ha portato alla luce un discreto numero di sepolture, tre delle quali riconosciute come le spoglie dei martiri, collocate poi nella Cripta seicentesca appositamente scavata per accoglierle, ed alcune tombe rivestite con tappeto musivo, identificate dalle epigrafi come sepolture di vescovi. Varie campagne di scavo archeologico successive hanno individuato i residui murari di due Chiese più antiche, risalenti al quinto ed al settimo secolo dopo Cristo. Una, più piccola, sta sotto il fianco nord della Basilica romanica, l’altra si estende nel settore esterno sempre a nord. Nella Cripta della Basilica sono sono conservate, in sarcofaghi del terzo e quarto secolo, le reliquie dei tre martiri San Gavino, Proto e Gianuario, fatti uccidere dall’Imperatore Diocleziano. All’interno sono visibili alcuni sarcofagi di epoca romana e altri reperti.
 La chiesa viene definita un Santuario, ossia un luogo ritenuto sacro dalla tradizione religiosa, per la devozione dei fedeli ai tre Martiri, che sono oggetto di numerose processioni che si tengono a Porto Torres. All’interno della Basilica è presente il quadro che rappresenta la decollazione di San Gavino, nel quale sono rappresentati anche il diacono Gianuario a sinistra, ed il presbitero Proto a destra. Ma sino a poco tempo fa l’origine di quel quadro era sconosciuta, ci ha, però, pensato l’epigrafista Giuseppe Piras, vicepresidente del Centro Studi Basilica di San Gavino, a svelare il mistero, ed egli ha decifrato la firma dell’autore ed ha rivelato che il quadro è opera dell’artista Antonio Casabianca, nato a Sassari nel 1798, ed è stato realizzato nel 1849.
La chiesa viene definita un Santuario, ossia un luogo ritenuto sacro dalla tradizione religiosa, per la devozione dei fedeli ai tre Martiri, che sono oggetto di numerose processioni che si tengono a Porto Torres. All’interno della Basilica è presente il quadro che rappresenta la decollazione di San Gavino, nel quale sono rappresentati anche il diacono Gianuario a sinistra, ed il presbitero Proto a destra. Ma sino a poco tempo fa l’origine di quel quadro era sconosciuta, ci ha, però, pensato l’epigrafista Giuseppe Piras, vicepresidente del Centro Studi Basilica di San Gavino, a svelare il mistero, ed egli ha decifrato la firma dell’autore ed ha rivelato che il quadro è opera dell’artista Antonio Casabianca, nato a Sassari nel 1798, ed è stato realizzato nel 1849.
Molto importante è la Festha Manna, che è la festa dei Santi Gavino, Proto e Gianuario. La festa ha inizio il quarantacinquesimo giorno dopo Pasqua, quando le statue dei tre martiri vengono portate in processione nell’antica piccola chiesa di Balai, luogo della loro morte. Poi la domenica di Pentecoste, ossia il cinquantesimo giorno dopo la Pasqua, una grande processione li accompagna nella Basilica di San Gavino, dove iniziano i festeggiamenti religiosi. Il giorno successivo, il lunedì, si conclude la festa con una processione a mare, al termine della quale viene offerta frittura di pesce a tutti i partecipanti.
Secondo la tradizione agiografica, i tre Santi sarebbero stati decapitati nella località di Balai Lontano, dove ancora oggi è ubicata la piccola chiesa intitolata a Santu Bainzu Ischabizzaddu, i cadaveri sarebbero stati gettati in mare e recuperati dai Cristiani che avebbero dato loro sepoltura. Un’altra leggenda, in contrasto con la tradizione agiografica, dice invece che la piccola chiesa di Balai vicino sarebbe stata edificata nel luogo dove sarebbero stati gettati a mare i corpi dei tre martiri, Gavino, Proto e Gianuario; e la seconda piccola chiesa, quella di Balai Lontano, nel luogo dove la corrente li avrebbe riportati a riva.
I resti della Necropoli Meridionale detta anche Necropoli di San Gavino
 La Basilica si sviluppa tra due cortili, detto quello a destra Atrio Comita sul quale si affaccia tutta una sequenza di piccole abitazioni, e quello a sinistra Atrio Metropoli. Gli scavi e le ricerche che hanno interessato, in tempi e modalità diverse, il sito su cui sorge la Basilica dei Martiri Turritani, hanno portato alla luce un importante e vasta area archeologica attraverso la quale è possibile tornare ai primi secoli del Cristianesimo in Sardegna. In età romana una legge antichissima vietava di seppellire i defunti all’interno delle mura della città, ed anche a Turris Libisonis le Necropoli si estendevano a sud, est e ovest dell’abitato, ai lati delle tre strade che conducevano ai principali centri dell’isola. Un ampia porzione della Città moderna era occupata dalla Necropoli Meridionale, detta anche Necropoli di San Gavino, situata nei dintorni della Basilica omonima, le cui prime ntizie risalgono al 1614, quando sono state rinvenute le spoglie dei tre martiri, e le sepolture dei vescovi. Numerose altre tombe sono state successivamente rinvenute nell’Atrio Comita e nell’Atrio Metropoli, e dal quarto secolo in poi entrambi gli atri sono interessati dall’impianto della necropoli cristiana, quando sono presenti epigrafi e di vari simboli Cristiani.
La Basilica si sviluppa tra due cortili, detto quello a destra Atrio Comita sul quale si affaccia tutta una sequenza di piccole abitazioni, e quello a sinistra Atrio Metropoli. Gli scavi e le ricerche che hanno interessato, in tempi e modalità diverse, il sito su cui sorge la Basilica dei Martiri Turritani, hanno portato alla luce un importante e vasta area archeologica attraverso la quale è possibile tornare ai primi secoli del Cristianesimo in Sardegna. In età romana una legge antichissima vietava di seppellire i defunti all’interno delle mura della città, ed anche a Turris Libisonis le Necropoli si estendevano a sud, est e ovest dell’abitato, ai lati delle tre strade che conducevano ai principali centri dell’isola. Un ampia porzione della Città moderna era occupata dalla Necropoli Meridionale, detta anche Necropoli di San Gavino, situata nei dintorni della Basilica omonima, le cui prime ntizie risalgono al 1614, quando sono state rinvenute le spoglie dei tre martiri, e le sepolture dei vescovi. Numerose altre tombe sono state successivamente rinvenute nell’Atrio Comita e nell’Atrio Metropoli, e dal quarto secolo in poi entrambi gli atri sono interessati dall’impianto della necropoli cristiana, quando sono presenti epigrafi e di vari simboli Cristiani.
 L’Atrio Comita sorge nel lato nord occidentale della Basilica di San Gavino, dirimpetto al fianco nord del monumento, sorgono le costruzioni chiamate cumbessias, termine che in sardo indica le case dei pellegrini. Queste abitazioni ospitavano i fedeli giunti in citt in occasione della festa dei Santi Martiri Turritani. L’impianto attuale risale ai secoli sedicesimo e diciassettesimo. Nell angolo sud occidentale delle cumbessias, lavori di restauro e scavo archeologico hanno messo in luce un ampio ambiente identificato come Aula Capitolare. All interno stata individuata una colonna in granito grigio e un capitello di reimpiego in trachite rossa, elemento fondamentale dal punto di vista statico e forse simbolico. L’aula, dotata di possenti muri perimetrali e ampie volte a crociera, ospitava presumibilmente le riunioni del collegio sacerdotale del Capitolo turritano. Le indagini hanno evidenziato le complesse stratificazioni archeologiche di et antica, medievale e moderna. L’Atrio Comita mostra, infatti, tre fasi strutturali sovrapposte all’antica necropoli romana di Monte Agellu. La prima fase, legata alla necropoli paleocristiana, comprende una struttura mononavata con abside costruita tra il quarto ed il sesto secolo dopo Cristo, successivamente ampliata con due navate laterali e un vestibolo. Tra l’Alto Medioevo e la prima era giudicale, si aggiunge un edificio di culto più grande, orientato da nord ovest verso sud est, con un portico rivestito di lastre di calcare. Le strutture sono state protette e coperte per preservarle insieme alle fondazioni della basilica romanica. Lastre di pietra sul pavimento segnano i contorni degli edifici paleocristiani e medievali scoperti dagli scavi archeologici.
L’Atrio Comita sorge nel lato nord occidentale della Basilica di San Gavino, dirimpetto al fianco nord del monumento, sorgono le costruzioni chiamate cumbessias, termine che in sardo indica le case dei pellegrini. Queste abitazioni ospitavano i fedeli giunti in citt in occasione della festa dei Santi Martiri Turritani. L’impianto attuale risale ai secoli sedicesimo e diciassettesimo. Nell angolo sud occidentale delle cumbessias, lavori di restauro e scavo archeologico hanno messo in luce un ampio ambiente identificato come Aula Capitolare. All interno stata individuata una colonna in granito grigio e un capitello di reimpiego in trachite rossa, elemento fondamentale dal punto di vista statico e forse simbolico. L’aula, dotata di possenti muri perimetrali e ampie volte a crociera, ospitava presumibilmente le riunioni del collegio sacerdotale del Capitolo turritano. Le indagini hanno evidenziato le complesse stratificazioni archeologiche di et antica, medievale e moderna. L’Atrio Comita mostra, infatti, tre fasi strutturali sovrapposte all’antica necropoli romana di Monte Agellu. La prima fase, legata alla necropoli paleocristiana, comprende una struttura mononavata con abside costruita tra il quarto ed il sesto secolo dopo Cristo, successivamente ampliata con due navate laterali e un vestibolo. Tra l’Alto Medioevo e la prima era giudicale, si aggiunge un edificio di culto più grande, orientato da nord ovest verso sud est, con un portico rivestito di lastre di calcare. Le strutture sono state protette e coperte per preservarle insieme alle fondazioni della basilica romanica. Lastre di pietra sul pavimento segnano i contorni degli edifici paleocristiani e medievali scoperti dagli scavi archeologici.
 L’Atrio Metropoli sorge nel lato sud orientale della Basilica di San Gavino ed stato oggetto di recenti scavi archeologici che hanno svelato le fasi insediative nell’area di Monte Agellu, precedenti l’edificazione della Basilica. La necropoli di Monte Agellu, nella sua parte più affascinante situata sotto l’Atrio Metropoli, è una fonte straordinaria di informazioni sulla storia della Città in età romana, dato che le differenti tipologie di sepoltura, a sarcofago, a fossa semplice, alla cappuccina, oltre alla varietà degli apparati decorativi in stucco e in mosaico, ed il ricco patrimonio di epigrafi, in gran parte databili al quarto secolo dopo Cristo, disegnano un ritratto suggestivo e a tratti toccante della societ e degli abitanti di Turris nei primi secoli del Cristianesimo, e ci parlano, insieme ai resti monumentali portati alla luce nell’adiacente Atrio Comita, delle radici antiche di una devozione che da secoli ha nel complesso monumentale dei Martiri Turritani il suo centro. Accanto all’area cimiteriale possibile inoltre vedere una grande cisterna sotterranea, riutilizzata in et medievale e moderna, originariamente connessa al sistema di approvvigionamento idrico della Città romana. Nel ripristinare la piazza dopo gli scavi archeologici, l’area funeraria è stata conservata sotto la nuova struttura, in modo da consentire la visita attraverso un percorso calibrato sulla vulnerabilità delle tombe.
L’Atrio Metropoli sorge nel lato sud orientale della Basilica di San Gavino ed stato oggetto di recenti scavi archeologici che hanno svelato le fasi insediative nell’area di Monte Agellu, precedenti l’edificazione della Basilica. La necropoli di Monte Agellu, nella sua parte più affascinante situata sotto l’Atrio Metropoli, è una fonte straordinaria di informazioni sulla storia della Città in età romana, dato che le differenti tipologie di sepoltura, a sarcofago, a fossa semplice, alla cappuccina, oltre alla varietà degli apparati decorativi in stucco e in mosaico, ed il ricco patrimonio di epigrafi, in gran parte databili al quarto secolo dopo Cristo, disegnano un ritratto suggestivo e a tratti toccante della societ e degli abitanti di Turris nei primi secoli del Cristianesimo, e ci parlano, insieme ai resti monumentali portati alla luce nell’adiacente Atrio Comita, delle radici antiche di una devozione che da secoli ha nel complesso monumentale dei Martiri Turritani il suo centro. Accanto all’area cimiteriale possibile inoltre vedere una grande cisterna sotterranea, riutilizzata in et medievale e moderna, originariamente connessa al sistema di approvvigionamento idrico della Città romana. Nel ripristinare la piazza dopo gli scavi archeologici, l’area funeraria è stata conservata sotto la nuova struttura, in modo da consentire la visita attraverso un percorso calibrato sulla vulnerabilità delle tombe.
Numerose altre sepolture sono state rinvenute vicino alla Basilica. Sepolture del primo secolo dopo Cristo sono state rinvenute circa trecento metri a nord della Basilica, nel cortile della Scuola elementare Edmondo De Amicis'in via Azuni, e si tratta di tombe ad incinerazione con cremazione diretta, come testimoniano i resti degli scheletri combusti e gli elementi di corredo alterati dal calore. Al medesimo arco cronologico appartengono le sepolture, di cui sei ad incinerazione e sette ad inumazione, rinvenute nella vicina via Eleonora d’Arborea. Altre tombe alla cappuccina sono state rinvenute più a nord, tra via Petronia e via Azuni. Il recinto funerario, molto ampio dato che si sviluppa tra i nove e gli oltre diciotto metri, riferibile ad un periodo che va dal secondo secolo dopo Cristo alla fine del terzo secolo, con riuso fino al sesto secolo, era destinato ad ospitare sepolture singole disposte su più piani, come dimostrano gli incassi orizzontali e verticali ad altezza regolare nelle pareti, delimitate da muretti. Al suo interno è stato scavato un primo livello di undici tombe, di cui alcune degne di nota per l’uso di lastre di marmo di riutilizzo, con iscrizioni e copertura con tappeti musivi. Al di sopra di queste ci sono altre cinque sepolture, meno curate e con reperti che giungono fino al sesto secolo dopo Cristo. Anche a sud della Basilica, altri interventi realizzati nell’ambito di lavori urbani negli anni 1963 e 1964, e poi nel 1978, hanno restituito numerose sepolture di diversa tipologia e resti di edifici funerari. Gli scavi sistematici effettuati tra il 1979 ed il 1980 nell’area tra via Sassari, via Indipendenza e via Mannu, hanno portato alla luce nove tombe alla cappuccina e in fossa terragna, oltre ad un significativo recinto funerario.
La palestra della Scuola Elementare Monte Angellu
Dal corso Vittorio Emanuele II eravamo arrivati nella piazza Guglielmo Marconi dove, alla sommità del colle Monte Agellu, avevamo visitato la bellissima Basilica dei Santi Gavino Proto e Gianuario. Procediamo, quindi, in direzione sud est dalla piazza Guglielmo Marconi la quale, dopo una sessantina di metri, svolta leggermente a sinistra e diventa il largo Sabelli. Percorsa una sessantina di metri nel largo Sabelli, svoltiamo a destra e prendiamo la via Mentana, la seguiamo per centoventi metri poi prendiamo a sinistra la via del Monte Angellu lungo la quale, dopo una cinquantina di metri, sulla destra al civico numero 66 si trova l’ingresso dell’edificio che ospita la Scuola Elementare Monte Angellu.
All’interno di questo complesso scolastico è ospitata una Palestra, senza tribune per gli spettatori, nella quale è possibile praticare come discipline la Ginnastica, la Pallacanestro e la Pallavolo.
La palestra della Scuola Media Gavino Gabriel
Dal corso Vittorio Emanuele II eravamo arrivati nella piazza Guglielmo Marconi dove, alla sommità del colle Monte Agellu, avevamo visitato la bellissima Basilica dei Santi Gavino Proto e Gianuario. Procediamo, quindi, in direzione sud est dalla piazza Guglielmo Marconi la quale, dopo una sessantina di metri, svolta leggermente a sinistra e diventa il largo Sabelli. Percorso un centinaio di metri nel largo Sabelli, svoltiamo a sinistra e prendiamo la via Giuseppe Manno che, dopo un centinaio di metri, incrocia la via Sassari. Passato l’incrocio con la via Sassari, la strada prosegue come viale delle Vigne che, dopo una cinquantina di metri, incrocia la via Ettore Sacchi. Passato l’incrocio con la via Ettore Sacchi, alla sinistra della strada al civico numero 1, si trova il complesso della Scuola Media Gavino Gabriel.
All’interno di questo complesso scolastico è ospitata una Palestra, senza tribune per gli spettatori, nella quale è possibile praticare come discipline il Calcetto ossia calcio a cinque, la Pallacanestro e la Pallavolo.
I resti delle terme romane Maetzke
Torniamo alla piazza della Consolata, dove avevamo incontrato la chiesa parrocchiale della Beata Vergine della Consolata. Da corso Vittorio Emanuele II, passata la pasticceria Acciaro, prendiamo sulla destra la via del Ponte Romano e, dopo circa duecentotrenta metri, prima che la strada curvi a destra per attraversare la linea ferrroviaria, prendiamo a sinistra la via delle Terme. La via delle Terme, dopo un’ottattina di metri, incrocia la via Petronia, la prendiamo a sinistra e, percorsi una sessantina di metri, vediamo alla destra della strada in cancello di ingresso ai resti delle Terme Maetzke, scavate negli anni sessanta del secolo scorso sotto la direzione di Guglielmo Maetzke. Gli scavi hanno portato in luce due quartieri di abitazione separati da una strada, uno disposto a terrazze lungo il fianco della collina, l’altro alla base di essa. Su una parte di quest’ultimo, che risale all’epoca di Augusto, venne ad impostarsi, in età imperiale avanzata, un impianto termale. In base alle recenti indagini archeologiche questa fase termale a carattere pubblico, costituisce la parte più orientale di quello che era un ampio complesso termale, che si sovrappone ad un quartiere abitativo privato più antico, risalente al primo secolo dopo Cristo, caratterizzato da domus riccamente decorate con rivestimenti musivi e tarsie marmoree, e dotate di un impianto termale privato.
Poco lontano dal quartiere abitativo privato più antico è stata rinvenuta, nel 1927, la lunga iscrizione commemorante la vittoria dell’Imperatore bizantino Costantino sui Longobardi e sugli altri barbari, attualmente conservata nella Basilica di San Gavino. Tra gli altri reperti, lo scavo del 2003 ha restituito un elemento marmoreo di fontana raffigurante un Satiro, che vedremo quando visiteremo l’Antiquarium Turritano nel quale è esposto oggi. Tale rinvenimento rimarca, con i suoi significati intrinseci, la diffusione che il culto di Dioniso, a cui il personaggio del satiro fa riferimento, ha avuto nella Città di Turris Libisonis, accentuandone il carattere di Città porto aperta al mondo Mediterraneo.
I resti delle Terme Centrali con il palazzo del Re Barbaro
Evitando la deviazione con la via delle Terme, proseguiamo con la via del Ponte Romano che curva a sinistra, e ci porta ai principali reperti storici della Città romana di Turris Libysonis, che si trovano alla sinistra della strada. I più importanti sono i resti delle Terme Centrali di Porto Torres, complesso conosciuto anche con il nome di Palazzo di Re Barbaro, perché secondo una leggenda vi sarebbe sorto il palazzo del governatore della diocesi di Corsica età Sardegna, a nome dell’Imperatore Diocleziano, responsabile delle persecuzioni ai Cristiani nel 304 e 305 dopo Cristo e del martirio dei Santi Gavino, Proto e Gianuario. Questi resti si pongono tra i pochi edifici noti della Città romana, per la gran parte rappresentati da abitazioni private.
 I grandiosi resti monumentali appartengono a un complesso termale pubblico del terzo secolo dopo Cristo, uno dei più grandi della Sardegna romana. Il complesso termale si distingue tanto per lo stato di conservazione quanto per la monumentalità dei resti, che, nelle forme oggi visitabili, risalgono alla media età imperiale. Gli scavi nell’area sono stati promossi da Maria Teresa d Austria, iniziati nel 1819 ad opera del frate francescano sassarese Antonio Cano, sedicente architetto ed archeologo, che per ottenere più celeri risultati fa saltare con le polveri da sparo interi settori dei resti degli impianti termali. Le ricerche continuano a più riprese, sino ad anni recenti, ma il complesso è a tutt'oggi noto solo in minima parte. Il complesso, con oltre duemila metri quadrati e un altezza residua di oltre dieci metri, è stato costruito sopra preesistenti strutture abitative private.
I grandiosi resti monumentali appartengono a un complesso termale pubblico del terzo secolo dopo Cristo, uno dei più grandi della Sardegna romana. Il complesso termale si distingue tanto per lo stato di conservazione quanto per la monumentalità dei resti, che, nelle forme oggi visitabili, risalgono alla media età imperiale. Gli scavi nell’area sono stati promossi da Maria Teresa d Austria, iniziati nel 1819 ad opera del frate francescano sassarese Antonio Cano, sedicente architetto ed archeologo, che per ottenere più celeri risultati fa saltare con le polveri da sparo interi settori dei resti degli impianti termali. Le ricerche continuano a più riprese, sino ad anni recenti, ma il complesso è a tutt'oggi noto solo in minima parte. Il complesso, con oltre duemila metri quadrati e un altezza residua di oltre dieci metri, è stato costruito sopra preesistenti strutture abitative private.
Delimitato da due cardines e da due decumani, l’edificio è stato ampiamente rimaneggiato. In una prima fase, alla fine del primo secolo avanti Cristo, i vani si disponevano assialmente da ovest dove si trovava l’ingresso ad est dove era presente il calidarium, e le murature erano in laterizio. La fase edilizia oggi visibile presenta un orientamento da nord a sud, murature per lo più in opera vittata di calcare e laterizio, copertura con grandi volte ora crollate. L’area circostante mostra un impostazione regolare, con strade pavimentate ad angolo retto e un portico adibito ad attivit commerciali e artigianali.
Alcuni dei reperti rinvenuti all’interno delle Terme Centrali e del palazzo del Re Barbaro sono oggi conservati ed esposti all’interno del Museo Archeologico ed Etnografico Giovanni Antonio Sanna di Sassari.
Il Museo Archeologico chiamato l’Antiquarium Turritano
 Ma i reperti archeologici più significativi, sono ospitati nel Museo Archeologico di Porto Torres, denominato Antiquarium Turritano, sorto agli inizi degli anni settanta su un edificio attiguo all’area di scavo, in via del Ponte Romano 99, ed aperto al pubblico nel 1984. Il complesso museale, che si trova sul retro della Stazione ferroviaria di Porto Torres Marittima dove era presente l’antica colonia di Turris Libisonis, si sviluppa su due piani. L’esposizione presenta statuaria, sculture architettoniche e reperti della vita quotidiana, compresi quelli delle necropoli, con pannelli informativi sugli scavi locali. Al piano terra sono conservati elementi architettonici, are e statue acefale di magistrati. Al primo piano una prima sezione conserva reperti rinvenuti presso le tabernae, le terme e altri edifici privati, ossia vasellame da cucina di origine prevalentemente africana, lucerne di produzione locale, condutture idriche in piombo o in terracotta, le cosiddette fistulae aquariae; mentre una seconda sezione contiene reperti rinvenute nelle necropoli, tombe alla cappuccina e lastre romane riutilizzate per sepolture, oltre a corredi materiale ceramico e metallico.
Ma i reperti archeologici più significativi, sono ospitati nel Museo Archeologico di Porto Torres, denominato Antiquarium Turritano, sorto agli inizi degli anni settanta su un edificio attiguo all’area di scavo, in via del Ponte Romano 99, ed aperto al pubblico nel 1984. Il complesso museale, che si trova sul retro della Stazione ferroviaria di Porto Torres Marittima dove era presente l’antica colonia di Turris Libisonis, si sviluppa su due piani. L’esposizione presenta statuaria, sculture architettoniche e reperti della vita quotidiana, compresi quelli delle necropoli, con pannelli informativi sugli scavi locali. Al piano terra sono conservati elementi architettonici, are e statue acefale di magistrati. Al primo piano una prima sezione conserva reperti rinvenuti presso le tabernae, le terme e altri edifici privati, ossia vasellame da cucina di origine prevalentemente africana, lucerne di produzione locale, condutture idriche in piombo o in terracotta, le cosiddette fistulae aquariae; mentre una seconda sezione contiene reperti rinvenute nelle necropoli, tombe alla cappuccina e lastre romane riutilizzate per sepolture, oltre a corredi materiale ceramico e metallico.
Il percorso stato rinnovato nel 2021 con un racconto museale sulla vita della colonia e una nuova sezione dedicata al territorio in epoca preromana. Attorno al complesso centrale del palazzo del Re Barbaro sono presenti numerosi mosaici, il più famoso e bello dei quali rappresenta Orfeo intento a suonare la lira, circondato da animali.
La domus di Orfeo e la domus dei mosaici marini
 Durante gli scavi vicino alle Terme centrali è stata scoperta un abitazione privata deominata Domus di Orfeo, che è decorata con intonaci dipinti e preziosi mosaici, come il famoso mosaico di Orfeo ed il mosaico delle tre Grazie o della Ierogamia. Nel suo mosaico, Orfeo è rappresentato a torso nudo e con il caratteristico berretto frigio a punta, indumento usato nelle raffigurazioni antiche per identificare personaggi di origine orientale. La tecnica di realizzazione è sicuramente accurata, per la vivacità e la lucentezza dei colori, le dimensioni delle tessere e l’attenzione per i dettagli, visibile soprattutto nel torace che appare ombreggiato come in una pittura. Orfeo viene ritenuto il più antico poeta e musicista della storia.
Durante gli scavi vicino alle Terme centrali è stata scoperta un abitazione privata deominata Domus di Orfeo, che è decorata con intonaci dipinti e preziosi mosaici, come il famoso mosaico di Orfeo ed il mosaico delle tre Grazie o della Ierogamia. Nel suo mosaico, Orfeo è rappresentato a torso nudo e con il caratteristico berretto frigio a punta, indumento usato nelle raffigurazioni antiche per identificare personaggi di origine orientale. La tecnica di realizzazione è sicuramente accurata, per la vivacità e la lucentezza dei colori, le dimensioni delle tessere e l’attenzione per i dettagli, visibile soprattutto nel torace che appare ombreggiato come in una pittura. Orfeo viene ritenuto il più antico poeta e musicista della storia.  Nel racconto mitologico ricevette in dono da Apollo una lira, uno strumento musicale a corde, ed educato dalle muse divenne un suonatore insuperabile, capace di ammaliare con la sua musica tutto il mondo animale e vegetale. In un altro ambiente è possibile ammirare, nell’ottagono centrale, il mosaico delle tre Grazie, probabilmente realizzato dalla stessa bottega artigiana, che è stato oggetto di un intervento di somma urgenza diretto dalla Soprintendenza. I diversi ambienti della domus si affacciano su un vano con un sistema di adduzione e scarico delle acque, e una vasca decorata con un mosaico di pesci e molluschi. La buona conservazione dei pavimenti suggerisce una breve occupazione della residenza. La casa stata successivamente sovrastata dalle grandi terme pubbliche, parte di un progetto urbanistico rinnovato.
Nel racconto mitologico ricevette in dono da Apollo una lira, uno strumento musicale a corde, ed educato dalle muse divenne un suonatore insuperabile, capace di ammaliare con la sua musica tutto il mondo animale e vegetale. In un altro ambiente è possibile ammirare, nell’ottagono centrale, il mosaico delle tre Grazie, probabilmente realizzato dalla stessa bottega artigiana, che è stato oggetto di un intervento di somma urgenza diretto dalla Soprintendenza. I diversi ambienti della domus si affacciano su un vano con un sistema di adduzione e scarico delle acque, e una vasca decorata con un mosaico di pesci e molluschi. La buona conservazione dei pavimenti suggerisce una breve occupazione della residenza. La casa stata successivamente sovrastata dalle grandi terme pubbliche, parte di un progetto urbanistico rinnovato.
 Nella parte occidentale dell’area archeologica è ubicato un articolato complesso monumentale denominato Domus dei mosaici marini. L’edificio si sviluppa su due livelli e poggia sulle pareti rocciose della collina, ed è particolare per la distribuzione degli ambienti, per la presenza di numerosi mosaici che raffigurano diverse specie di pesci e per il ricco apparato decorativo con marmi colorati. Recenti indagini archeologiche hanno messo in luce parte di un’iscrizione nella cornice di un pavimento musivo, nella quale è scritto Deo gratias qui praestitit, traducibile come grazie a Dio che ha provveduto. Si tratta della prova dell’utilizzo dell’ambiente come luogo di culto cristiano nel quarto secolo dopo Cristo, ed è la prima volta che si rinviene all’interno del perimetro urbano di Turris Libisonis. L’originario utilizzo di questo spazio, caratterizzato da una serie di sedili su tutti i lati, pare corrispondere a uno spogliatoio funzionale all’impianto termale. Le caratteristiche confermano l’ipotesi che l’edificio abbia vissuto almeno due periodi di utilizzo, uno ascrivibile al terzo secolo ed uno finale del quarto e quinto secolo dopo Cristo. Anche le ceramiche e le monete ritrovate risultano quasi tutte pertinenti a quest'ultimo periodo.
Nella parte occidentale dell’area archeologica è ubicato un articolato complesso monumentale denominato Domus dei mosaici marini. L’edificio si sviluppa su due livelli e poggia sulle pareti rocciose della collina, ed è particolare per la distribuzione degli ambienti, per la presenza di numerosi mosaici che raffigurano diverse specie di pesci e per il ricco apparato decorativo con marmi colorati. Recenti indagini archeologiche hanno messo in luce parte di un’iscrizione nella cornice di un pavimento musivo, nella quale è scritto Deo gratias qui praestitit, traducibile come grazie a Dio che ha provveduto. Si tratta della prova dell’utilizzo dell’ambiente come luogo di culto cristiano nel quarto secolo dopo Cristo, ed è la prima volta che si rinviene all’interno del perimetro urbano di Turris Libisonis. L’originario utilizzo di questo spazio, caratterizzato da una serie di sedili su tutti i lati, pare corrispondere a uno spogliatoio funzionale all’impianto termale. Le caratteristiche confermano l’ipotesi che l’edificio abbia vissuto almeno due periodi di utilizzo, uno ascrivibile al terzo secolo ed uno finale del quarto e quinto secolo dopo Cristo. Anche le ceramiche e le monete ritrovate risultano quasi tutte pertinenti a quest'ultimo periodo.
La parte settentrionale del complesso termale è costituito dai resti delle Terme Pallottino
 Passato il Museo Archeologico, si arriva a una rotonda, passata la quale, prendiamo la prosecuzione della via del Ponte Romano. Percorsi duecento metri, alla sinistra della strada si vede l’ingresso della parte più settentrionale del complesso termale, che è costituita dalle Terme Pallottino, scavate nel 1941 dall’archeologo Massimo Pallottino. Della struttura termale sono visibili diversi ambienti, con mosaici di stile geometrico, dotati di un complesso sistema di riscaldamento posto sotto il pavimento e nelle intercapedini murarie. Era inizialmente stato portato alla luce un peristilio, delimitato sul lato orientale da un portico con colonne marmoree, del quale erano stati messi in luce circa quattordici metri. In una prima fase edilizia la pavimentazione del portico era costituita da lastre marmoree, quella del peristilio consisteva in un semplice battuto, mentre successivamente il peristilio viene lastricato in trachite e il portico, parzialmente chiuso mediante muretti, riceve una pavimentazione musiva policroma a riquadri entro treccia a più capi, databile intorno alla fine del terzo o agli inizi del quarto secolo dopo Cristo. Il monumento, databile alla fine del terzo secolo dopo Cristo, è stato oggetto di ulteriori campagne di scavo e restauro. A pochi metri dall’impianto termale sono visibili quattro colonne marmoree, facenti parte di un portico che delimita un area lastricata. Accanto al portico è stato rinvenuto un altro mosaico, anch’esso policromo, che però oggi è andato perduto.
Passato il Museo Archeologico, si arriva a una rotonda, passata la quale, prendiamo la prosecuzione della via del Ponte Romano. Percorsi duecento metri, alla sinistra della strada si vede l’ingresso della parte più settentrionale del complesso termale, che è costituita dalle Terme Pallottino, scavate nel 1941 dall’archeologo Massimo Pallottino. Della struttura termale sono visibili diversi ambienti, con mosaici di stile geometrico, dotati di un complesso sistema di riscaldamento posto sotto il pavimento e nelle intercapedini murarie. Era inizialmente stato portato alla luce un peristilio, delimitato sul lato orientale da un portico con colonne marmoree, del quale erano stati messi in luce circa quattordici metri. In una prima fase edilizia la pavimentazione del portico era costituita da lastre marmoree, quella del peristilio consisteva in un semplice battuto, mentre successivamente il peristilio viene lastricato in trachite e il portico, parzialmente chiuso mediante muretti, riceve una pavimentazione musiva policroma a riquadri entro treccia a più capi, databile intorno alla fine del terzo o agli inizi del quarto secolo dopo Cristo. Il monumento, databile alla fine del terzo secolo dopo Cristo, è stato oggetto di ulteriori campagne di scavo e restauro. A pochi metri dall’impianto termale sono visibili quattro colonne marmoree, facenti parte di un portico che delimita un area lastricata. Accanto al portico è stato rinvenuto un altro mosaico, anch’esso policromo, che però oggi è andato perduto.
Dell’insieme rimangono visibili anche pochi resti delle colonne, un centinaio di metri più ad est rispetto ai resti del complesso termale. Il complesso aveva quasi certamente carattere pubblico, come indica il rinvenimento nell’area della base di una statua dedicata nel 305 dal governatore dell’isola Valerio Domiziano all’Imperatore Galerio, che oggi è conservata ed esposta all’interno del Museo Archeologico ed Etnografico Giovanni Antonio Sanna di Sassari. Poco più avanti, alla sinistra della strada, si trovano i resti di un altro piccolo complesso termale scavato anch’esso dal Pallottino nel 1941 e 1942.
Il Ponte Romano
Proseguendo lungo la via del Ponte Romano, passiamo sotto un viadotto e, poco più avanti, la strada si biforca, dove a sinistra parte la via Fontana Vecchia, mentre a destra prosegue la via del Ponte Romano. Seguendo questa strada, arriviamo in un paio di centinaia di metri ai resti del Ponte Romano, il più grande ponte edificato dai Romani in Sardegna, sul quale, la strada che congiungeva la Città a KarAles per la zona mineraria dell’Argentiera, superava il Rio Mannu. È una costruzione lunga 135 metri realizzata in trachite, caratterizzato da sette arcate ineguali a sesto ribassato di dimensioni crescenti verso ovest.
Il ponte aveva una pavimentazione originale costituita da lastroni di trachite, ricoperti successivamente con dell’asfalto, ed è stato utilizzato fino agli anni sessanta del Novecento. Sotto le arcate minori, previste per il deflusso delle acque nei periodi piena, si conserva una pavimentazione in lastre di trachite, simile a quella della strada antica.
L’estremo occidentale dell’abitato
Dove avevamo passato il Museo Archeologico ed eravamo arrivati alla rotonda, invece di prendere la prosecuzione della via del Ponte Romano, prendiamo invece, un poco più a destra, il lungomare Amerigo Vespucci.
La foce del Rio Mannu e le fornaci di Porto Torres
Il lungomare Amerigo Vespucci passa, con il ponte Vespucci, al di sopra dello sbocco a mare del Rio Mannu. Questo è il corso d’acqua a regime torrentizio che scorre in provincia di Sassari nascendo dal monte Sa Figu, a circa 376 metri di altezza, il quale, dopo un breve percorso, si getta nel golfo dell’Asinara. Ed il golfo è stato formato, per l’appunto, dal corso del fiume.
 Presso la foce del Rio Mannu, nel 1964 sono state realizzate le Fornaci che si trovano alla sinistra del lungomare Amerigo Vespucci, oltre la via del Ponte Romano, sul lato sinistro del fiume. Le due rosse torri gemelle sono state realizzate dalla Società Siderurgica Mineraria Ferromin, uno dei primi stabilimenti industriali di Porto Torres. Si trattava in sostanza di un distaccamento della vicina miniera di Canaglia, dove i minerali estratti venivano trasportati al Porto industriale mediante una ferrovia a scartamento ridotto fino alle fornaci e poi, attraverso il ponte costruito in epoca romana alla foce del Rio Mannu, fino alla banchina, dove veniva caricato sulle navi dirette nel Continente. Tutto questo fino alla prima metà degli anni sessanta, quando è iniziata la crisi che ha portato alla chiusura.
Presso la foce del Rio Mannu, nel 1964 sono state realizzate le Fornaci che si trovano alla sinistra del lungomare Amerigo Vespucci, oltre la via del Ponte Romano, sul lato sinistro del fiume. Le due rosse torri gemelle sono state realizzate dalla Società Siderurgica Mineraria Ferromin, uno dei primi stabilimenti industriali di Porto Torres. Si trattava in sostanza di un distaccamento della vicina miniera di Canaglia, dove i minerali estratti venivano trasportati al Porto industriale mediante una ferrovia a scartamento ridotto fino alle fornaci e poi, attraverso il ponte costruito in epoca romana alla foce del Rio Mannu, fino alla banchina, dove veniva caricato sulle navi dirette nel Continente. Tutto questo fino alla prima metà degli anni sessanta, quando è iniziata la crisi che ha portato alla chiusura.
La strada statale che ci porta verso Sassari
Se, provenendo dal Porto commerciale e turistico in direzione del Porto industriale, passato il ponte Vespucci sul Rio Mannu, proseguiamo sul lungomare, dopo trecento metri arriviamo a una rotonda. Alla rotonda prendiamo la seconda uscita, che ci fa imboccare la via dell’Industriala quale, dopo tre chilometri, sbocca sulla via Sassari. Questa strada prosegue fino ad uscire dall’abitato con il nome di SS131 di Carlo Felice, che porta in direzione di Sassari. Si tratta della vecchia SS131 di Carlo Felice, dato che negli ultimi anni è stata realizzata la nuova SS131 di Carlo Felice, che passa più ad ovest, e si può imboccare da una deviazione dopo seicento metri da dove avevamo imboccato la via dell’Industria.
I resti della Necropoli Occidentale detta anche Necropoli della Marinella
 Subito oltre il ponte Vespucci, in località Marinella vicino alla foce del Rio Mannu, alla destra della strada, tra questa ed il mare, si stende la vasta Necropoli Occidentale della città, ossia la Necropoli della Marinella. La prima notizia del rinvenimento di tombe di questa necropoli ipogeica si deve a Giovanni Spano, che ha dato notizia di un’iscrizione e di monete del secondo secolo, ma il sito è stato sottoposto a scavi regolari solo nel 1964, ad opera di Guglielmo Maetzke, che ha indagato una serie di tombe alla cappuccina poste lungo il litorale sabbioso, e catalogato i corredi. Diverse altre campagne di scavi dal 1990 hanno permesso di verificare l’ampiezza della necropoli e di rilevare la continuità del suo utilizzo, dal II fino al sesto e settimo secolo, senza pause fra il rito pagano e quello cristiano. Ad oggi, mancando ogni attestazione di sepolture a incinerazione, si nota la sola presenza di inumati. Le più comuni sono le tombe alla cappuccina con deposizionisu un piano ricavato con embrici e coperte con tegole a doppio spiovente raccordate da coppi, quelle ricavate all’interno di fosse scavate nel banco calcareo e contraddistinte da una risega per l’alloggiamento degli embrici di copertura, ed infine quelle costituite da una semplice fossa terragna, coperta con embrici disposti in piano o a doppio spiovente. Vi sono anche numerosi esempi di tombe a cassone, scavate nella roccia, coperte con lastre litiche, tumuli quadrangolari con pietre di diverse dimensioni. Alcune fosse scavate nel banco di calcare sono visibili sul taglio del lungomare Amerigo Vespucci che attraversa appunto l’area della necropoli. Il monumento attualmente aperto al pubblico è costituito da una tomba ipogeica con arcosoli affrescati. Una scelta dei ritrovamenti ed un pannello esplicativo sono al piano superiore dell’Antiquarium, sulla destra di chi sale.
Subito oltre il ponte Vespucci, in località Marinella vicino alla foce del Rio Mannu, alla destra della strada, tra questa ed il mare, si stende la vasta Necropoli Occidentale della città, ossia la Necropoli della Marinella. La prima notizia del rinvenimento di tombe di questa necropoli ipogeica si deve a Giovanni Spano, che ha dato notizia di un’iscrizione e di monete del secondo secolo, ma il sito è stato sottoposto a scavi regolari solo nel 1964, ad opera di Guglielmo Maetzke, che ha indagato una serie di tombe alla cappuccina poste lungo il litorale sabbioso, e catalogato i corredi. Diverse altre campagne di scavi dal 1990 hanno permesso di verificare l’ampiezza della necropoli e di rilevare la continuità del suo utilizzo, dal II fino al sesto e settimo secolo, senza pause fra il rito pagano e quello cristiano. Ad oggi, mancando ogni attestazione di sepolture a incinerazione, si nota la sola presenza di inumati. Le più comuni sono le tombe alla cappuccina con deposizionisu un piano ricavato con embrici e coperte con tegole a doppio spiovente raccordate da coppi, quelle ricavate all’interno di fosse scavate nel banco calcareo e contraddistinte da una risega per l’alloggiamento degli embrici di copertura, ed infine quelle costituite da una semplice fossa terragna, coperta con embrici disposti in piano o a doppio spiovente. Vi sono anche numerosi esempi di tombe a cassone, scavate nella roccia, coperte con lastre litiche, tumuli quadrangolari con pietre di diverse dimensioni. Alcune fosse scavate nel banco di calcare sono visibili sul taglio del lungomare Amerigo Vespucci che attraversa appunto l’area della necropoli. Il monumento attualmente aperto al pubblico è costituito da una tomba ipogeica con arcosoli affrescati. Una scelta dei ritrovamenti ed un pannello esplicativo sono al piano superiore dell’Antiquarium, sulla destra di chi sale.
Il Porto industriale dove approdano oggi i grandi traghetti
 Il lungomare Amerigo Vespucci prosegue e, in poco più di un chilometro e mezzo, ci porta al Porto industriale. Nel secondo dopoguerra si è assistito alla creazione della zona industriale e il suo relativo porto, un bacino portuale di considerevoli dimensioni e totalmente indipendente dal punto di vista strutturale dal porto principale, il Porto commerciale. Il Porto industriale di Porto Torres, a ovest del Porto commerciale, gode di una posizione strategica e rappresenta la più grande piattaforma logistico industriale del centro nord dell’Isola, dato che è il principale scalo per i collegamenti Ro-Ro misti nazionali con il porto di Genova, con Civitavecchia, ed è interessato da collegamenti Ro-Ro misti internazionali. Il Porto industriale è composto da due banchine utilizzabili per traghetti, crociere, carichi solidi e liquidi, ed un terminale, sulla diga foranea, destinato al traffico di combustibili solidi, principalmente carbone, e sino a qualche anno fa anche liquidi in particolare olio combustibile. Importante polo di servizio delle aree industriali contigue dispone di uno scalo merci attrezzato.
Il lungomare Amerigo Vespucci prosegue e, in poco più di un chilometro e mezzo, ci porta al Porto industriale. Nel secondo dopoguerra si è assistito alla creazione della zona industriale e il suo relativo porto, un bacino portuale di considerevoli dimensioni e totalmente indipendente dal punto di vista strutturale dal porto principale, il Porto commerciale. Il Porto industriale di Porto Torres, a ovest del Porto commerciale, gode di una posizione strategica e rappresenta la più grande piattaforma logistico industriale del centro nord dell’Isola, dato che è il principale scalo per i collegamenti Ro-Ro misti nazionali con il porto di Genova, con Civitavecchia, ed è interessato da collegamenti Ro-Ro misti internazionali. Il Porto industriale è composto da due banchine utilizzabili per traghetti, crociere, carichi solidi e liquidi, ed un terminale, sulla diga foranea, destinato al traffico di combustibili solidi, principalmente carbone, e sino a qualche anno fa anche liquidi in particolare olio combustibile. Importante polo di servizio delle aree industriali contigue dispone di uno scalo merci attrezzato.
Negli ultimi anni, il Porto commerciale ha visto ridursi notevolmente la sua importanza, da quando i traghetti della Grimaldi prima, e successivamente anche i nuovi traghetti della Tirrenia, per le loro grandi dimensioni, hanno dovuto attraccare più vicino all’approdo industriale. Sono stati effettuati lavori per collegare i due porti e creare un’unica struttura portuale che assolva a tutte le sue funzioni.
La stazione ferrroviaria di Porto Torres Centrale
Dove la via del Ponte Romano si biforca, prendiamo a sinistra la via Fontana Vecchia. Seguiamo questa strada e, dopo cinquecento metri, arriviamo a una rotonda, dove prendiamo la prima uscita che ci fa imboccare la via Stintino, alla destra della quale, dopo qualche decina di metri, si vede la Stazione di Porto Torres Centrale. Si tratta di una stazione di categoria Bronze posta sulla linea ferroviaria a scartamento ordinario denominata Dorsale Sarda in direzione di Porto Torres Marittima, dopo la stazione di Sassari e le stazioni dismesse di Sant’Orsola, di San Giorgio, di San Giovanni, e prima della Stazione ferroviaria di Porto Torres Marittima. Si tratta della maggiore Stazione ferroviaria delle Ferrovie dello Stato nel comune di Porto Torres, la cui storia risale agli inizi negli anni ottanta del Novecento, quando è stato deciso di arretrare la stazione dalla sede originaria, che era situata nei pressi del porto alcune centinaia di metri più a nord, e di portarla alla zona di Fontana Vecchia. L’impianto viene realizzato nelle vicinanze del Rio Mannu, prima della galleria del faro turritano e dell’imbocco della diramazione sud, che all’epoca conduceva al vecchio capolinea di Porto Torres piazza Cristoforo Colombo, e che dal 2004 collega la stazione con la nuova fermata terminale di Porto Torres Marittima.
Entrata in esercizio nel 1991, la sua gestione passa nel 2001 dalle Ferrovie dello Stato alla controllata RFI. Nell’area del fabbricato viaggiatori sono presenti due binari, attrezzati con pensiline, utilizzati per il servizio passeggeri, ognuno dotato di propria banchina, mentre ulteriori binari a fianco di questi sono utilizzati per la sosta di carri, e quello più esterno costituisce l’imbocco del raccordo per il Porto industriale di Porto Torres, ancora armato ma non più utilizzato.
Il Petrolchimico di Porto Torres
 Verso occidente, proseguendo il lungomare Amerigo Vespucci, passato il Porto industriale dove attraccano i grandi traghetti, si arriva nella zona industriale di Porto Torres. L’idea di sviluppare a Porto Torres uno Stabilimento petrolchimico risale al 1959, quando a Sassari viene costituita la SIR, Sarda Industrie Resine, facente capo al gruppo dell’imprenditore brianzolo Nino Rovelli. L’ipotesi di insediare nell’area portuale quello che sarebbe divenuto, a pieno regime, uno dei più grandi poli petrolchimici europei, era suffragata da una serie di vantaggi, tra i quali la vicinanza a snodi importanti come il porto e l’Aeroporto di Fertilia, ma anche la possibilità di godere delle agevolazioni e dei contributi statali e regionali. Il piano chimico nazionale, risalente agli inizi degli anni settanta, contribuì alla crescita della SIR prevedendo progetti di ampliamento sia per Porto Torres che per gli impianti di Assemini, in provincia di Cagliari. La crisi petrolifera del 1973, che porta, quattro anni dopo, al raddoppio del costo della materia prima, causa il crollo della domanda e di conseguenza un netto calo della richiesta di materie plastiche. L’avvento dell’Ente nazionale Idrocarburi nel sito industriale di Porto Torres dà il via a un lento ma inesorabile ridimensionamento degli investimenti nell’area, in modo particolare nel settore della chimica, mentre si avvia verso una crescente importanza, anche in campo nazionale, il polo energetico, con lo sviluppo della Centrale termica ed eolica di Fiume Santo, che si trova in territorio di Sassari e che descriveremo quando parleremo di Stintino. Intanto, il sito industriale vero e proprio veniva spezzettato, con la dismissione in più aziende, solo alcune mantenute dall’Eni in proprio e poi attraverso controllate.
Verso occidente, proseguendo il lungomare Amerigo Vespucci, passato il Porto industriale dove attraccano i grandi traghetti, si arriva nella zona industriale di Porto Torres. L’idea di sviluppare a Porto Torres uno Stabilimento petrolchimico risale al 1959, quando a Sassari viene costituita la SIR, Sarda Industrie Resine, facente capo al gruppo dell’imprenditore brianzolo Nino Rovelli. L’ipotesi di insediare nell’area portuale quello che sarebbe divenuto, a pieno regime, uno dei più grandi poli petrolchimici europei, era suffragata da una serie di vantaggi, tra i quali la vicinanza a snodi importanti come il porto e l’Aeroporto di Fertilia, ma anche la possibilità di godere delle agevolazioni e dei contributi statali e regionali. Il piano chimico nazionale, risalente agli inizi degli anni settanta, contribuì alla crescita della SIR prevedendo progetti di ampliamento sia per Porto Torres che per gli impianti di Assemini, in provincia di Cagliari. La crisi petrolifera del 1973, che porta, quattro anni dopo, al raddoppio del costo della materia prima, causa il crollo della domanda e di conseguenza un netto calo della richiesta di materie plastiche. L’avvento dell’Ente nazionale Idrocarburi nel sito industriale di Porto Torres dà il via a un lento ma inesorabile ridimensionamento degli investimenti nell’area, in modo particolare nel settore della chimica, mentre si avvia verso una crescente importanza, anche in campo nazionale, il polo energetico, con lo sviluppo della Centrale termica ed eolica di Fiume Santo, che si trova in territorio di Sassari e che descriveremo quando parleremo di Stintino. Intanto, il sito industriale vero e proprio veniva spezzettato, con la dismissione in più aziende, solo alcune mantenute dall’Eni in proprio e poi attraverso controllate.
La prossima tappa del nostro viaggio
Nella prossima tappa del nostro viaggio, nella Nurra visiteremo i dintorni di Porto Torres, con le sue spiagge e con i resti archeologici tra i quali l'altare preistorico di Monte d’Accoddi e l’importante necropoli di Su Crucifissu Mannu.
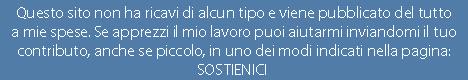
Tutte le foto e riprese sono state effettuate a scopo amatoriale per uso personale senza fini di lucro. Alle nostre foto se ne aggiungono altre inviateci da amici ed alcune tratte da Internet. Alcune informazioni sulle descrizioni dei comuni sono tratte da italiapedia.it, molte descrizioni e foto da wikimapia.org, informazioni sui siti archeologici da tharros.info, altre da siti differenti. È consentito scaricare testi, foto e riprese dell’autore per uso privato senza eliminare i riferimenti. Libri e filmati sono riprodotti per farli conoscere ma non è consentita la riproduzione delle foto di terzi, dei libri, dei filmati e di altro materiale non realizzato dall’autore. È vietato qualsiasi utilizzo commerciale del materiale in assenza di apposita autorizzazione. |
© Claudio de Tisi 2002-2025 - Codice Fiscale DTSCLD44M23F132W


































































































































































