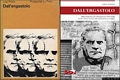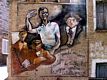Un sito di oltre 480 pagine che descrive tutta l’Isola e che pur non vendendo nulla riceve fino a oltre un migliaio di visitatori ogni giorno


Orgosolo la Città del banditismo divenuta famosa per gli oltre 150 murales che ne abbelliscono il centro storico
In questa tappa del nostro viaggio, continueremo la visita della Barbagia di Ollolai partendo da Orgosolo quello che è stato il paese del banditismo ed è ora il paese dei murales. Qui assisteremo alla processione dell’Assunta. Visiteremo poi i dintorni di Orgosolo e soprattutto l’altopiano di Pratobello.
La Regione storica della Barbagia di Ollolai
 La Barbagia di Ollolai (nome in lingua sarda Barbàgia ’e Ollolai), chiamata anche Barbagia Superiore, è una Regione storica della Sardegna centrale. Durante il periodo giudicale ha fatto parte del Giudicato d’Arborea, nellla Curatoria della Barbagia di Ollolai, è stata poi degli Aragonesi, quindi del Ducato di Mandas. Ne fanno parte i comuni: Austis, Fonni, Dorgali, Gavoi, lodine, Mamoiada, Oliena, Ollolai, Olzai, Orgosolo, Ovodda, Teti e Tiana. Secondo molti, ed anche secondo noi, alla Barbagia di Ollolai apparterrebbe anche il comune di Dorgali, che durante il periodo nel quale la Sardegna era sotto il controllo dell’impero Bizantino e nel primo periodo del Giudicato di Arborea ne costituiva uno sbocco al mare, che è andato perduto a seguito dell’espansione, promossa dai Pisani, verso sud del Giudicato di Gallura. Secondo alcuni, alla Barbagia di Ollolai apparterebbero anche i comuni di Orani e Sarule, che noi attribuiamo, invece, al Nuorese, noto anche come Barbagia di Nuoro o Barbagia di Bitti.
La Barbagia di Ollolai (nome in lingua sarda Barbàgia ’e Ollolai), chiamata anche Barbagia Superiore, è una Regione storica della Sardegna centrale. Durante il periodo giudicale ha fatto parte del Giudicato d’Arborea, nellla Curatoria della Barbagia di Ollolai, è stata poi degli Aragonesi, quindi del Ducato di Mandas. Ne fanno parte i comuni: Austis, Fonni, Dorgali, Gavoi, lodine, Mamoiada, Oliena, Ollolai, Olzai, Orgosolo, Ovodda, Teti e Tiana. Secondo molti, ed anche secondo noi, alla Barbagia di Ollolai apparterrebbe anche il comune di Dorgali, che durante il periodo nel quale la Sardegna era sotto il controllo dell’impero Bizantino e nel primo periodo del Giudicato di Arborea ne costituiva uno sbocco al mare, che è andato perduto a seguito dell’espansione, promossa dai Pisani, verso sud del Giudicato di Gallura. Secondo alcuni, alla Barbagia di Ollolai apparterebbero anche i comuni di Orani e Sarule, che noi attribuiamo, invece, al Nuorese, noto anche come Barbagia di Nuoro o Barbagia di Bitti.
In viaggio verso Orgosolo
A Orgosolo possiamo arrivare direttamente da Nuoro percorrendo verso sud con la SP58; oppure da Oliena, che abbiamo visitato in una precedente tappa del nostro viaggio, con la SP22ter. In entrambi i casi, entriamo nella Regione storica della Barbagia di Ollolai.
Lungo la SP58 che da Nuoro porta a Orgosolo troviamo la necropoli di Su Calavriche ed i primi massi decorati
Arriviamo a Orgosolo da Nuoro, uscendo lungo via Miughina dalla quale prendiamo la SP58, che ci porta a Orgosolo con un percorso di poco meno di venti chilometri. Lungo la SP58, che da Nuoro porta a Orgosolo, a una diecina di chilometri da Nuoro, si trova la Necropoli di Su Calavriche che descriveremo più avanti. Lungo questa strada, prima dell’ingresso in Orgosolo, troviamo i primi massi di granito decorati, quasi un anticipo dei murales che troveremo più avanti in tutte le vie del paese.
Lungo la SP22ter che da Oliena porta a Orgosolo si trova la Cantoniera lannas e la diga di Cumbidanovu
Possiamo arrivare a Orgosolo anche da Oliena, uscendo lungo via Italia dalla quale prendiamo la SP22ter, che ci porta a Orgosolo con un percorso di poco più di sedici chilometri tra diverse curve e tornanti. Da qui, proseguendo su una strada molto bella, che si sviluppa alla base delle falde del Supramonte, arriviamo a Orgosolo.
Il comune chiamato Orgosolo famoso per i suoi murales

 Il comune chiamato Orgosolo il cui nome si pronuncia Orgòsolo (altezza metri 620 sul livello del mare, abitanti 3.950 al 31 dicembre 2021) è un paese che affonda le sue origini nella preistoria con un’economia di tipo essenzialmente agricolo, posto nella Barbagia di Ollolai, nella parte centro orientale della provincia. Il paese sorge su un ripido pendio ai margini settentrionali dell’altopiano di Pratobello, che ha origine nei contrafforti settentrionali del massiccio del Gennargentu. Il territorio Comunale, comprensivo delle aree speciali di Campu Donanigoro in contestazione con il comune di Dorgali, di S’aliderrargiu, e di Settile Osporrai in contestazione con il comune di Oliena, ha un profilo geometrico irregolare, con variazioni altimetriche molto accentuate, dato che si raggiungono i 1.433 metri di quota. Il paese chiamato Orgosolo è il paese più rappresentativo della cultura barbaricina, ed è meta di discreto afflusso turistico, molti sono, infatti, coloro che decidono di visitare le sue innumerevoli bellezze archeologiche e naturalistiche, ed il centro dell’abitato famoso per i suoi murales. Particolarmente attraente è il vicino Supramonte, meta ambita da escursionisti e amanti della montagna, la cui natura aspra e selvaggia è tra i paesaggi più belli ed affascinanti che gli amanti del trekking possano trovare.
Il comune chiamato Orgosolo il cui nome si pronuncia Orgòsolo (altezza metri 620 sul livello del mare, abitanti 3.950 al 31 dicembre 2021) è un paese che affonda le sue origini nella preistoria con un’economia di tipo essenzialmente agricolo, posto nella Barbagia di Ollolai, nella parte centro orientale della provincia. Il paese sorge su un ripido pendio ai margini settentrionali dell’altopiano di Pratobello, che ha origine nei contrafforti settentrionali del massiccio del Gennargentu. Il territorio Comunale, comprensivo delle aree speciali di Campu Donanigoro in contestazione con il comune di Dorgali, di S’aliderrargiu, e di Settile Osporrai in contestazione con il comune di Oliena, ha un profilo geometrico irregolare, con variazioni altimetriche molto accentuate, dato che si raggiungono i 1.433 metri di quota. Il paese chiamato Orgosolo è il paese più rappresentativo della cultura barbaricina, ed è meta di discreto afflusso turistico, molti sono, infatti, coloro che decidono di visitare le sue innumerevoli bellezze archeologiche e naturalistiche, ed il centro dell’abitato famoso per i suoi murales. Particolarmente attraente è il vicino Supramonte, meta ambita da escursionisti e amanti della montagna, la cui natura aspra e selvaggia è tra i paesaggi più belli ed affascinanti che gli amanti del trekking possano trovare.
Si tratta di uno dei paesi dove la speranza di vita è più alta rispetto alla media mondiale
 Il comune appartiene ad una delle zone blu dove la speranza di vita è più alta rispetto alla media mondiale. Il termine Zone blu, in inglese darkslateblue Zones, viene usato per identificare le aree demografiche o geografiche del mondo in cui la speranza di vita è notevolmente più alta rispetto alla media mondiale. Il concetto è nato quando gli studiosi Gianni Pes e Michel Poulain hanno pubblicato su Experimental Gerontology il loro studio demografico sulla longevità umana, che identifica la provincia di Nuoro, in Sardegna, come l’area con la maggiore concentrazione di centenari al mondo. Gli studiosi, per procedere nel lavoro, tracciavano sulla mappa delle serie di cerchi concentrici blu che indicavano le zone con la più alta longevità, da qui il termine Zona blu. I paesi appartenenti alle zone blu in Sardegna sono Arzana, Baunei, Fonni, Gavoi, Mamoiada, Oliena, Ollolai, Orgosolo, Ovodda, Perdasdefogu, Seulo, Talana, Tiana, Ulassai, Urzulei, Villagrande Strisaili.
Il comune appartiene ad una delle zone blu dove la speranza di vita è più alta rispetto alla media mondiale. Il termine Zone blu, in inglese darkslateblue Zones, viene usato per identificare le aree demografiche o geografiche del mondo in cui la speranza di vita è notevolmente più alta rispetto alla media mondiale. Il concetto è nato quando gli studiosi Gianni Pes e Michel Poulain hanno pubblicato su Experimental Gerontology il loro studio demografico sulla longevità umana, che identifica la provincia di Nuoro, in Sardegna, come l’area con la maggiore concentrazione di centenari al mondo. Gli studiosi, per procedere nel lavoro, tracciavano sulla mappa delle serie di cerchi concentrici blu che indicavano le zone con la più alta longevità, da qui il termine Zona blu. I paesi appartenenti alle zone blu in Sardegna sono Arzana, Baunei, Fonni, Gavoi, Mamoiada, Oliena, Ollolai, Orgosolo, Ovodda, Perdasdefogu, Seulo, Talana, Tiana, Ulassai, Urzulei, Villagrande Strisaili.
Questo paese fa parte dell’Associazione nazionale delle Città dell’Olio
 Questo paese fa parte della Associazione nazionale Città dell’Olio, che ha tra i suoi compiti principali quello di divulgare la cultura dell’olivo e dell’olio di oliva di qualità, tutelare e promuovere l’ambiente ed il paesaggio olivicolo, diffondere la storia dell’olivicoltura, e garantire il consumatore attraverso le denominazioni di origine. Le Città dell’Olio in Sardegna sono ad oggi Alghero, Berchidda, Bolotana, Bosa, Cuglieri, Dolianova, Escolca, Genuri, Gergei, Giba, Gonnosfanadiga, Ilbono, Ittiri, Masainas, Olbia, Oliena, Orgosolo, Orosei, Osini, Riola Sardo, Samatzai, Santadi, Seneghe, Sennori, Serrenti, Siddi, Sini, Uri, Usini, Ussaramanna, Vallermosa, Villacidro, Villamassargia.
Questo paese fa parte della Associazione nazionale Città dell’Olio, che ha tra i suoi compiti principali quello di divulgare la cultura dell’olivo e dell’olio di oliva di qualità, tutelare e promuovere l’ambiente ed il paesaggio olivicolo, diffondere la storia dell’olivicoltura, e garantire il consumatore attraverso le denominazioni di origine. Le Città dell’Olio in Sardegna sono ad oggi Alghero, Berchidda, Bolotana, Bosa, Cuglieri, Dolianova, Escolca, Genuri, Gergei, Giba, Gonnosfanadiga, Ilbono, Ittiri, Masainas, Olbia, Oliena, Orgosolo, Orosei, Osini, Riola Sardo, Samatzai, Santadi, Seneghe, Sennori, Serrenti, Siddi, Sini, Uri, Usini, Ussaramanna, Vallermosa, Villacidro, Villamassargia.
Origine del nome
Il suo nome, di origine antichissima, è attestato fino dal 1341 nelle forme Orgusulla o Orgosuli. La sua origine si fa risalire al termine greco antico Oργάσ-Oργέ, o all’appellativo di origine preromana Orgòsoa, col significato di terra fertile, terra umida, ipotesi confermata dal fatto che in lingua sarda, e nella variante orgolese in particolare, le voci òrga e orgòsa indicano un sito ricco di sorgenti, ancora usati nell’area barbaricina come si evince anche da altri nomi locali sardi della zona interna, e come in effetti è il centro storico del paese.
La sua economia
Il comune di Orgosolo ha sempre vissuto di una economia agropastorale, presente con la coltivazione di cereali, ortaggi, foraggi, vite, ulivi, agrumeti, frutteti e con l’allevamento di bovini, suini, ovini, caprini, equini e avicoli. L’industria è costituita da un piccolo numero di aziende che operano nei comparti alimentare, tessile, metallurgico ed edile. Il terziario si compone di una sufficiente rete distributiva oltre che dell’insieme dei servizie. Il suo Supramonte è stato per molto tempo collegato ai fenomeni del banditismo e della latitanza. Il paese chiamato orgosolo ha, però, recentemente scoperto una sua vena turistica, soprattutto per il fascino esercitato dai suoi famosi murales. Molti sono, infatti, coloro che decidono di visitare le sue innumerevoli bellezze archeologiche e naturalistiche.  Particolarmente attraente è il vicino Supramonte, meta ambita da escursionisti e amanti della montagna. I suoi impervi sentieri permettono di raggiungere le numerose grotte e valli di cui è ricco il territorio e di ammirare una vegetazione rigogliosa, composta da boschi di lecci e di roverelle, di ginepri, di aceri, di tassi, di eriche e di ginestre, nonché di avvistare mufloni, aquile, grifoni e falchi. E in una visita a Orgosolo non può mancare il pranzo tipico cucinato e servito dai pastori, nel bel mezzo di boschi secolari e incontaminati nel Supramonte, convivi che si tengono all’aperto a diretto contatto con l’ambiente naturale in aree attrezzate all’interno dei boschi di leccio con i sapori e i profumi dei prodotti tipici del menu, rigorosamente a base di prodotti locali e apprezzato dalla generalità degli utenti. Ad Orgosolo l’apparato ricettivo offre possibilità di ristorazione e di soggiorno.
Particolarmente attraente è il vicino Supramonte, meta ambita da escursionisti e amanti della montagna. I suoi impervi sentieri permettono di raggiungere le numerose grotte e valli di cui è ricco il territorio e di ammirare una vegetazione rigogliosa, composta da boschi di lecci e di roverelle, di ginepri, di aceri, di tassi, di eriche e di ginestre, nonché di avvistare mufloni, aquile, grifoni e falchi. E in una visita a Orgosolo non può mancare il pranzo tipico cucinato e servito dai pastori, nel bel mezzo di boschi secolari e incontaminati nel Supramonte, convivi che si tengono all’aperto a diretto contatto con l’ambiente naturale in aree attrezzate all’interno dei boschi di leccio con i sapori e i profumi dei prodotti tipici del menu, rigorosamente a base di prodotti locali e apprezzato dalla generalità degli utenti. Ad Orgosolo l’apparato ricettivo offre possibilità di ristorazione e di soggiorno.
Brevi cenni storici
La storia di Orgosolo parte dalle prime tracce di insediamenti umani che risalgono al periodo preistorico,come testimoniano i numerosissimi resti di età preistorica, in particolare quelli del Neolitico Medio. Fino al quarto secolo dopo Cristo la sua popolazione adora ancora gli spiriti della natura, ed oppone una forte resistenza ai tentativi di conquista dei Cartaginesi e dei Romani. I primi missionari non sono ben accetti e la maggior parte di essi subisce il martirio. Si ricorda che nel 301 vengono uccisi i Santi Anania ed Egidio. Dal sesto secolo inizia, però, la conversione al Cristianesimo. In epoca medievale, nel periodo giudicale, il territorio orgolese appartiene alla curatoria di Sarule, nel Giudicato di Logudoro, per passare in seguito a quello d’Arborea. Le prime testimonianze dell’esistenza di un piccolo centro abitato risalgono alla prima metà del 1300. Con la conquista degli Aragonesi, nel 1324 viene concessa in feudo ai Carroz, e nel 1617 viene incorporata nel Marchesato di Orani. Durante la dominazione aragonese, e poi spagnola, iniziano i primi fenomeni di resistenza, che sfoceranno nel tradizionale banditismo tipico delle località interne dell’Isola, dato che Orgosolo è il paese più rappresentativo della cultura barbaricina. Quindi, con la cessione ai Savoia, l’aggravio delle tasse porta una recrudescenza degli atti banditeschi. Lontana dalle vie di comunicazione, Orgosolo non vive i moti antifeudali della fine del Settecento e in essa non viene applicata la legge delle Chiudende. Con il Novecento iniziano i primi progressi nelle condizioni di vita materiale ed intellettuale, pur dovendosi registrare ancora fenomeni di banditismo, che vedranno nel bandito Graziano Mesina, la primula rossa del Supramonte, il suo eroe. In periodo Repubblicano, del comune di Orgosolo nel 1927, dopo la creazione della provincia di Nuoro, viene cambiata la provincia, da quella di Sassari a quella di Nuoro.  Il 27 maggio 1969 sui muri di Orgosolo compaiono i manifesti intestati alla Brigata Trieste, il cui testo impone di abbandonare la zona e trasferire il bestiame altrove perché per due mesi il terreno da pascolo diventerà un poligono di tiro. La notizia non ufficiale è, però, che il poligono temporaneo diventerà in seguito un campo permanente. Ma la popolazione si oppone all’ennesima espropriazione e, dopo un’assemblea popolare, decide di occupare fisicamente i terreni in oggetto per impedire lo svolgersi delle esercitazioni di tiro. Nonostante l’intervento di carabinieri e polizia, la gente è irremovibile e, per la prima volta in tempi moderni, una mobilitazione popolare riesce a bloccare l’occupazione del territorio sardo. Dal 1975 in poi, l’amministrazione Comunale commissiona a Francesco Del Casino, a cui, coadiuvato dalle Scuole Medie e dai pittori orgosolesi Pasquale Buesca e Vincenzo Floris, si deve la creazione dei murales sulla facciata delle abitazioni del centro cittadino. Tali lavori rappresentano la vita politica e sociale propria di quegli anni, e la passione politica e sociale continua a vivere nel paese e nelle centinaia di murales che sono stati dipinti sulle facciate delle case e sulle rocce intorno al paese, e che vedremo più avanti.
Il 27 maggio 1969 sui muri di Orgosolo compaiono i manifesti intestati alla Brigata Trieste, il cui testo impone di abbandonare la zona e trasferire il bestiame altrove perché per due mesi il terreno da pascolo diventerà un poligono di tiro. La notizia non ufficiale è, però, che il poligono temporaneo diventerà in seguito un campo permanente. Ma la popolazione si oppone all’ennesima espropriazione e, dopo un’assemblea popolare, decide di occupare fisicamente i terreni in oggetto per impedire lo svolgersi delle esercitazioni di tiro. Nonostante l’intervento di carabinieri e polizia, la gente è irremovibile e, per la prima volta in tempi moderni, una mobilitazione popolare riesce a bloccare l’occupazione del territorio sardo. Dal 1975 in poi, l’amministrazione Comunale commissiona a Francesco Del Casino, a cui, coadiuvato dalle Scuole Medie e dai pittori orgosolesi Pasquale Buesca e Vincenzo Floris, si deve la creazione dei murales sulla facciata delle abitazioni del centro cittadino. Tali lavori rappresentano la vita politica e sociale propria di quegli anni, e la passione politica e sociale continua a vivere nel paese e nelle centinaia di murales che sono stati dipinti sulle facciate delle case e sulle rocce intorno al paese, e che vedremo più avanti.
Principali personaggi nati ad Orgosolo
Ad Orgosolo sono nati, tra gli altri, la beata Antonia Mesina; Luigi Podda, pastore e contadino, eroico partigiano, ergastolano e scrittore vincitore del Premio Viareggio; e Peppino Marotto, poeta, cantante e sindacalista.
Il costume tradizionale di Orgosolo
 Molto sentite sono le principali feste e sagre che si svolgono a Orgosolo, sia quelle della Pasqua che quelle religiose, che si celebrano partendo dalle diverse Chiese che si trovano nell’abitato. Durante le feste è possibile ammirare il costume tradizionale di Orgosolo, uno dei più originali e apprezzati di tutta la Sardegna, le cui antiche origini si perdono nella notte dei tempi, dato che particolari disegni del grembiule del costume femminile sono stati ritrovati in alcune tombe cretesi. La tradizione prevede un costume femminile molto più elaborato e ricco di varianti rispetto a quello maschile, che è abbastanza uniforme.
Molto sentite sono le principali feste e sagre che si svolgono a Orgosolo, sia quelle della Pasqua che quelle religiose, che si celebrano partendo dalle diverse Chiese che si trovano nell’abitato. Durante le feste è possibile ammirare il costume tradizionale di Orgosolo, uno dei più originali e apprezzati di tutta la Sardegna, le cui antiche origini si perdono nella notte dei tempi, dato che particolari disegni del grembiule del costume femminile sono stati ritrovati in alcune tombe cretesi. La tradizione prevede un costume femminile molto più elaborato e ricco di varianti rispetto a quello maschile, che è abbastanza uniforme.  Il costume femminile è un allegro e continuo contrasto di vivaci colori: dal rosso del corpetto, ai disegni stilizzati del grembiule, fino ad arrivare al giallo della benda sopra il capo. In particolare la benda coprivapo femminile detta su lionzu è un capo esclusivamente orgolese, in quanto il baco che produce la seta, una specie selezionatasi nei secoli battezzata appunto Orgosolo, viene allevato in alcune famiglie del paese. Il costume maschile ha carattere più sobrio, ed anche in questo caso predomina il rosso della giacca detta su zippone e il velluto blu scuro. Entrambi i costumi sono fatti interamente a mano. Nella parte inferiore il gonnellino detto sa fraca, in orbace nero, tenuto con la cintura in pelle nera, ed i calzoni bianche molto semplici, che all’estremita inferiore sono inseriti nelle ghette.
Il costume femminile è un allegro e continuo contrasto di vivaci colori: dal rosso del corpetto, ai disegni stilizzati del grembiule, fino ad arrivare al giallo della benda sopra il capo. In particolare la benda coprivapo femminile detta su lionzu è un capo esclusivamente orgolese, in quanto il baco che produce la seta, una specie selezionatasi nei secoli battezzata appunto Orgosolo, viene allevato in alcune famiglie del paese. Il costume maschile ha carattere più sobrio, ed anche in questo caso predomina il rosso della giacca detta su zippone e il velluto blu scuro. Entrambi i costumi sono fatti interamente a mano. Nella parte inferiore il gonnellino detto sa fraca, in orbace nero, tenuto con la cintura in pelle nera, ed i calzoni bianche molto semplici, che all’estremita inferiore sono inseriti nelle ghette.
Le pricipali sagre e feste che si svolgono a Orgosolo
Ad Orgosolo sono attivi il Gruppo Folk MurAles, dell’omonima Associazione Culturale, nato con l’obiettivo di tutelare e valorizzare tutte le espressioni della cultura popolare Orgolese e Sarda; ed il Gruppo Folk Antonia Mesina, nato nel 1992 e rinnovato nel tempo, che ora è composto principalmente da giovani. È attiva, inoltre, la Corale Polifonica Orgolese, un coro costituito nel 1969 su iniziativa di don Luciano Pala, caratterizzato da un’impronta prevalentemente liturgica che si pone lo scopo di animare le celebrazioni liturgiche della comunità parrocchiale di Orgosolo.
Tra le principali feste e sagre che si svolgono ad Orgosolo ricordiamo, il 16 e 17 gennaio, la Festa di Sant’Antonio Abate, per la quale vengono accesi dei fuochi all’aperto nei vari rioni del paese, con la legna generalmente di quercia che viene raccolta dai ragazzini nelle settimane percedenti alla festa, passando in rassegna le abitazioni del paese chiedendo su truncheddu pro Sant’Antoni; il Carnevale di Orgosolo chiamato su Harrasehare, che si celebra nel mese di febbraio e gran parte dei giovani del paese partecipano alla sfilata con carri originalissimi, la cui lavorazione spesso richiede interi mesi; i riti della Settimana Santa per la quale hanno luogo i riti pasquali e la mattina di Pasqua si ha la processione de S’Incontru, in cui avviene l’incontro di Gesù Cristo Risorto con la Madre vestita ancora a lutto; il 25 aprile la Festa di San Marco Evangelista con la benedizione dei campi, per la quale dopo la messa, le famiglie che hanno ottenuto grazie per l’intercessione del Santo offrono ai ragazzi convenuti in gran numero grosse porzioni di sa ita, la carne e il pane preparato artigianalmente; il 17 maggio, la data in cui questa giovane orgolese è stata martirizzata, si svolge la Festa di Antonia Mesina, detta sa esta de Antonia Mesina, che ha luogo nelle campagne del paese e registra grande affluenza turistica, motivata soprattutto dai piatti squisiti che vengono preparati come carne arrosto e patata a perras, ossia patate con carne di pecora bollita; la prima o la seconda domenica di giugno la Festa di Santu Anania, nella chiesa campestre dei Santi Martiri Egidio ed Anania, intitolata ai due martiri uccisi mentre diffondevano il Vangelo, che prevede la celebrazione della messa solenne, seguita dalla tipica processione in costume sardo e una corsa di cavalli; il 17 maggio in ricordo della morte, o il 19 giugno in ricordo della nascita, si svolgono le cerimonie di Commemorazione della beata Antonia Mesina; il 29 giugno la Festa dei patroni i Santi Pietro e Paolo; il 15 agosto, al culmine del ferragosto orgolese, la Festa di Santa Maria Vergine Assunta, ossia la festa di Nostra Sennora de Mesaustu, con suggestiva processione e sfilata in costumi tradizionali; a metà ottobre, la manifestazione Autunno in Barbagia, con eventi e concerti; il 31 dicembre si svolge la festa chiamata Sa Candelaria che potremmo definire la festa dei bambini.
I riti della Settimana Santa
La tradizione vuole che la domenica delle palme ci sia, appunto, la benedizione delle palme e degli ulivi nella chiesa di San Pietro, seguita dalla processione. Poi si svolgono le celebrazioni della Settimana Santa. Giovedì santo si celebra la messa con la lavanda dei piedi, a seguire l’adorazione del Sepolcro.  Venerdì Santo si tiene l’adorazione della Croce e in serata, la Via Crucis per le strade del paese. Segue il rito di S’Iscravamentu nella chiesa di San Pietro con la collaborazione delle due confraternite. Immediatamente dopo quello della sepoltura, in processione, il Cristo morto viene accompagnato in preghiera nella chiesa di Santa Croce, al suono delle metraculas, congegni costituiti da una tavola in legno di forma rettangolare, che possiedono una parte centrale fissa alla quale sono incernierati elementi percussivi azionati dal movimento periodico di polso e o dell’avambraccio. La notte di Pasqua si svolge la veglia. La domenica di Pasqua in mattinata il rito di S’Incontru che si svolge come da tradizione in piazza Caduti. Le due processioni vengono aperte dalle due confraternite, quella con il Cristo morto parte dalla chiesa di Santa Croce, mentre quella con la Madonna ancora vestita di lutto che cerca il figlio morto, parte dalla chiesa di San Pietro.
Venerdì Santo si tiene l’adorazione della Croce e in serata, la Via Crucis per le strade del paese. Segue il rito di S’Iscravamentu nella chiesa di San Pietro con la collaborazione delle due confraternite. Immediatamente dopo quello della sepoltura, in processione, il Cristo morto viene accompagnato in preghiera nella chiesa di Santa Croce, al suono delle metraculas, congegni costituiti da una tavola in legno di forma rettangolare, che possiedono una parte centrale fissa alla quale sono incernierati elementi percussivi azionati dal movimento periodico di polso e o dell’avambraccio. La notte di Pasqua si svolge la veglia. La domenica di Pasqua in mattinata il rito di S’Incontru che si svolge come da tradizione in piazza Caduti. Le due processioni vengono aperte dalle due confraternite, quella con il Cristo morto parte dalla chiesa di Santa Croce, mentre quella con la Madonna ancora vestita di lutto che cerca il figlio morto, parte dalla chiesa di San Pietro.
Il ferragosto di Orgosolo e la processione dell’Assunta
Nonostante il patrono di Orgosolo sia San Pietro Apostolo e la sua festa sia molto sentita e celebrata nel paese, la festa grande che si celebra è la Festa della Madonna dell’Assunta, chiamata la Festa di Nostra Sennora de Mesaustu ossia di mezzo agosto, che si svolge appunto il 15 di agosto. La festa più antica di origine precristiana e più sentita ad Orgosolo è il Ferragosto, che segna la chiusura della stagione agricola passata e l’inizio di quella nuova. In questo giorno viene festeggiata la Beata Vergine Assunta, Nostra Sennora de Mesaustu, presso la chiesa di S’Assunta del 1634, situata in uno dei rioni del paese. È una delle più spettacolari manifestazioni religiose della Barbagia. Il poster propone la sagra della Madonna dell’Assunta del 15 agosto 2001. Anche qui, come abbiamo visto a Dorgali, il cavallo è al centro dei festeggiamenti, cavalcato da adulti, giovani ed anche dai bambini. Nella serata del 15 dopo la messa solenne, dalla chiesa dell’Assunta al cui interno è custodita un’antica immagine della Beata Vergine, inizia una bellissima e pittoresca processione che porta la statua della Madonna, dopo la vestizione, con stendardi e donne nei costumi tradizionali, cavalieri chiamati Sos Vardieris con più di 150 cavalli e carri addobbati a festa, e con numerosi fedeli. Sfilano per primi i giovani, che costituiscono la parte più folkloristica della sfilata, dato che sono tutti abbigliati negli splendidi costumi locali. Sfilano, poi, i religiosi che accompagnano il simulacro delle Vergine Assunta dormiente, molto pesante e per questo sorretta da quattro uomini a spalla, accompagnato dai cavalieri seguiti dalle donne nel loro abbigliamento tradizionale. La processione religiosa è particolarmente suggestiva per i colori e per le preghiere recitate in lingua sarda. Al termine della processione viene offerto ai partecipanti un tipico dolce detto S'Aranzada, accompagnato da buon vino.
Terminata la processione, i cavalieri danno luogo a spettacoli di abilità, con sfilate per le vie del paese, competizioni equestri, e prove di destrezza a pariglia correndo Sa VArdia, ossia una spettacolare corsa con i cavalli che vengono lanciati a coppie o a gruppi di tre e su cui i cavalieri si esibiscono in acrobazie spesso rischiose, ed in serata c’è la corsa equestre Su Palu, ossia il Palio, la sfrenata corsa a cavallo che vede la partecipazione di tantissimi cavalieri provenenti da tutta la Sardegna. Tutte le corse si svolgono sull’asfalto cittadino. La sera nella piazza si tiene la Rassegna di Tenores e si svolgono balli folkloristici sardi. La festa civile si sviluppa nell’arco di nove giorni, dal 14 al 23 agosto. Il 23, giorno di S’Ottada, ossia dell’ottava dopo ferragosto, il paese partecipa nuovamente alla processione, stavolta notturna, in cui comunque non mancano i cavalli e i colori dei costumi. Le serate serate sono allietate da spettacoli di ogni tipo che non mancano di attirare folle di turisti.
Sa Candelaria la festa dei bambini
 Inoltre, ogni anno ad Orgosolo il 31 dicembre si svolge la festa chiamata Sa Candelaria che potremmo definire la festa dei bambini, i quali in tale data escono di buon mattino e percorrono le vie del paese con un sacco di tela e chiedono in ciascuna casa sa candelaria, ed ai quali ogni famiglia offre il pane ossia sos coccones, frutta, biscotti, dolci, caramelle e qualche soldino, ed i bambini ringraziano pronunciano una frase di buon auspicio e continuano la raccolta fino a mezzogiorno, mentre di sera è la volta dei giovani e degli adulti che si riuniscono in gruppi e vanno a cantare i loro auguri a casa delle coppie che si sono sposate durante l’anno che sta volgendo al termine.
Inoltre, ogni anno ad Orgosolo il 31 dicembre si svolge la festa chiamata Sa Candelaria che potremmo definire la festa dei bambini, i quali in tale data escono di buon mattino e percorrono le vie del paese con un sacco di tela e chiedono in ciascuna casa sa candelaria, ed ai quali ogni famiglia offre il pane ossia sos coccones, frutta, biscotti, dolci, caramelle e qualche soldino, ed i bambini ringraziano pronunciano una frase di buon auspicio e continuano la raccolta fino a mezzogiorno, mentre di sera è la volta dei giovani e degli adulti che si riuniscono in gruppi e vanno a cantare i loro auguri a casa delle coppie che si sono sposate durante l’anno che sta volgendo al termine.
Orgòsolo pro terra de bandidos...
Le crisi economiche e politiche di fine Ottocento provocano nuovi episodi banditismo illustrati da diversi autori, tanto da farle assegnare il nome di terra di banditi. Orgosolo conosce l’epopea della faida nei primi anni del Novecento, quando scoppia una vera guerra tra famiglie, alla quale venne dato il nome di disamistade, ossia inimicizia, proprio per le sue proporzioni e la particolare collocazione nel tessuto sociale. Per oltre dieci anni, dal 1905 al 1917, vede Orgosolo spaccato in due partiti contrapposti, legati alle due famiglie dei Cossu e dei Corraine, ed alle famiglie loro alleate. La disamistade inizia ufficialmente nel 1905, ma era scoppiata già nel 1903, per la divisione dell’eredità di uno dei più ricchi proprietari del paese. Ha origine il 3 aprile del 1905, quando a Corriolu di San Vero Milis, piccolo centro del Campidano, Carmine Corraine viene ucciso per mano di Egidio Podda, legato alla famiglia dei Cossu. La disamistade si concluderà il 25 giugno del 1917, quando verrà chiusa con la il processo celebrato fra il 15 marzo e il 25 giugno 1917 alla Corte di Assise di Sassari, che determinerà, l’assoluzione di tutti gli imputati. Il tutto finisce con una pace ufficiale, ma nel frattempo sul terreno rimangono decine di vittime, tra le quali anche dei bambini.
La battaglia di Murguliai
 Tra il 9 e il 10 luglio 1899, nella densa boscaglia di Morgogliai, tra Orgosolo ed Oliena, uno dei pochi valichi dal territorio orgolese a quello dell’Ogliastra, si è verificato un durissimo conflitto a fuoco tra carabinieri e latitanti che viene ricordato come la battaglia di Murguliai, nome che in dialetto di Orgosolo indica la località di Morgogliai, dove rimangono uccisi il famigerato bandito Tommaso Virdis, i fratelli Giacomo ed elias Serra Sanna, ed il latitante Giuseppe Pau. Dall’altra parte perdono la vita il carabiniere Aventino Moretti, che qualche tempo prima ha ucciso in conflitto il famoso bandito olianese Giovanni Battista Salis detto Corbeddu, ed il soldato Rosario Amato, mentre viene ferito il vicebrigadiere loranzo Gasco. Creduto morto, l’unico a farla franca è Giuseppe loddo, detto lovicu, che riesce a salvarsi la pelle arrampicandosi su un albero e restandoci per ore e ore. Si trattava dell’ennesima partita di caccia all’uomo, che in meno di due mesi aveva portato alla cattura di sessantaquattro latitanti, su venticinque dei quali pesava una taglia, che rappresenta una delle pagine più drammatiche della storia criminale sarda.
Tra il 9 e il 10 luglio 1899, nella densa boscaglia di Morgogliai, tra Orgosolo ed Oliena, uno dei pochi valichi dal territorio orgolese a quello dell’Ogliastra, si è verificato un durissimo conflitto a fuoco tra carabinieri e latitanti che viene ricordato come la battaglia di Murguliai, nome che in dialetto di Orgosolo indica la località di Morgogliai, dove rimangono uccisi il famigerato bandito Tommaso Virdis, i fratelli Giacomo ed elias Serra Sanna, ed il latitante Giuseppe Pau. Dall’altra parte perdono la vita il carabiniere Aventino Moretti, che qualche tempo prima ha ucciso in conflitto il famoso bandito olianese Giovanni Battista Salis detto Corbeddu, ed il soldato Rosario Amato, mentre viene ferito il vicebrigadiere loranzo Gasco. Creduto morto, l’unico a farla franca è Giuseppe loddo, detto lovicu, che riesce a salvarsi la pelle arrampicandosi su un albero e restandoci per ore e ore. Si trattava dell’ennesima partita di caccia all’uomo, che in meno di due mesi aveva portato alla cattura di sessantaquattro latitanti, su venticinque dei quali pesava una taglia, che rappresenta una delle pagine più drammatiche della storia criminale sarda.
La battalia di Osposidda
 Nel periodo dei sequestri di persone in Sardegna, un rapimento noto è quello del 17 gennaio 1985, quando venne sequestrato Tonino Caggiari, piccolo imprenditore di Oliena. Per la sua liberazione avviene un tremendo conflitto a fuoco in località Osposidda, una zona campestre tra i comuni di Orgosolo e Oliena. Questo conflitto a fuoco vede quattro ore di intensi combattimenti con migliaia di colpi sparati e numerosi lanci di bombe a mano, e con la partecipazione di centinaia di uomini tra poliziotti, carabinieri e volontari olianesi, e viene ricordato come la battaglia di Osposidda. Sono i volontari olianesi ad indicare il luogo dove i rapitori si sono fermati, in località Osposidda. Il 18 gennaio, gli uomini ritrovano delle tracce che vengono fatte risalire ai rapitori. Le tracce portano le forze dell’ordine nei pressi di un canalone ricco di vegetazione da cui odono colpi di arma da fuoco che la banda sta sparando contro i civili impegnati nella ricerca del Caggiari. Sono proprio i civili a ritrovare il Caggiari, che era stato rilasciato incolume dai sequestratori, ed a condurlo successivamente presso la caserma dei carabinieri di Oliena. Abbandonato il sequestrato, i malviventi ingaggiano un conflitto a fuoco con la Polizia. I primi, che cercano di raggiungere il versante del Supramonte opposto a quello dove si trovavano, lanciano contro i militari anche una bomba a mano. Nel primo conflitto a fuoco muore il latitante Giuseppe Mesina. Anche il sovrintendente Vincenzo Marongiu ingaggia un conflitto a fuoco con i banditi, rimanendo ucciso da due fucilate al petto ed egli è l’unica vittima tra le forze dell’ordine, mentre Mauro Torti, comandante della squadra cinofili di Nuoro, e il carabiniere Carmelo Mureddu rimangono feriti. Il maresciallo Serra, abbandonata la sua postazione, nota la canna di un fucile che da un cespuglio gli è puntata contro. Riesce a spostarla e ad esplodere dei colpi verso il cespuglio. Anche l’agente Daniele ladu esplode dei colpi verso il cespuglio. Rimarranno uccisi nello scontro i due latitanti Giovanni Corraine e Salvatore Fais.
Nel periodo dei sequestri di persone in Sardegna, un rapimento noto è quello del 17 gennaio 1985, quando venne sequestrato Tonino Caggiari, piccolo imprenditore di Oliena. Per la sua liberazione avviene un tremendo conflitto a fuoco in località Osposidda, una zona campestre tra i comuni di Orgosolo e Oliena. Questo conflitto a fuoco vede quattro ore di intensi combattimenti con migliaia di colpi sparati e numerosi lanci di bombe a mano, e con la partecipazione di centinaia di uomini tra poliziotti, carabinieri e volontari olianesi, e viene ricordato come la battaglia di Osposidda. Sono i volontari olianesi ad indicare il luogo dove i rapitori si sono fermati, in località Osposidda. Il 18 gennaio, gli uomini ritrovano delle tracce che vengono fatte risalire ai rapitori. Le tracce portano le forze dell’ordine nei pressi di un canalone ricco di vegetazione da cui odono colpi di arma da fuoco che la banda sta sparando contro i civili impegnati nella ricerca del Caggiari. Sono proprio i civili a ritrovare il Caggiari, che era stato rilasciato incolume dai sequestratori, ed a condurlo successivamente presso la caserma dei carabinieri di Oliena. Abbandonato il sequestrato, i malviventi ingaggiano un conflitto a fuoco con la Polizia. I primi, che cercano di raggiungere il versante del Supramonte opposto a quello dove si trovavano, lanciano contro i militari anche una bomba a mano. Nel primo conflitto a fuoco muore il latitante Giuseppe Mesina. Anche il sovrintendente Vincenzo Marongiu ingaggia un conflitto a fuoco con i banditi, rimanendo ucciso da due fucilate al petto ed egli è l’unica vittima tra le forze dell’ordine, mentre Mauro Torti, comandante della squadra cinofili di Nuoro, e il carabiniere Carmelo Mureddu rimangono feriti. Il maresciallo Serra, abbandonata la sua postazione, nota la canna di un fucile che da un cespuglio gli è puntata contro. Riesce a spostarla e ad esplodere dei colpi verso il cespuglio. Anche l’agente Daniele ladu esplode dei colpi verso il cespuglio. Rimarranno uccisi nello scontro i due latitanti Giovanni Corraine e Salvatore Fais.  Il maresciallo Serra rimarrà ferito non gravemente mentre l’ultimo bandito rimasto vivo ferisce l’agente Daniele ladu ad una gamba. Subito circondato, e ignorando i richiami degli agenti, anche quest'ultimo verrà ucciso. Si tratta di Niccolò Floris di Orgosolo, anch’egli pregiudicato e latitante. I cadaveri dei banditi verranno trasportati su camion scortati dalla polizia a sirene spiegate, il che causerà accese polemiche, perché molti interpreteranno il fatto come un’ostentazione dei cadaveri alla stregua di trofei di caccia, dato che il trasporto per le vie del paese si usa nella caccia al cinghiale, e l’evento ispirerà la canzone Osposidda del cantautore Piero Marras, nella quale si canta «Sonende bos passizan finas'in s’istradone: omines assimizan a peddes de sirbone», ossia «al suono di clacson vi esibiscono per la strada: assimilano uomini a pelli di cinghiale».
Il maresciallo Serra rimarrà ferito non gravemente mentre l’ultimo bandito rimasto vivo ferisce l’agente Daniele ladu ad una gamba. Subito circondato, e ignorando i richiami degli agenti, anche quest'ultimo verrà ucciso. Si tratta di Niccolò Floris di Orgosolo, anch’egli pregiudicato e latitante. I cadaveri dei banditi verranno trasportati su camion scortati dalla polizia a sirene spiegate, il che causerà accese polemiche, perché molti interpreteranno il fatto come un’ostentazione dei cadaveri alla stregua di trofei di caccia, dato che il trasporto per le vie del paese si usa nella caccia al cinghiale, e l’evento ispirerà la canzone Osposidda del cantautore Piero Marras, nella quale si canta «Sonende bos passizan finas'in s’istradone: omines assimizan a peddes de sirbone», ossia «al suono di clacson vi esibiscono per la strada: assimilano uomini a pelli di cinghiale».
I principali banditi ottocenteschi nati a Orgosolo
Orgosolo è famosa per il banditismo, che vi si sviluppa e che rappresenta la principale caratteristica del paese. A Orgosolo nasce, infatti, il bandito ottocentesco Giuseppe loddo, detto Lovicu, e la giovane latitante ottocentesca Paska Devaddis.
A Orgosolo nasce, nella seconda metà dell’Ottocento, Giuseppe loddo detto Lovicu un bandito sanguinario al quale si devono numerosi efferati delitti ed altri reati. Giuseppe loddo si unisce alla banda dei fratelli Giacomo ed elias Serra Sanna, di Nuoro, che spadroneggia nella zona che va da Orgosolo fino a Nuoro, con i quali agisce fino al 10 luglio 1899, quando a Morgogliai, un’impervia località fra Orgosolo e Oliena, vengono impegnati in un conflitto a fuoco con oltre Duecento fra carabinieri e fanti. Restano sul campo i due fratelli Serra Sanna, Giuseppe Pau, di Oliena, e Tommaso Virdis, di Oniferi, mentre si salva il quinto componente del gruppo, Giuseppe loddo, sul cui capo è posta una taglia di 10mila lire. Morirà due anni dopo, anche lui in un conflitto a fuoco con i carabinieri e con le armi in pugno. |
I principali banditi novecenteschi nati a Orgosolo
Nel secondo dopoguerra, ad Orgosolo nascono i due banditi che, tra gli anni trenta e cinquanta del Novecento, insanguinano la Barbagia, ossia Giovanni Battista Liandru e Pasquale Tanteddu, o Tandeddu.
La vita di Graziano Mesina la primula rossa del Supramonte
Qualche anno dopo Giovanni Battista Liandru e Pasquale Tandeddu, ad Orgosolo nasce il bandito Graziano Mesina, denominato la primula rossa del Supramonte, che è stato uno dei personaggi più importanti nella vita della comunità di Orgosolo.
Visita del centro di Orgosolo
 Provenendo da Nuoro con la SP58, da dove si immette da destra la strada provinciale proveniente da Oliena, percorsi nove chilometri e quattrocento metri, troviamo alla destra della strada il cartello segnaletico che indica l’ingresso in Orgosolo. Si tratta di un cartello segnaletico tempestato dai colpi di fucile degli Orgolesi. Da qui, la prosecuzione della SP58 assume il nome di via locoe e ci porta all’interno dell’abitato di Orgosolo. L’abitato, interessato da forte espansione edilizia, si estende in una conca circondata da vasti boschi, caratterizzato da stretti vicoli ai cui lati sorgono le case addossate l’una all’altra e decorate da bei murales. I negozi e le loro insegne sono le stesse di quaranta anni fa, per questo motivo Orgosolo ha un ambiente unico al mondo, che difficilmente si può trovare in altre località della Sardegna.
Provenendo da Nuoro con la SP58, da dove si immette da destra la strada provinciale proveniente da Oliena, percorsi nove chilometri e quattrocento metri, troviamo alla destra della strada il cartello segnaletico che indica l’ingresso in Orgosolo. Si tratta di un cartello segnaletico tempestato dai colpi di fucile degli Orgolesi. Da qui, la prosecuzione della SP58 assume il nome di via locoe e ci porta all’interno dell’abitato di Orgosolo. L’abitato, interessato da forte espansione edilizia, si estende in una conca circondata da vasti boschi, caratterizzato da stretti vicoli ai cui lati sorgono le case addossate l’una all’altra e decorate da bei murales. I negozi e le loro insegne sono le stesse di quaranta anni fa, per questo motivo Orgosolo ha un ambiente unico al mondo, che difficilmente si può trovare in altre località della Sardegna.
Il nuovo Municipio di Orgosolo
Da via locoe, a ottocento metri dal cartello segnaletico che ci ha portati all’interno di Orgosolo, prendiamo a sinistra via Guscana, poi a sinistra in corrispondenza di via del Lavoro, che diventa via della Pace, dalla quale svoltiamo a sinistra ed arriviamo in via Sas Codinas, che prendiamo verso sinistra e che ci porta all’edificio che ospita la sede del Municipio di Orgosolo, che ha sostituito il precedente antico Municipio che si trova nel corso della Repubblica e che vedremo più avanti.
L’ex chiesa parocchiale di San Paolo Apostolo
Passato il Municipio, proseguendo lungo la via Sas Coddinas, nella parte bassa del paese in centottanta metri arriviamo a vedere alla sinistra della strada, al civico numero 60 della via Sas Codinas, il cancello di ingresso che porta al cortile nel quale si affaccia la grande chiesa di San Pietro Apostolo, chiamata Santu Perdu e dedicata al Santo patrono, che è la sede religiosa più antica di Orgosolo e fino al 1975 è stata la chiesa parrocchiale. La chiesa è stata realizzata in stile romanico in data incerta, probabilmente edificata nel quattordicesimo secolo ma ampiamente rimaneggiata nel settecento e successivamentecostruita nel XIV secolo e rimaneggiata nel corso del 1700. Il restauro che ha interessato l’edificio dal 1854 al 1859 è stato opera dell’architetto Giacomo Galfrè, nonno materno di Salvatore Satta, autore del romanzo Il giorno del giudizio. I lavori furono ultimati nel giugno del 1860 e la chiesa fu benedetta il 29 dello stesso mese, giornata nella quale da allora in poi a Orgosolo si festeggia San Pietro patrono del paese. L’elegante prospetto esterno scandito da quattro snelle lesene, si conclude con un timpano triangolare con raffinata cornice aggettante. Al centro si trova il portale d’ingresso sormontato da una lunetta vetrata di forma semicircolare. Nella parte posteriore della chiesa, sulla parte destra, si eleva l’antica torre campanaria a canna quadrata, aperta nella parte superiore da quattro monofore a tutto sesto e concluso da cupoletta piramidale. Sul campanile quattrocentesco si trovano due curiosi orologi, uno che guarda a ovest, con un quadrante a cifre romane, che segna sempre le 12 e 03, ed un altro che guarda a sud, con un quadrante a numeri arabi, fermo sulle 7 e 27. Su un muro si può vedere la scritta Orgosolo caput mundi, firmata Tony e Simone, due ragazzi.
L’edificio è caratterizzata all’interno da un’ampia pianta longitudinale nella quale, al termine navata, in corrispondenza dell’abside posteriore, è presente l’altare, sul quale è presente una bella statua del Sacro Cuore di Gesù. All’interno della chiesa è anche presente la statua di San Pietro, che verrà portata in processione insieme a quella di San Paolo nella loro Festa patronale.
In questa chiesa venne battezzata e ricevette la cresima e la prima comunione la Beata Antonia Mesina, della quale parleremo più avanti. Attualmente la parrocchia, intitolata sempre a San Pietro Apostolo, viene officiata nella nuova chiesa del Santissimo Redentore, situata al centro del paese.
 Come ogni anno, il 29 giugno, il paese celebra nella Festa patronale dei Santi Pietro e Paolo, i riti in onore del primo papa della chiesa cattolica, ucciso assieme a San Paolo, attorno al 67 dopo Cristo, a causa delle persecuzioni ordinate da Nerone. Un destino comune, segnato dal martirio per i due fondatori del cristianesimo, ricordati, non a caso, entrambi nella stessa giornata attraverso le funzioni eucaristiche, alle quali segue la solenne processione. Il programma religioso comincia il 20 giugno con la novena, poi il 29 giugno si parte con la celebrazione della messa, al seguito della quale ci sarà la processione religiosa per vie del paese. Le statue di San Pietro e San Paolo vengono portate in spalla tra le vie del centro abitato, accompagnate dalla popolazione dei fedeli e devoti, che partecipano sempre numerosi. Sono i cavalieri ad aprire il corteo, incolonnati a gruppi di due. Seguono lo stendardo, sa Pandela, ritraente le effigi del santo. Nel tardo pomeriggio, quegli stessi cavalieri danno prova delle loro abilità in s'Ardia a cavallo, alla quale partecipano gran parte dei cavalieri di Orgosolo. Le esibizioni acrobatiche di abili fantini, sas Pariglias, vengono eseguite su cavalli spinti al galoppo, ad alta velocità, lungo le strade della periferia del paese.
Come ogni anno, il 29 giugno, il paese celebra nella Festa patronale dei Santi Pietro e Paolo, i riti in onore del primo papa della chiesa cattolica, ucciso assieme a San Paolo, attorno al 67 dopo Cristo, a causa delle persecuzioni ordinate da Nerone. Un destino comune, segnato dal martirio per i due fondatori del cristianesimo, ricordati, non a caso, entrambi nella stessa giornata attraverso le funzioni eucaristiche, alle quali segue la solenne processione. Il programma religioso comincia il 20 giugno con la novena, poi il 29 giugno si parte con la celebrazione della messa, al seguito della quale ci sarà la processione religiosa per vie del paese. Le statue di San Pietro e San Paolo vengono portate in spalla tra le vie del centro abitato, accompagnate dalla popolazione dei fedeli e devoti, che partecipano sempre numerosi. Sono i cavalieri ad aprire il corteo, incolonnati a gruppi di due. Seguono lo stendardo, sa Pandela, ritraente le effigi del santo. Nel tardo pomeriggio, quegli stessi cavalieri danno prova delle loro abilità in s'Ardia a cavallo, alla quale partecipano gran parte dei cavalieri di Orgosolo. Le esibizioni acrobatiche di abili fantini, sas Pariglias, vengono eseguite su cavalli spinti al galoppo, ad alta velocità, lungo le strade della periferia del paese.
Il Cimitero Comunale di Orgosolo
Poco dopo il cancello di ingresso della chiesa di San Pietro Apostolo, vediamo alla sinistra della via Sas Codinas la facciata con l’ingresso del Cimitero Comunale di Orgosolo. Subito più avanti, la via Sas Codinas dopo una cinquantina di metri termina sboccando sulla via della Rinascita, e subito alla sua destra parte la via del Cimitero, strada che costeggia appunto sulla destra il muro di cinta del Cimitero, che scende a gradoni ripidi lungo un costone a strapiombo sulla vallata di Galanoli.
All’interno del Cimitero Comunale si trovano le tombe dei numerosi morti di faida e di altri personaggi significativi nella vita del paese. Tra questi, il bandito Pasquale Tandeddu forse il più noto latitante sardo, descritto come un bandito molto popolare a Orgosolo, perché è opinione generale che non avrebbe mai commesso delitti contro i poveri, e non abbia mai voluto diventare servo dei padroni. Vi trova la sua dimora anche Peppino Marotto sindacalista, poeta e cantante, tra i fondatori del gruppo dei Tenores di Orgosolo, un uomo che viveva di libertà, giustizia e profondo senso etico, e che è stato assassinato nel 2007.
La Palestra Comunale
Proseguendo lungo via del Cimitero, dopo poco circa centotrenta metri continuiamo sulla sua prosecuzione, che è la via Santa Lucia, e subito all’inizio di questa strada prendiamo la sua traversa verso la sinistra. La strada costeggia il parcheggio per il Cimitero Comunale, che si sviluppa alla sua sinistra, ed in una sessantina di metri porta di fronte all’ingresso della Palestra Comunale di Orgosolo, intestata a Mario Monni che è stato sindaco di Orgosolo al tempo del rapimento di Farouk Kassam. All’interno della palestra, dotata di fondo in materiali sintetici, e di tribune in grado di ospitare 240 spettatori, si svolgono esibizioni di diverse discipline sportive, soprattutto la pallavolo.
Lo Stadio Comunale
Proseguendo lungo via Santa Lucia, in circa centotrenta metri arriviamo a vedere sulla sinistra l’ingresso dello Stadio Comunale di Orgosolo. All’interno di questo complesso sportivo si trova un Campo da calcio, con fondo in terra battuta, dotato di tribune in grado di ospitare una trentina di spettatori. Alla destra del Campo da calcio, è presente il più piccolo Campo da calcetto, ossia da calcio a sette e da calcio a cinque, anch’esso con fondo in terra battuta, che non è dotato di tribune per gli spettatori.
La piccola chiesa della Santa Croce
 Ritorniamo alla chiesa di San Pietro Apostolo. Seguendo la via Sas Codinas, quando questa strada sbocca sulla via della Rinascita, svoltiamo a destra e prendiamo la via della Rinascita, la seguiamo per una cinquantina di metri fino a vedere, alla sinistra della strada, la facciata della piccola chiesa della Santa Croce, chiamata anche in lingua la chiesa di Santa Gruhe. Si tratta di un piccolo oratorio risalente al sedicesimo secolo, realizzato in stile rustico. All’interno, sotto la cupola, la chiesa ospita un semplice altare sul quale si aprono delle piccole finestre. All’interno della chiesa, alle spalle dell’altare, dentro una nicchia, è presente un crocifisso ligneo del Seicento.
Ritorniamo alla chiesa di San Pietro Apostolo. Seguendo la via Sas Codinas, quando questa strada sbocca sulla via della Rinascita, svoltiamo a destra e prendiamo la via della Rinascita, la seguiamo per una cinquantina di metri fino a vedere, alla sinistra della strada, la facciata della piccola chiesa della Santa Croce, chiamata anche in lingua la chiesa di Santa Gruhe. Si tratta di un piccolo oratorio risalente al sedicesimo secolo, realizzato in stile rustico. All’interno, sotto la cupola, la chiesa ospita un semplice altare sul quale si aprono delle piccole finestre. All’interno della chiesa, alle spalle dell’altare, dentro una nicchia, è presente un crocifisso ligneo del Seicento.
La grande piazza don Graziano Muntoni
Passata la chiesa di Santa Croce, alla sua destra si apre la grande piazza don Graziano Muntoni, intitolata al sacerdote don Graziano Muntoni, originario di Fonni, ucciso la mattina della vigilia di Natale del 1998, mentre usciva di casa. Professore e politico locale, una vita di insegnamento, aveva avuto la vocazione sacerdotale tardiva, ed era sacerdote da solo otto anni, quando, a cinquantasette anni, semplice vice parroco, è stato colpito a morte dalla scarica dei pallettoni di un unico colpo di fucile, mentre si recava per andare in parrocchia a dire la messa. Al centro della piazza è stato collocato un busto in bronzo che rappresenta appunto don Graziano Muntoni.
Voleva essere santo, è divenuto un martire, ha detto di lui il vescovo di Nuoro monsignor Pietro Meloni. In questi 25 anni il suo carnefice non è mai stato trovato infliggendo un dolore forse più profondo della sua stessa fine, a don Graziano sono state dedicate varie iniziative, Orgosolo gli ha dedicato la piazza, gli è stata dedicata la casa di accoglienza di detenuti di Sassari, ma anche spazi frequentati dai giovani come il guardino della pace dell’Istituto pedagogico di Nuoro, a Fonni c’è un centro di aggregazione che porta il suo nome. Sua sorella Caterina non ha mai smesso di chiedere giustizia.
La chiesa di Sant’Antonio Abate
Dalla via della Rinascita, passata la piazza don Graziano Muntoni, prendiamo a sinistra la via 25 Aprile e, dopo una cinquantina di metri, troviamo sulla destra della strada una scalinata che, in un’altra cinquantina di metri, ci porta in alto, nella piazza Sant’Antonio Abate. In questa piazza si trova la chiesa di Sant’Antonio Abate chiamata Sant’Antoni de Su Ohu e dedicata al Santo che pare che, con un stratagemma, sia riuscito a portare via il fuoco dall’inferno, portandolo sulla terra. È intorno a questa chiesa, databile tra il quattordicesimo e quindicesimo secolo, che si è sviluppato l’originario borgo di Orgosolo.
 La notte tra il 16 ed il 17 gennaio presso questa chiesa si svolge la Festa di Sant’Antonio Abate, per la quale a fianco nella chiesa, a metà pomeriggio del giorno 16 viene celebrata la messa e subito dopo viene acceso il grosso falò che campeggia al centro della piazza, per il quale la legna, generalmente di quercia, viene raccolta dai ragazzini che nelle settimane percedenti alla festa, passano per le abitazioni del paese chiedendo Su truncheddu pro Sant’Antoni.
La notte tra il 16 ed il 17 gennaio presso questa chiesa si svolge la Festa di Sant’Antonio Abate, per la quale a fianco nella chiesa, a metà pomeriggio del giorno 16 viene celebrata la messa e subito dopo viene acceso il grosso falò che campeggia al centro della piazza, per il quale la legna, generalmente di quercia, viene raccolta dai ragazzini che nelle settimane percedenti alla festa, passano per le abitazioni del paese chiedendo Su truncheddu pro Sant’Antoni.  Dopo l’accensione del falò i fedeli compiono tre giri intorno al falò. La festa è seguita da una processione con il simulacro del Santo, seguita dalle donne che recitano le preghiere in lingua sarda, e poi, subito dopo, vino e dolci per tutti, mentre la serata prosegue spesso anche con balli e con la cena per tutti. Per questa occasione, a Orgosolo viene preparato il dolce tipico di questa festa, chiamato Su Pistiddi, che è realizzato con pasta sfoglia fatta di semola di grano duro, ed il cui ripieno che è un composto di una parte di semola grossa, miele, poco zucchero e bucce di arance finissime. Nella sua realizzazione ogni artigiana si sbizzarrisce nei vari ricami che rendono questo dolce unico, ed il cui suo sapore è un’esplosione di gusto davvero speciale.
Dopo l’accensione del falò i fedeli compiono tre giri intorno al falò. La festa è seguita da una processione con il simulacro del Santo, seguita dalle donne che recitano le preghiere in lingua sarda, e poi, subito dopo, vino e dolci per tutti, mentre la serata prosegue spesso anche con balli e con la cena per tutti. Per questa occasione, a Orgosolo viene preparato il dolce tipico di questa festa, chiamato Su Pistiddi, che è realizzato con pasta sfoglia fatta di semola di grano duro, ed il cui ripieno che è un composto di una parte di semola grossa, miele, poco zucchero e bucce di arance finissime. Nella sua realizzazione ogni artigiana si sbizzarrisce nei vari ricami che rendono questo dolce unico, ed il cui suo sapore è un’esplosione di gusto davvero speciale.
La chiesa di Sant’Antonio da Padova
Dopo la visita alla chiesa di Sant’Antonio Abate, torniamo alla chiesa di Santa Croce. Da qui, presa alla sinistra della chiesa della Santa Croce, in direzione sud,ovest, la via Brigata Sassari, la seguiamo per una trentina di metri, poi svoltiamo a sinistra nella via Sant’Antonio da Padova, la seguiamo per un’ottantina di metri fino a prendere a destra la via Rosselli, che in una trentina di metri ci porta a vedere alla sinistra della strada la facciata della chiesa di Sant’Antonio da Padova, chiamata Sant’Antoni ’e Padua. Si tratta di una chiesa che è stata edificata nel sedicesimo secolo, probabilmente nel 1620.
La chiesa, però, attualmente non è aperta al culto. Sulla facciata, che avrebbe bisogno di un restauro, presenta un portone centrale sovrastato da un punto luce di forma esagonale. Sul fianco sinistro, nel retro, è presente un campanile a vela.
Il Santuario della Beata Vergine Assunta
Guardando la chiesa della Santa Croce, prendiamo a sinistra la via della Rinascita che ci porta verso la periferia orientale del paese, e, dopo duecentotrenta metri, prendiamo a sinistra la via Santa Caterina. In una cinquantina di metri arriviamo a vedere, alla sinistra al civico numeo 21, la facciata del Santuario della Beata Vergine Assunta, che viene chiamata anche Chesia de Nostra Sennora. Il Santuario della Beata Vergine Assunta è stato edificato nel 1634 nel centro storico di Orgosolo, in uno spiazzo circondato da alberi e vegetazione cui si accede tramite un cancello. Da allora l’edificio ha subito vari interventi di modifica e restauro, sia all’esterno che all’interno. La facciata, intonacata di bianco, è a salienti, a tre navate, culminante, al centro, con un piccolo campanile a vela con croce e, ai lati, con due edicole. Il portone d’ingresso è fiancheggiato da semicolonne e sormontato da un timpano in granito, mentre due grandi nicchie, oggi vuote, si aprono lateralmente. Un oculo e la scritta spes nostra salve completano il prospetto, che risulta, nell’insieme, di grande semplicità.
la chiesa della Beata Vergine Assunta, eretta nel 1634, al cui interno si può ammirare la statua della Madonna conservata
L’interno, a sua volta intonacato di bianco, è scandito da archi a tutto sesto e a sesto acuto. In una piccola cappella, dentro una teca in legno dorato e cristallo ornata da numerosi ex voto, è custodito il simulacro della Madonna dormiente conservata in un’urna di legno dorato ornata da pregevoli ex voto. All’esterno vi è un’altra statua della Madonna.
La chiesa viene definita un Santuario, ossia un luogo ritenuto sacro dalla tradizione religiosa, per la devozione dei fedeli alla statua della Vergine Assunta dormiente conservata al suo interno in un’urna di legno dorato ornata da pregevoli ex voto. La Festa della Beata Vergine Assunta, la più sentita dalla popolazione di Orgosolo, dura dal 13 al 18 di agosto in coincidenza con le celebrazioni del ferragosto orgosolese, e da questa chiesa parte nel pomeriggio del 15 agosto la solenne processione in costume, che abbiamo già descritto. Nel corso dell’evento i cavalieri che hanno seguito la processione, si lanciano in corse a cavallo, un evento davvero imperdibile per chi ama la tradizione.
Raggiungiamo la piazza dei Caduti in guerra
Dopo la visita del Santuario della Beata Vergine Assunta, proseguamo verso sud lungo la via Santa Caterina dalla quale, dopo una sessantina di metri, prendiamo verso sinistra la via Camillo Bellieni che, dopo poco più di duecento metri, sbocca sul corso della Repubblica. Svoltiamo a sinistra e prendiamo il corso della Repubblica che si dirige verso est, lo seguiamo per appena un centinaio di metri, e vediamo il corrispondenza del civico numero 338 aprirsi alla sinistra della strada l’ampia piazza dei Caduti in guerra, mentre alla destra si vede l’edificio che ospita la Scuola Elementare Attilio Deffenu. Sul retro di questo edificio, passato l’Auditorium Comunale al quale l’accesso è possibile dal cortile adiacente l’edificio della Scuola, si trova l’edificio che ospita la Biblioteca Comunale, nella quale è presente il percorso didattico intitolato dalla roccia al gipeto, realizzato con diorami e preparazioni tassidermiche di qualità. Consiste nella ricostruzione tridimensionale del Supramonte, dalla genesi della foresta alla catena alimentare, rappresentata dalle diverse specie animali, collocate in un rapporto di predatore con la preda, fino ad arrivare al gipeto, l’avvoltoio barbuto, del quale vengono illustrati le caratteristiche biologiche e il progetto della sua reintroduzione.
La piazza dei Caduti in guerra è stata realizzata in periodo fascista, dato che l’elenco dei Viali e Parchi della Rimembranza, istituito nel 1923 su iniziativa del sottosegretario alla Pubblica Istruzione Dario lupi, riferisce l’inaugurazione ad Orgosolo di un Parco delle rimembranze. Attualmente è costituita da una parte pavimentata e da una parte sistemata a giardino pubblico con aiuole e vialetti, ed oggi la piazza antistante il caseggiato scolastico ospita un monumento commemorativo ai caduti in guerra, realizzato nel 2011. Fino ad allora ad Orgosolo c'erano solo delle lapidi con i nomi dei 106 caduti, niente di più, ma nel 2011 l’amministrazione Comunale ha commissionato una scultura che ricordasse i poveri ragazzi partiti dalla Sardegna e morti per la patria. Il monumento, bellissimo, è stato situato nella piazza dei Caduti, che da allora ha anche una motivazione per la scelta di tale nome. Il monumento è stato realizzato dall’artista Carmine Pira, di Oristano su una pietra di basalto alta circa quattro metri. Nella parte alta del monumento campeggia una grande bandiera tricolore e una più piccola, della Sardegna con i quattro mori. Il tutto è piazzato su una base di cemento, nella parte bassa della piazza.
Nella periferia meridionale dell’abitato si trova la chiesa di San Nicola da Mira
Riprendiamo il corso della Repubblica questa volta verso ovest. percorsa appena una cinquantina di metri, prendiamo a sinistra la via Giovanni Maria Angioy e la seguiamo fino ad arrivare alla periferia meridionale del paese. Percorsi circa trecento metri, dopo l’incrocio a destra con la via Galileo Galilei e, subito dopo, a sinistra con la via Gabriele D’Annunzio, vediamo su un rialzo alla sinistra della strada la chiesa di San Nicola da Mira, chiamata dai locali Santu Nihola, una chiesa realizzata nel corso del quindicesimo secolo.
In corso della Repubblica vediamo la sede dell’antico Municipio
Riprendiamo il corso della Repubblica verso ovest e, dopo una settantina di metri, arriviamo dove è arrivata da destra la via Camillo Bellieni, proseguiamo per un altro centinaio di metri e vediamo, alla sinistra della strada in corrispondenza del civico numero 290, l’edificio che ha ospitato la sede dell’antico Municipio di Orgosolo, fino alla creazione dell’attuale Municipio. Si tratta di una struttura storica che nel periodo della rivolta di Pratobello o quando si discuteva del Parco nazionale del Gennargentu, poi mai realizzato, ha ospitato consigli comunali infuocati. Ma è anche quell’edificio sul quale campeggia il murale di Francesco del Casino, su cui sono impresse le parole che Emilio Lussu, nel 1969 durante la rivoluzione contro il poligono militare, inviò agli Orgolesi tramite un telegramma, ossia Se fossi stato in condizioni di salute differenti sarai stato in mezzo a voi, scriveva il fondatore del Partito Sardo d’Azione.
Recentemente l’ex palazzo Comunale di Orgosolo, chiuso da decenni, è tornato ad accogliere la cittadinanza dopo una intensa ristrutturazione che lo ha proposto in una nuova veste, ovvero come luogo di condivisione di attività ed esperienze. L’edificio nel cuore di Corso Repubblica nel centro storico del paese, è distribuito su quattro piani, due piani seminterrati adibiti ad ufficio turistico a sala d’attesa e un bookshop, nei restanti piani sono stati allestiti una sala multifunzionale, un laboratorio, una sala formazione, uno spazio co-working e una sala convegni, con alcuni locali che rimarranno a disposizione delle associazioni locali.
La chiesa parrocchiale del Santissimo Salvatore
Percorsa appena un’altra quarantina di metri, arriviamo al civico numero 175, alla destra della strada, dove si affaccia la chiesa del Santissimo Salvatore chiamata localmente Sa lhesia Nova, di costruzione assai recente. È stata edificata nella seconda metà del ventesimo secolo, ed è dal 1971 la chiesa parrocchiale di Orgosolo, anno in cui in essa è stata trasferita la ex chiesa parrocchiale di San Pietro Apostolo.
Il 29 giugno viene festeggiato il patrono del paese, e la Festa di Pietro Apostolo è un’occasione per fare lo sfoggio dei bellissimi costumi tradizionali. La festa è già stata descritta parlando della chiesa di San Pietro Apostolo
Nella Cripta della chiesa parrocchiale sono conservate le spoglie della Beata Antonia Mesina
Fiancheggiando con la stretta via Lamarmora il lato destro della chiesa parrocchiale del Santissimo Salvatore, dopo quindici metri troviamo alla sinistra l’ingresso della Cripta, nella quale sono conservate le spoglie mortali della Beata Antonia Mesina. Subito di fronte all’ingresso, alla destra della via Lamarmora, si trova qualle che era stata la casa natale della beata Antonia Mesina.
Da qualche anno alla beata Antonia Mesina è stata dedicata la cripta della chiesa parrocchiale, che si trova dinnanzi alla sua casa natale e che ospita la sua statua vestita con il costume locale. Nelle pareti della cripta si possono poi ammirare gli affreschi che ripercorrono la sua vita. Antonia Mesina è una figura importantissima per la comunità orgolese e pertanto ogni anno nel giorno del suo martirio si svolge la festa in suo onore nella campagne fuori Orgosolo. Alla beata è stato anche dedicato il gruppo di ballo e il tenore che portano il suo nome.
Sa Dommo ’e Sos Corraine
Passata la chiesa parrocchiale del Santissimo Salvatore, dopo circa duecentocinquanta metri, subito dopo via Podda e prima della via di Vittorio, sulla destra della strada all’altezza del civico numero 103, possiamo visitare Sa Dommo ’e Sos Corraine. Si tratta di un piccolo Museo Etnografico che si trova in una tipica casa orgolese, proprio a ridosso del murale sulla donna relativo all’8 marzo 1908, quando in una fabbrica di New York 129 donne venivano rinchiuse dentro dal padrone e morivano in un incendio, che vedremo meglio nella prossima pagina. La casa è composta di quindici stanze distribuite su tre piani, e contiene gli ambienti suddivisi ed arredati secondo le esigenze e le usanze dell’epoca. Vi si trovano arredi come credenze, tavoli, camini, camere da letto ed un bellissimo telaio, e vi si trovano inoltre stoviglie, piatti, corredi, ed i dolci tipici del luogo essiccati per venire mostrati nella loro bellezza.
Oltre a tutto questo sono moltissimi i documenti dei primi del novecento conservati dalla simpaticissima padrona di casa ed appartenuti alla sua famiglia. Alla fine della visita la signora Maria Corraine e suo marito offrono ai visitatori dolci tipici e liquori preparati da loro.
La bella fontana chiamata Untana de Cunzimu
Continuando ancora poco più di cento metri su corso della Repubblica, troviamo, sulla sinistra della strada ad angolo con una traversa che porta nella parallela via papa Giovanni XXIII, subito dopo il civico numero 146 e di fronte al civico 93, una bella fontana chiamata Untana de Cunzimu, ossia fontana della località Cunzimu. Sulle pareti alla sinistra della fontana si trovano dei bei murales, come si trova uno dei più belli sulla retrostante via Papa Giovanni XXIII.
La fontana è stata recentemente restaurata ed assume ora nuove colorazioni.
A nord ovest dell’abitato vediamo gli impianti sportivi delle Scuole Medie
Proseguiamo lungo il corso della Repubblica e, dopo centotrenta metri, arriviamo a una deviazione, dove il corso prosegue in salita verso sinistra, mentre noi prendiamo verso destra la prosecuzione della strada che assume il nome di via Nuoro, e che ci porterà nella periferia nord occidentale del paese. Presa la via Nuoro, la seguiamo per quasi duecentocinquanta metri, poi prendiamo a sinistra la via Giuseppe Ungaretti e, dopo un centinaio di metri, vediamo alla destra della strada l’edificio che ospita le Scuole Medie intestate a Sebastiano Satta.
All’interno di questo complesso scolastico è presente una Palestra, priva di tribune per gli spettatori, nella quale è possibile praticare diversi tipi di attività ginnico motorie; mentre dall’esterno si può accedere a un Campo sportivo polivalente, anch’esso senza tribune, nel quale praticare come disciplin principalmente la pallacanestro.
Gli oltre 150 murales che hanno reso famoso Orgosolo
Continueremo, ora, la visita di Orgosolo percorrendo le sue strade, dove potremo vedere i murales che decorano i massi all’ingresso del paese e le pareti delle abitazioni del centro storico. Sono oltre 150 i famosi murales di Orgosolo, che decorano le abitazioni del centro del paese. Propongo quelli che ho fotografato qualche anno fa, cercando di ordinarli e rileggerli nel loro significato, quasi una sorta di giornale murale nel quale vengono raccontate le ordinarie storie di vita, di sofferenze, di oppressione e di lotta del popolo sardo e di tutte le popolazioni oppresse del mondo. I murales cambiano continuamente nel tempo. I più vecchi si rovinano e muoiono, mentre altri nuovi nascono accanto a loro o anche al loro posto, quasi un giornale sempre aggiornato.
I primi murales
 Un primo murale è stato realizzato nel 1968 dal gruppo teatrale milanese Dionisio. Nel 1975, l’insegnante di educazione artistica Francesco Del Casino, il pittore senese che aveva iniziato la sua carriera pittorica nel 1962 con una produzione legata allo stile di Renato Guttuso, seguita da una fase influenza dall’arte di Pablo Picasso, e che nel 1964 si era trasferito in Sardegna, ad Orgosolo, dove aveva iniziato la sua opera come muralista. Egli ha ripreso, con gli studenti della Scuola media, quell’esperienza, coadiuvato dai pittori orgosolesi Pasquale Buesca e Vincenzo Floris, ed a loro si deve la creazione dei murales presenti sulla facciata delle abitazioni del centro cittadino. Tali lavori rappresentano la vita politica e sociale propria di quegli anni, e la passione politica e sociale continua a vivere nel paese e nelle centinaia di murales che sono stati dipinti sulle facciate delle case e sulle rocce intorno al paese. Inizialmente esprimevano le idee politiche di quel periodo e le problematiche del recente passato della Sardegna, si sono poi adeguati alle attuali tematiche di contestazione della globalizzazione dell’economia. Raccontiamo qui la lezione che ci viene dai murales, da noi fotografati qualche anno fa, riunendoli per argomento quasi a costituire un libro di storia scritto sui muri del paese.
Un primo murale è stato realizzato nel 1968 dal gruppo teatrale milanese Dionisio. Nel 1975, l’insegnante di educazione artistica Francesco Del Casino, il pittore senese che aveva iniziato la sua carriera pittorica nel 1962 con una produzione legata allo stile di Renato Guttuso, seguita da una fase influenza dall’arte di Pablo Picasso, e che nel 1964 si era trasferito in Sardegna, ad Orgosolo, dove aveva iniziato la sua opera come muralista. Egli ha ripreso, con gli studenti della Scuola media, quell’esperienza, coadiuvato dai pittori orgosolesi Pasquale Buesca e Vincenzo Floris, ed a loro si deve la creazione dei murales presenti sulla facciata delle abitazioni del centro cittadino. Tali lavori rappresentano la vita politica e sociale propria di quegli anni, e la passione politica e sociale continua a vivere nel paese e nelle centinaia di murales che sono stati dipinti sulle facciate delle case e sulle rocce intorno al paese. Inizialmente esprimevano le idee politiche di quel periodo e le problematiche del recente passato della Sardegna, si sono poi adeguati alle attuali tematiche di contestazione della globalizzazione dell’economia. Raccontiamo qui la lezione che ci viene dai murales, da noi fotografati qualche anno fa, riunendoli per argomento quasi a costituire un libro di storia scritto sui muri del paese.
Il banditismo barbaricino
Non possono mancare murales che rievocano il fenomeno del banditismo barbaricino come quello che rappresenta la locandina del film Banditi a Orgosolo di De Seta, girato nel 1960 con la partecipazione della popolazione locale. Un film del quale il regista narra con stile freddo e asciutto la dura vita dei pastori e la diffidenza tradizionale nei confronti dello Stato. La cultura ufficiale non comprendeva il fenomeno del banditismo, nato come difesa da occupazioni ed invasioni, dallo sfruttamento che determinava sofferenze e povertà, basato quindisu una forte compartecipazione ed omertà. Riteneva addirittura il sardo naturalmente predisposto all’attività criminale. La conseguenza era la caccia al criminale, che quando non veniva ucciso trascorreva il resto dei suoi anni prigione. Uno dei più bei murales, intitolato Caccia Grossa, racconta la strage di Murguliai, del 1899, quando viene sgominata la banda dei fratelli Serra Sanna che era riuscita a imporre uno spietato dominio sul territorio tra Nuoro e Orgosolo.
I murales dedicati ad Antonio Gramsci
Ad Antonio Gramsci sono dedicati numerosi murales che ripercorrono tutte le principali tappe della sua vita. Istruitevi perché avremo bisogno di tutta la vostra intelligenza - Le parole di Gramsci come speranza di una vita diversa.
Il principali personaggi della storia italiana
Le strade del paese vengono intestate ai principali personaggi della storia italiana. Garibaldi unisce l’Italia, ma la Sardegna fornisce solo carne da macello per le diverse guerre. Il generale Cadorna viene, qui, visto più come macellaio che come eroe; tra l’altro, ci scrive Giancarlo Romiti di avere Chiesto al sindaco di Orgosolo di valutare la possibilità di cambiare nome alla via Cadorna, ovviamente mantenendo quello splendido murale, preziosa testimonianze di chi fu il principale responsabile di quell’immane ecatombe. Poi arriva il Fascismo e l’impegno dei contadini, per evitare confische e rastrellamenti, diventava quello di salvare il bestiame. Alla guerra di resistenza anche Orgosolo offre il suo contributo. Ma la resistenza non finisce con la liberazione perché, come scrisse Brecht, Il grembo da cui nacque è ancora fecondo.
Le stragi di stato
E arriviamo, infatti, alle stragi di stato quelle di piazza Fontana, Bologna, Ustica, piazza della loggia. Nei processi nessuno Sa niente, tanto che un murale ricorda il comandamento: Non dire falsa testimonianza. Viene addotto il segreto militare per coprire la strage di Stato da parte di una Giustizia di Stato. Ma come ammoniscono i murales, Non finisce qui. Rinasce la la protesta e giovani antifascisti vengono uccisi, prima Serantini, poi Varalli e Zibecchi.
Scandali nella vita politica nazionale
Non che nella vita politica nazionale le cose vadano meglio, tra lo sfruttamento del grande capitale e gli scandali che travolgono diversi personaggi pubblici, dal ministro De lorenzo al capo dello stato leone costretto a dimettersi. Un monito a Craxi, De Michelis e Amato: Questi erano questi erano i socialisti, con il ritratto di Turati, Rosselli, Pertini, Parri.
Disuguaglianze e sfruttamento nel mondo
Disuguaglianze e sfruttamento nel mondo, la falsa assistenza dei popoli ricchi al sud del mondo. L’arrivo dei missionari in Africa nelle parole dell’arcivescovo Tutu: Quando i primi missionari arrivarono in Africa, noi avevamo la terra e loro la Bibbia. Allora chiudemmo gli occhi e pregammo. Quando li riaprimmo noi avevamo in mano la bibbia e loro la terra. E degli uomini bianchi tra i pellirosse d’America: L’uomo bianco ha portato un pezzo di carta e ha detto di firmare. Quando abbiamo imparato l’inglese ci siamo accorti che con quel documento avevamo perduto la terra. Fino alla famosa frase di Toro Seduto sui falsi valori: Solo quando l’ultimo albero sarà stato abbattuto, l’ultimo fiume avvElenato, l’ultimo pesce pescato, vi accorgerete che non si può mangiare il denaro. Ai pericoli dell’energia atomica nella parole di Einstein: La potenza incontrollata dell’atomo ha cambiato ogni cosa tranne il nostro modo di pensare e così noi siamo trascinati verso una catastrofe senza pari. Il sogno di un futuro migliore, i valori della Rivoluzione Francese e la speranza di Pietro Gori di realizzarli. Solo colui che morì in croce poteva portare i capelli lunghi senza essere chiamato drogato!L’8 marzo 1908 muoiono 129 donne rinchiuse in fabbrica per un incendio a New York, il 18 luglio 1936 il dramma del paese chiamata Guernica, fino alla lotta contro l’ingiustizia del Che Guevara.
Contro tutte le guerre
Contro tutte le guerre perché non esistono guerre giuste. Il golpe in Cile, l’invasione del Vietnam e la vittoria dei partigiani cambogiani e vietnamiti. Poi i fatti di piazza Tien An Men, la ribellione del popolo curdo, il dramma della Guerra del Golfo, la guerra in Iraq. Operaio non produrre più armi, anche Charlot rifiuta la guerra. Mentre, con la globalizzazione nel mondo, si fa rosso di sangue il colore dei soldi.
La vita del popolo sardo
Naturale e genuina la vita del popolo sardo basata sulla pastorizia e su valori antichi. Anche se non è facile la vita del pastore. Quando non sono gli incendi a bruciare i pascoli è la siccità che li inaridisce, e l’acqua diventa un bene più prezioso persino del cibo.
Le lotte della popolazione sarda
I murales rievocano le lotte della popolazione sarda dalla richiesta di libertà per Luigi Podda, l’ex partigiano Corvo condannato al confino, ai fatti di Pratobello con la vittoriosa protesta contro l’installazione di un poligono di tiro in località Pratobello, con il telegramma inviato da Emilio Lussu, valoroso combattente delle grande guerra e tra i fondatori del Partito Sardo d’Azione.
La disoccupazione.la povertà, la durezza del lavoro in miniera e in fabbrica
C’è poi il grave problema della disoccupazione, la povertà, la durezza del lavoro in miniera e in fabbrica. Se avessi saputo in che cosa consisteva la vita in miniera, avrei fatto centoanni di latitanza piuttosto che consegnarmi a quel lavoro. Centrali nucleari, basi Nato, fabbriche chiuse con gli operai in cassa integrazione, lottizzazione delle coste. Così qualcuno cerca di cambiare la Sardegna, dove non c’è più spazio per i Sardi. Che però non accettano tutto questo, i 180.000 ettari di terreno occupati da servitù militari, la Sardegna incatenata, e conducono la loro lotta per una vita diversa.
Scene di vita del paese
Chiudiamo questa carrellata sui murales di Orgosolo vedendo alcune scene di vita del paese. Il grande murale sui tre piani del palazzo della Biblioteca Civica, le donne di Orgosolo disegnate con un tratto chiaramente ispirato all’opera di Picasso. La corsa del Palio e le esagerazioni quando dopo la corsa si è alzato un poco il gomito.
La grande ospitalità di Orgosolo
Anche a Orgosolo accanto agli studenti che chiedono il diritto allo studio altri vivono diversi valori, scorrazzano in moto e provocano gravi incidenti. E quando lasciamo Orgosolo conserviamo dentro di noi il ricordo delle scene di vita, dei suoi prodotti e soprattutto della sua grande ospitalità. E uscendo dall’abitato con la SP58 in direzione di Nuoro, o entrando in Orgosolo prevenendo da Nuoro, si trova un bel murale che riporta il saluto di Orgosolo ai suoi visitatori.
La prossima tappa del nostro viaggio
Nella prossima tappa del nostro viaggio, continueremo la visita della Barbagia di Ollolai partendo da Orgosolo quello che è stato il paese del banditismo ed è ora il paese dei murales. Qui visiteremo I dintorni di Orgosolo e soprattutto l’altopiano di Pratobello ed i suoi numerosi siti archeologici.
Tutte le foto e riprese sono state effettuate a scopo amatoriale per uso personale senza fini di lucro. Alle nostre foto se ne aggiungono altre inviateci da amici ed alcune tratte da Internet. Alcune informazioni sulle descrizioni dei comuni sono tratte da italiapedia.it, molte descrizioni e foto da wikimapia.org, informazioni sui siti archeologici da tharros.info, altre da siti differenti. È consentito scaricare testi, foto e riprese dell’autore per uso privato senza eliminare i riferimenti. Libri e filmati sono riprodotti per farli conoscere ma non è consentita la riproduzione delle foto di terzi, dei libri, dei filmati e di altro materiale non realizzato dall’autore. È vietato qualsiasi utilizzo commerciale del materiale in assenza di apposita autorizzazione. |
© Claudio de Tisi 2002-2025 - Codice Fiscale DTSCLD44M23F132W