Un sito di oltre 480 pagine che descrive tutta l’Isola e che pur non vendendo nulla riceve fino a oltre un migliaio di visitatori ogni giorno


Visita dei dintorni di Orgosolo la Città del banditismo con l’altopiano di Pratobello ed i suoi numerosi siti archeologici
In questa tappa del nostro viaggio, continueremo la visita della Barbagia di Ollolai partendo da Orgosolo quello che è stato il paese del banditismo ed è ora il paese dei murales. Qui visiteremo I dintorni di Orgosolo e soprattutto l’altopiano di Pratobello ed i suoi numerosi siti archeologici.
Iniziamo la visita dei dintorni di Orgosolo
Vediamo ora che cosa si trova di più sigificativo nei dintorni dell’abitato che abbiamo appena descritto. Per quanto riguarda le principali ricerche archeologiche effettuate nei dintorni di Orgosolo, sono stati portati alla luce i resti della fonta sacra di Su Olosti; di una sessantina di Domus de Janas tra cui quelle di Tettène, Istuvuzzai e Pandelai; di un Dolmen; di una ventina di Menhir; delle Tombe di Giganti di Bentosu, Dovilino, Ena longa, Malarthana, Presethu Tortu I, Presethu Tortu II, Presethu Tortu III, Senepida, Su Milhosu; del santuario protostorico di Orulu; del Nuraghe complesso Ruju; del Nuraghe complesso di tipo misto Dovilino; dei Nuraghi alapiana, Biduni, de Gorropu, de Mereu sito in una zona montuosa di difficile penetrazione, Delacana, Dortesi, Filigai, Funtana Bona, Ghirghinnari, Giuanne Puddu, Ilole, Lartio, Lollove, Luillie, Maninturtio, Mannurrie, Monte Nieddu, Nuragheddu de Burdu, Orghe, Orolai, Ortotidda, Orulu, Pertuntu, Pighisone, S’Oliva Vera, Sa Senepida, Sa Serra Olai, Sirilo, Talasuniai, tutti di tipologia indefinita. Tra le numerose vestigia del suo antichissimo passato figurano anche vari oggetti litici, e resti di età punica e romana.
Lungo la SP22 che da Orgosolo porta ad Oliena si trovano i cantieri per la costruzione della diga di Cumbidanovu
 Usciamo da Orgosolo verso est in direzione di Oliena. Dal centro di Orgosolo prendiamo verso est il corso della Repubblica, che va ad immettersi sulla via della Rinascita, la quale esce dall’abitato come SP22 e, dopo un centinaio di metri, arriviamo al cartello segnaletico che indica l’abitato di Orgosolo. Passato questo cartello, procediamo in direzione di Oliena e, percorsi circa cinque chilometri, ossiamo vedere alla sinistra della strada i cantiere della Diga dell’alto Cedrino, nota come Diga di Cumbidanovu. La costruzione della diga, progettata dall’ingegner Giancarlo Tomasi, che ha progettato anche la diga di Olai che vedremo più avanti. Lo scopo della diga è quello di invasare le acque del fiume Cedrino immediatamente a valle di Orgosolo, e la sua realizzazione è iniziata nel 1989, ma non si sa quando verrà portata a termine. Si tratta di una diga di tipo a gravità massiccia in calcestruzzo, con un asse curvilineo di 330 metri, suddivisa in 19 conci, ognuno con una larghezza di 14 metri. L’altezza della diga raggiunge i 67,17 metri, mentre lo sviluppo del coronamento è di 263,50 metri. Questa opera avrà una capacità di invaso di circa 12,1 milioni di metri cubi. La costruzione della Diga di Cumbidanovu è iniziata diversi anni fa. Tuttavia, un’alluvione devastante nel novembre 2013 ha causato ingenti danni alle aree dedicate agli impianti e ha fermato i lavori. All’epoca dell’evento di piena, erano stati eseguiti tutti i lavori di scavo e riprofilatura delle sponde dell’invaso, nonché il getto dei conci di calcestruzzo della diga, corrispondenti a circa il quindici per cento del volume totale dell’opera. In un prossimo futuro, la Diga di Cumbidanovu sarà pronta per svolgere il suo ruolo nella promozione di una Sardegna più prospera e sostenibile.
Usciamo da Orgosolo verso est in direzione di Oliena. Dal centro di Orgosolo prendiamo verso est il corso della Repubblica, che va ad immettersi sulla via della Rinascita, la quale esce dall’abitato come SP22 e, dopo un centinaio di metri, arriviamo al cartello segnaletico che indica l’abitato di Orgosolo. Passato questo cartello, procediamo in direzione di Oliena e, percorsi circa cinque chilometri, ossiamo vedere alla sinistra della strada i cantiere della Diga dell’alto Cedrino, nota come Diga di Cumbidanovu. La costruzione della diga, progettata dall’ingegner Giancarlo Tomasi, che ha progettato anche la diga di Olai che vedremo più avanti. Lo scopo della diga è quello di invasare le acque del fiume Cedrino immediatamente a valle di Orgosolo, e la sua realizzazione è iniziata nel 1989, ma non si sa quando verrà portata a termine. Si tratta di una diga di tipo a gravità massiccia in calcestruzzo, con un asse curvilineo di 330 metri, suddivisa in 19 conci, ognuno con una larghezza di 14 metri. L’altezza della diga raggiunge i 67,17 metri, mentre lo sviluppo del coronamento è di 263,50 metri. Questa opera avrà una capacità di invaso di circa 12,1 milioni di metri cubi. La costruzione della Diga di Cumbidanovu è iniziata diversi anni fa. Tuttavia, un’alluvione devastante nel novembre 2013 ha causato ingenti danni alle aree dedicate agli impianti e ha fermato i lavori. All’epoca dell’evento di piena, erano stati eseguiti tutti i lavori di scavo e riprofilatura delle sponde dell’invaso, nonché il getto dei conci di calcestruzzo della diga, corrispondenti a circa il quindici per cento del volume totale dell’opera. In un prossimo futuro, la Diga di Cumbidanovu sarà pronta per svolgere il suo ruolo nella promozione di una Sardegna più prospera e sostenibile.
Lungo la SP58 che da Orgosolo porta a Nuoro troviamo la necropoli di Su Calavriche
Usciamo da Orgosolo verso nord in direzione di Nuoro. Dal centro di Orgosolo prendiamo verso nord la via locoe che esce dall’abitato come SP58, che da Nuoro porta a Orgosolo. Dal cartello segnaletico che indica l’abitato di Orgosolo proseguiamo per circa sette chilometri e vediamo alla destra della strada i resti della Necropoli di Su Calavriche, si trova a una diecina di chilometri da Nuoro. Si tratta di tre tombe scavate nel granito su un costone roccioso a fianco strada, sulla sinistra. Su un costone roccioso, sulla destra della strada, si trovano le prime due tombe chiamate le Domus de Janas di Su Calavriche I e Su Calavriche II, che sono un poco nascoste. Nelle due tombe si possono vedere resti di pittura, rossa e gialla, che disegnavano colonne, semicolonne e false finestre ed altri elementi architettonici. Davanti ad una di queste tombe si trovano i resti di un Dolmen. La terza, chiamata la Domus de Janas di Su Calavriche III, si trova un centinaio di metri più avanti, in alto, realizzata sopra una roccia isolata più distante dalla strada. Tutte e tre le domus de Janas sono di tipo semplice senza anticella, presentano una risega nel portello d’accesso, ma non sono visitabili liberamente in quanto si trovano all’interno di una proprietà privata.
La fonte Su Cantaru
Usciamo da Orgosolo verso ovest in direzione di Mamoiada. Da dove dalla via della Repubblica parte alla sinistra la via Nuoro che porta alla periferia settentrionale del paese, proseguiamo lungo la via della Repubblica e, dopo trecentocinquanta metri arriviamo un bivio dove proseguendo verso destra si prende la SP22 che porta verso Mamoiada, mentre a sinistra parte la SP48 che porta verso Montes. Presa la SP22 e percorsi circa trecentocinquanta metri si vede alla sinistra della strada la fonte Su Cantaru, una delle fontane che arricchiscono il territorio di Orgosolo.
Il campo da Softball’di Orgosolo
Passata la fonte Su Cantaru, proseguiamo lungo la SP22 e, dopo circa centosettanta metri, vediamo alla destra della strada l’ingresso del Campo da Softball di Orgosolo. Si tratta di un campo da gioco, nel quale è possibile praticare come discipline Baseball’Softball’e Softball, dotato di tribune in grado di ospitare una trentina di spettatori.
I resti del Nuraghe Ilole
 Passato l’ingresso del campo da Softball’e percorsi ancora lungo la SP22 poco meno di altri duecento metri, poco prima del cartello segnaletico che che indica il chilometro 26, prendiamo una strada in cemento in salita sulla sinistra che, in qualche centinaio di metri, ci fa vedere alla sinistra il nuraghe Ilole, attorno al quale la strada gira. Il Nuraghe, che si trova alla periferia di Orgosolo, è un Nuraghe di tipologia indefinita edificato in materiale indeterminato a 700 metri di altezza, che probabilmente era un Nuraghe complesso, anche se non è possibile identificare l’esatta planimetria, costituito da un mastio centrale e circondato da un bastione del quale qualche tratto è abbastanza ben conservato. È possibile esplorarlo internamente
Passato l’ingresso del campo da Softball’e percorsi ancora lungo la SP22 poco meno di altri duecento metri, poco prima del cartello segnaletico che che indica il chilometro 26, prendiamo una strada in cemento in salita sulla sinistra che, in qualche centinaio di metri, ci fa vedere alla sinistra il nuraghe Ilole, attorno al quale la strada gira. Il Nuraghe, che si trova alla periferia di Orgosolo, è un Nuraghe di tipologia indefinita edificato in materiale indeterminato a 700 metri di altezza, che probabilmente era un Nuraghe complesso, anche se non è possibile identificare l’esatta planimetria, costituito da un mastio centrale e circondato da un bastione del quale qualche tratto è abbastanza ben conservato. È possibile esplorarlo internamente
Il Centro di spiritualità Antonia Mesina in località Galanoli con la Chiesa dello Spirito Santo
 Proseguendo lungo la SP22 in direzione di Mamoiada, dopo circa quattro chilometri prendiamo una deviazione sulla destra, la seguiamo e, dopo un centinaio di metri, arriviamo a un bivio dove prendiamo a sinistra, proseguaimo per circa duecento metri ed arriviamo in località Galanoli, da molti considerata una frazione Orgosolo, che è una delle località più amene e rinomate del suo territorio. Posta in posizione panoramica, a guardia della fertile vallata di locoe, si stende immersa in un folto bosco che fronteggia il maestoso Supramonte di Orgosolo. Il sito dove oggi sorge il Centro di spiritualità Antonia Mesina di Galanoli, un complesso religioso della diocesi di Nuoro, è assai importante dal punto di vista archeologico, essendo stato frequentato fin dalla metà del quarto millennio avanti Cristo da popolazioni dedite alla pastorizia, che vi hanno costruito i loro villaggi ed alcuni monumenti. Durante i periodi successivi la zona è stata utilizzata per il pascolo, senza però grandi stravolgimenti del paesaggio naturale.
Proseguendo lungo la SP22 in direzione di Mamoiada, dopo circa quattro chilometri prendiamo una deviazione sulla destra, la seguiamo e, dopo un centinaio di metri, arriviamo a un bivio dove prendiamo a sinistra, proseguaimo per circa duecento metri ed arriviamo in località Galanoli, da molti considerata una frazione Orgosolo, che è una delle località più amene e rinomate del suo territorio. Posta in posizione panoramica, a guardia della fertile vallata di locoe, si stende immersa in un folto bosco che fronteggia il maestoso Supramonte di Orgosolo. Il sito dove oggi sorge il Centro di spiritualità Antonia Mesina di Galanoli, un complesso religioso della diocesi di Nuoro, è assai importante dal punto di vista archeologico, essendo stato frequentato fin dalla metà del quarto millennio avanti Cristo da popolazioni dedite alla pastorizia, che vi hanno costruito i loro villaggi ed alcuni monumenti. Durante i periodi successivi la zona è stata utilizzata per il pascolo, senza però grandi stravolgimenti del paesaggio naturale.
All’interno del Centro di spiritualità Antonia Mesina si trova la monumentale Chiesa intitolata allo Spirito Santo, composta da una cripta e locali accessori nel piano seminterrato, e dalla sala di culto principale al piano terra, è uno dei simboli della spiritualità locale e della storia recente dell’architettura sacra in Sardegna. La struttura in cemento armato è caratterizzata dalla sua copertura curva e spiovente, che culmina sopra l’altare a un’altezza di circa quindici metri. Nella Chiesa, l’altare in pietra è quanto resta del lastrone di copertura di un Dolmen distrutto.
Passato il luogo del martirio raggiungiamo la Chiesa campestre dei Santi Egidio e Anania
Usciamo da Orgosolo verso ovest in direzione di Mamoiada. Da dove dalla via della Repubblica parte alla sinistra la via Nuoro che porta alla periferia settentrionale del paese, proseguiamo lungo la via della Repubblica e, dopo trecentocinquanta metri arriviamo un bivio dove proseguendo verso destra la SP22 porta verso Mamoiada, mentre prendiamo a sinistra la SP48 che si dirige verso Montes, e che porta in direzione del Supramonte e di Pratobello. Percorso un chilometro e cento metri lungo la SP48, prendiamo la deviazione a sinistra seguendo le indicazioni per il luogo del martirio della Beata Antonia Masina, un tratto di strada divenuto nel tempo un cammino devozionale verso una sentita meta di pellegrinaggio. Presa questa strada di collegamento, la seguiamo e, dopo un chilometro, vediamo alla sinistra della strada, sopra un masso, la croce commemorativa edificata sul luogo del martirio di Sant’Anania, un soldato romano martire del Cristianesimo, che scondo la tradizione locale sarebbe stato ucciso, insieme a Egidio, nel 310 dalla popolazione locale mentre cercava di diffondere il Vangelo, come risulta da un’epigrafe in marmo conservata nella casa parrocchiale della Chiesa a lui dedicata. Uccisione che sarebbe avvenuta duecentottanta anni prima che Gregorio Magno convincesse il re giudice dei barbaricini Ospitone a convertire al Cristianesimo i suoi cittadini.
Proseguiamo e, dopo quasi trecento metri, vediamo alla destra della strada la seicentesca Chiesa campestre dedicata ai Santi Egidio e Anania, che viene chiamata Chiesa di Santu Naniu e Santu Zìliu. Si tratta di sue Santi autoctoni, vittime dello scontro, che su queste montagne durò più a lungo di altrove, fra l’antica religione dei Sardi e la religione cristiana. L’edificio sacro si distingue per la sua architettura tipicamente sarda, con una facciata imponente arricchita da decorazioni in pietra e da elementi artistici di grande pregio.
L’interno della Chiesa, infatti, è caratterizzato da affreschi e opere d’arte che risalgono a diverse epoche storiche, testimonianza della ricca tradizione artistica e religiosa di questa zona interna della Sardegna. Durante tutto l’anno, numerosi fedeli e turisti giungono qui per ammirare la bellezza dell’edificio e per respirare l’atmosfera di sacralità che vi si respira.
La prima o la seconda domenica di giugno, si svolge la Festa di Santu Anania, nella Chiesa campestre dedicata ai Santi Martiri Egidio ed Anania, intitolata ai due martiri uccisi mentre diffondevano il Vangelo, che prevede la celebrazione della messa solenne, seguita dalla tipica processione in costume sardo e una corsa di cavalli.
Il luogo del martirio della Beata Antonia Mesina
Percorso circa un chilometro e duecento metri lungo la strada di collegamento, in prossimità di un tornante fra i lecci vediamo un cancello sulla destra che ci fa raggiungere, in località Ovadduthai, il luogo del martirio della Beata Antonia Mesina, martire della purezza, uccisa quì a soli sedici anni a colpi di pietra il 17 maggio del 1935 per difendere la propria castità fino alla morte, diventando anche un simbolo contro la malvagità e i soprusi.
Ed in questo luogo ogni anno, il 17 maggio in occasione delle ricorrenza della sua morte, si svolgono le cerimonie di Commemorazione della beata Antonia Mesina con la processione che precede le cerimonie religiose sul luogo del suo martirio.
I resti della necropoli di Sa lhopasa detta anche di Salhopasa
 Proseguiamo lungo la strada di collegamento divenuta nel tempo un cammino devozionale verso la sentita meta di pellegrinaggio al luogo del martirio della Beata Antonia Masina. Percorso un chilometro e duecento metri, troviamo una deviazione sulla destra, la seguiamo e dopo quasi trecento metri si trovano alla sinistra della strada i resti della necropoli di Sa lhopasa, che viene chiamata anche necropoli di Salhopasa. La necropoli, che sorge a circa cinque chilometri dal centro abitato di Orgosolo, è composta da tre Domus de Janas scavate in spuntoni di roccia granitica, delle quali le prime due assai vicine tra loro, mentre la terza più a sud appare come incompiuta. Qui riportiamo una planimetria della necropoli con le tre Domus de Janas disposte verticalmente da nord a sud, ed indicate con la nostra numerazione nella quale la più significativa viene indicata come la tomba II, che da molti viene però chiamata semplicemente come la Domus de Janas di Sa lhopasa, o come la tomba I della necropli di Sa lhopasa.
Proseguiamo lungo la strada di collegamento divenuta nel tempo un cammino devozionale verso la sentita meta di pellegrinaggio al luogo del martirio della Beata Antonia Masina. Percorso un chilometro e duecento metri, troviamo una deviazione sulla destra, la seguiamo e dopo quasi trecento metri si trovano alla sinistra della strada i resti della necropoli di Sa lhopasa, che viene chiamata anche necropoli di Salhopasa. La necropoli, che sorge a circa cinque chilometri dal centro abitato di Orgosolo, è composta da tre Domus de Janas scavate in spuntoni di roccia granitica, delle quali le prime due assai vicine tra loro, mentre la terza più a sud appare come incompiuta. Qui riportiamo una planimetria della necropoli con le tre Domus de Janas disposte verticalmente da nord a sud, ed indicate con la nostra numerazione nella quale la più significativa viene indicata come la tomba II, che da molti viene però chiamata semplicemente come la Domus de Janas di Sa lhopasa, o come la tomba I della necropli di Sa lhopasa.
La principale domus de Janas di sa lhopasa è composta da due ambienti, l’anticella e la cella principale. Si accede alla tomba tramite un ingresso trapezoidale, che conduce a un vano quadrangolare. Nelle pareti laterali, sotto il soffitto, resistono tracce di pittura in ocra rossa. In quella di sinistra c’è anche un bassorilievo, forse pertinente a una lesena che è andata però distrutta. Nel lato opposto all’ingresso si trova l’accesso alla camera principale, a pianta rettangolare, il cui sviluppo in altezza è maggiore rispetto alla profondità. Si nota che pareti ed il soffitto in alcuni tratti sembrano più rifiniti rispetto a parti in cui, invece, paiono appena sbozzati, il che testimona che forse la decorazione della domus non è stata mai completata. L’elemento più sorprendente della cella è il focolare di forma circolare, del diametro di circa mezzo metro, al centro del pavimento. Presenta un listello con bordi arrotondati e vanta una particolarità, dato che si fonde con una specie di piattaforma risparmiata sulla roccia, sulla quale sono state ricavate quattro coppelle del diametro di pochi centimetri, eseguite a martellina diretta. Il focolare ha un particolare che lo rende davvero unico, dato che «è fuso con una piattaforma ad arco di cerchio, appena livellata, risparmiata nella roccia ed aggettante, presso la parete di fondo, m. 0,15 in media». Nella parete di fondo, oltre a ulteriori tracce di pittura rossa, si vede una nicchia rettangolare, al cui interno compare un semipilastro betilico, realizzato a bassorilievo, molto probabilmente legato alla funzione sacra e cultuale del vano. Per alcuni rappresenterebbe un simbolo maschile legato a riproduzione e rinascita, in contrapposizione al carattere funebre del luogo.
La Chiesa di San Marco Evangelista
Ritoniamo sulla SP48. Da dove avevamo imboccato la strada di collegamento che ci aveva portato al luogo del martirio della Beata Antonia Mesina, proseguiamo con la SP48 e percorriamo altri circa cinquecento metri, fino a trovare sulla sinistra della strada la piccola Chiesa campestre di San Marco Evangelista chamata Chiesa di Santu Malhu, situata a poca distanza dall’abitato, nella sua periferia meridionale.
Presso questa piccola Chiesa il 25 aprile si svolge la Festa di San Marco, che prevede le cerimonie religiose e poi, in paese, la distribuzione ai bambini de Sa Ita, ossia di grossi pezzi di carne cruda di agnello e di pane, ben da otto a dieci quintali di pane e da trentacinque a quaranta agnelli, che si preparano per l’occasione. Una volta la tradizione era di donare questo cibo alle persone bisognose, in segno di ringraziamento per grazia ricevuta.
La Chiesa di San Michele Arcangelo chiamata anche Chiesa di San Michele a Montes
Dopo aver visto la Chiesa campestre di San Marco Evangelista, riprendiamo la SP48 e proseguimo per circa un altro chilometro e mezzo, fino a trovare alla destra della strada l’indicazione per il ristorante tipico Supramonte. Qui prendiamo a sinistra una strada sterrata in salita e, dopo trecentocinquanta metri, arriviamo a un bivio dove prendiamo a sinistra. Percorso poco più di un altro chilometro e mezzo tra i monti, arriviamo a vedere alla sinistra della strada la Chiesa di San Michele Arcangelo detta anche di Santu Micheli, che si trova all’interno della foresta di Montes e per questo viene chiamata anche Chiesa di San Michele a Montes. Si tratta di una Chiesa del quindicesimo secolo che si trova sul monte lisorgoni e domina dall’alto tutto l’abitato di Orgosolo.
La bella fonte di Su Dentes
Tornati sulla SP48, dopo l’indicazione alla destra della strada per il ristorante tipico Supramonte, percorriamo verso sud quasi un chilometro e vediamo alla destra della strada il parcheggio per l’area picnic di Su Dentes, una zona in cui si può sostare, mangiare e bere acqua fresca di sorgente, un estate c'è sempre fresco essendo una zona tranquilla ricoperta di lecci e tutti ne approffittano per prendere aria pura fino a tarda sera. Dal parcheggio, procedendo per poco più di duecento metri tra gli alberi, raggiungiamo la bella Fonte di Su Dentes, con una vasca rettangolare che raccoglie l’acqua, su un fondo lastricato.
I ruderi della Chiesa campestre di Sant’Antioco
Dal parcheggio per l’area picnic di Su Dentes, proseguiamo verso sud lungo la SP48 per un chilometro e seicento metri, e troviamo sulla destra la deviazione sulla SP2bis che ci porta verso occidente in direzione di Fonni e di Lanusei. La seguiamo e, dopo quattrocentocinquanta metri, svoltiamo a destra in una stradina sterrata e percorriamo altri quattrocentocinquanta metri, fino a vedere alla destra della strada i ruderi della Chiesa campestre di Sant’Antioco, che si trova vicino alla foresta di Montes e per questo viene chiamata anche Chiesa di Sant’Antioco di Montes.
Sono pubblicate prima due foto del 2005 nella quale si vedono i ruderi, e poi una foto del 2010 della nuova struttura costruita accanto ai ruderi. Nell’area, resa unica dalle secolari querce, si trovano anche un anfiteatro, ed una struttura ricettiva Comunale per la somministrazione di alimenti e bevande, che è quasi sempre chiusa. nella quale non vi sono tavoli nè sedie, ma è possibile sedersi lungo i muretti di recinzione.
Resti del Nuraghe chiamato Nuragheddu de Burdu
Percorsa appena una cinquantina di metri lungo la SP2bis dopo la deviazione per i ruderi della Chiesa campestre di Sant’Antioco, si può prendere un sentiero sulla sinistra lungo il quale alla sinistra si possono visitare i resti di un piccolo Nuraghe chiamato Nuragheddu de Burdu, di tipologia indefinita edificato in granito a 984 metri di altezza, la cui struttura è ancora oggi parzialmente visibile.
Il Galoppatoio Comunale di Orgosolo
Proseguendo verso ovest sulla SP2bis, passato il Nuraghe chiamato Nuragheddu del Burdu, troviamo poco più avanti, sempre alla sinistra della strada, il Galoppatoio Comunale di Orgosolo, situato in località Ispadulargiu. L’ippodromo di Orgosolo, ossia il Galoppatoio Ispadulargiu, è intitolato ad Andrea Cossu, primo presidente e uno dei fondatori dell’associazione Ippica. In esso si corre, tra l’altro, Su palu e de Nostra Sennora de Mesaustu, ossia il Palio dell’Assunta, uno degli appuntamenti più gettonati sia dai fantini che dagli appassionati.
I resti del Nuraghe complesso Duvilinò
 Proseguendo verso ovest lungo la SP2bis, a un chilometro ed ottocento metri di distanza da dove la avevamo imboccata provenendo dalla SP48, si trovano alla destra della strada i pochi resti della Tomba di Giganti di Duvilinò. La tomba è stata edificata in materiale indeterminato, a un’altezza di 970 metri, e di essa non restano altro che alcune pietre.
Proseguendo verso ovest lungo la SP2bis, a un chilometro ed ottocento metri di distanza da dove la avevamo imboccata provenendo dalla SP48, si trovano alla destra della strada i pochi resti della Tomba di Giganti di Duvilinò. La tomba è stata edificata in materiale indeterminato, a un’altezza di 970 metri, e di essa non restano altro che alcune pietre.
Alla distanta di circa duecento metri, sopra una altura alla destra della strada, di trovano i resti del nuraghe Duvilinò, che non è però visibile dalla strada. Si tratta di un Nuraghe complesso di tipo misto, cioè con caratteristiche sia dei Nuraghi a corridoio o proto nuraghi, sia dei successivi Nuraghi complessi a tholos, edificato in blocchi squadrati di notevoli dimensioni di granito, a 985 metri di altezza. Il Nuraghe si erge su un affioramento roccioso in posizione strategica sfruttando la conformazione delle rocce granitiche, per dominare sulla pianura di Pratobello. Il mastio è un quanto resta di un Nuraghe a corridoio, si tratta di una torre centrale con corridoi, la cui altezza residua è di circa dodici metri, attorno alla quale si dispongono tre torri secondarie. L’ingresso architravato immette in un corridoio coperto a piattabanda. Sul lato sinistro del passaggio c’è un cunicolo che conduce a un pozzo, realizzato con filari di piccole pietre e con copertura ogivale, profondo quasi due metri. Da un’apertura sulla destra si accede alla camera principale a pianta ellittica, con una nicchia e un altro corridoio, che, attraverso una scala elicoidale, conduce al livello superiore. Due delle tre torri secondarie sono coperte da macerie dovute a crolli, mentre la terza, quella ovest, presenta una curiosa struttura, dato che sul lato sud si aprono due corridoi che conducono allo stesso ambiente, invece sul lato opposto parte un terzo corridoio che sfocia nel lato nord della torre.
 Proprio dalla torre occidentale si diparte un antemurale, che si sviluppa fino a chiudere tutta un’area di forma regolare davanti all’ingresso principale. E tutt'intorno all’edificio, ma con una densità maggiore sul lato a sud orientale, si vedono i resti delle capanne che costituivano il villaggio nuragico, alcune delle quali di dimensioni notevoli che arrivavano a misurare anche intorno ai dieci metri. Si trattava di un grande villaggio del quale si presenta oggi solo una distesa di rovine di circa otto mila metri quadri, con muretti nuragici, ed a una cinquantina di metri di distanza, sono presenti anche i resti di un muro di recinzione. Il Nuraghe Duvilinò stato oggetto di un intervento di scavo condotto dalla Soprintendenza per i Beni archeologici di Sassari e Nuoro nel 1984.
Proprio dalla torre occidentale si diparte un antemurale, che si sviluppa fino a chiudere tutta un’area di forma regolare davanti all’ingresso principale. E tutt'intorno all’edificio, ma con una densità maggiore sul lato a sud orientale, si vedono i resti delle capanne che costituivano il villaggio nuragico, alcune delle quali di dimensioni notevoli che arrivavano a misurare anche intorno ai dieci metri. Si trattava di un grande villaggio del quale si presenta oggi solo una distesa di rovine di circa otto mila metri quadri, con muretti nuragici, ed a una cinquantina di metri di distanza, sono presenti anche i resti di un muro di recinzione. Il Nuraghe Duvilinò stato oggetto di un intervento di scavo condotto dalla Soprintendenza per i Beni archeologici di Sassari e Nuoro nel 1984.
Sull’altopiano di Pratobello il piccolo borgo famoso per la sua rivolta popolare contro l’espropriazione dei terreno adibiti a pascolo
Seguendo la SP2bis, dopo circa quattro chilometri e mezzo da dove la abbiamo imboccata, passata sotto il viadotto sopra il quale passa la SS389 di Buddusò e del Correboi, svoltando a sinistra sulla SP2 che si dirige verso sud. Dopo circa cinquecento metri, lungo la SP2 raggiungiamo il piccolo borgo denominato Pratobello (altezza metri 882, distanza 11.2 chilometri). Pratobello è famoso perché, sul suo altopiano, avvenne la rivolta popolare contro l’occupazione militare di 13 mila ettari di terreni adibiti a pascolo.
Resti del villaggio abitativo di Pratobello
 alla sinistra della SP2 si trovano i ruderi degli edifici del piccolo borgo di Pratobello, abbandonato dopo la rivolta. Il piccolo paese edificato nella zona dei pascoli di Pratobello comprendeva la Chiesa, le scuole e le abitazioni per ospitare le famiglie dei militari che lavoravano nel poligono temporaneo di tiro, e, circa seicento metri più a sud, lungo la strada, il Cimitero di Pratobello. Oggi quel che resta è un vero piccolo paese fantasma, dove i ruderi sono il ricordo di un importante evento della storia recente dell’Isola. Sulle pareti, come al solito, c’è il diario generazionale dei giovani della zona, oltre ad alcune scritte indipendentiste e due bei murales che ricordano lo spirito della rivolta di Pratobello e il rischio ricorrente di uno Stato autoritario che veda nell’Isola il proprio parco giochi per operazioni militari.
alla sinistra della SP2 si trovano i ruderi degli edifici del piccolo borgo di Pratobello, abbandonato dopo la rivolta. Il piccolo paese edificato nella zona dei pascoli di Pratobello comprendeva la Chiesa, le scuole e le abitazioni per ospitare le famiglie dei militari che lavoravano nel poligono temporaneo di tiro, e, circa seicento metri più a sud, lungo la strada, il Cimitero di Pratobello. Oggi quel che resta è un vero piccolo paese fantasma, dove i ruderi sono il ricordo di un importante evento della storia recente dell’Isola. Sulle pareti, come al solito, c’è il diario generazionale dei giovani della zona, oltre ad alcune scritte indipendentiste e due bei murales che ricordano lo spirito della rivolta di Pratobello e il rischio ricorrente di uno Stato autoritario che veda nell’Isola il proprio parco giochi per operazioni militari.
La abitazioni di Pratobello
 Il villaggio si sviluppava in un’area di poco più di un ettaro, su un lotto di forma pressappoco rettangolare, nel perimetro del quale si dispongono, in maniera ordinata, sei edifici concepiti per accogliere varie funzioni che garantivano nel villaggio i servizi essenziali agli abitanti. Due cancelli ubicati sulla SP2 delimitano l’inizio della viabilità interna del complesso, con vie alberate slarghi di forma regolare, intorno alle quali si articolano le strutture architettoniche. La semplicità dei materiali adoperati, delle tecniche costruttive e delle geometrie, appare interrompersi in alcune parti nelle quali si cerca di generare delle architetture più ricercate, come ad esempio per i portici con gli archi a tutto sesto o la facciata principale della Chiesa. L’architettura, nella sua forma, appare dettata principalmente dalle funzioni che doveva accogliere. La pavimentazione esterna agli edifici è ugualmente semplice, realizzata in battuto di cemento, mentre piastrelle in graniglia, abbelliscono la parte ricoperta dai portici, come gli interni degli edifici.
Il villaggio si sviluppava in un’area di poco più di un ettaro, su un lotto di forma pressappoco rettangolare, nel perimetro del quale si dispongono, in maniera ordinata, sei edifici concepiti per accogliere varie funzioni che garantivano nel villaggio i servizi essenziali agli abitanti. Due cancelli ubicati sulla SP2 delimitano l’inizio della viabilità interna del complesso, con vie alberate slarghi di forma regolare, intorno alle quali si articolano le strutture architettoniche. La semplicità dei materiali adoperati, delle tecniche costruttive e delle geometrie, appare interrompersi in alcune parti nelle quali si cerca di generare delle architetture più ricercate, come ad esempio per i portici con gli archi a tutto sesto o la facciata principale della Chiesa. L’architettura, nella sua forma, appare dettata principalmente dalle funzioni che doveva accogliere. La pavimentazione esterna agli edifici è ugualmente semplice, realizzata in battuto di cemento, mentre piastrelle in graniglia, abbelliscono la parte ricoperta dai portici, come gli interni degli edifici.
La Chiesa di Pratobello
L’edificio che avrebbe ospitato la Chiesa di Pratobello presenta un’unica navata con abside. Il campanile a vela, di circa sedici metri, disposto in mezzeria, in asse con l’ingresso alla Chiesa, ed appare essere imponente. È realizzato con conci di granito con alcune parti in mattoni laterizi pieni che fungono da unico apparato di abbellimento. Nella facciata, un rosone circolare con grata in ferro, interrompe la continuità della muratura della facciata in conci di granito faccia a vista. La porta è priva di finiture di pregio, ma è resa leggermente monumentale dalla presenza di tre gradini anteposti. Le murature laterali sono ricoperte da intonaco, e una serie di monofore, quattro per parte, rendono ampiamente luminoso l’interno della struttura. Il manto della copertura è in coppi, con palombelli in elementi prefabbricati di cemento armato che sorreggono la breve sporgenza a sbalzo. Identiche in grandezza e forma sono le monofore presenti nell’abside, che è realizzata in conci di granito lasciati faccia a vista all’esterno, intonacata all’interno. La copertura a doppia falda è controsoffittata da un orizzontamento realizzato con travetti e tavelloni. Gli infissi, da quanto si può ancora osservare, erano realizzati in legno.
 L’edificio che avrebbe ospitato la Casa Canonica è un corpo di fabbrica collegato alla Chiesa, che ha una forma pressappoco a L e si sviluppa su un unico livello, con un portico sul lato della facciata principale della Chiesa, ma arretrato rispetto ad essa. Le tecniche costruttive combinano diversi materiali, dalle pietre di granito, ai mattoni laterizi forati o pieni, ai blocchi di cemento. Il prospetto a nord, prospiciente la strada provinciale, è in conci di pietrame sbozzato, con elementi più regolari per la realizzazione di cantonali o spallette di bucature. Qui si ritrova una composizione di tre finestre, disposte centralmente rispetto al corpo principale, con unico architrave dato da un elemento prefabbricato in cemento armato e, al di sopra di esso, due filari di mattoni in cotto pieni. Un leggero sporto della copertura a doppia falda, termina in sommità l’edificio, con medesimi elementi in cemento, tavelle e manto di coppi. Sull’opposto prospetto, a sud, pilastri in cemento sostengono quattro archi ribassati realizzati in mattoni forati e la soluzione in copertura è la medesima. Gli spazi interni sono regolari, articolati su un corridoio che si dispone parallelamente a tali portici.
L’edificio che avrebbe ospitato la Casa Canonica è un corpo di fabbrica collegato alla Chiesa, che ha una forma pressappoco a L e si sviluppa su un unico livello, con un portico sul lato della facciata principale della Chiesa, ma arretrato rispetto ad essa. Le tecniche costruttive combinano diversi materiali, dalle pietre di granito, ai mattoni laterizi forati o pieni, ai blocchi di cemento. Il prospetto a nord, prospiciente la strada provinciale, è in conci di pietrame sbozzato, con elementi più regolari per la realizzazione di cantonali o spallette di bucature. Qui si ritrova una composizione di tre finestre, disposte centralmente rispetto al corpo principale, con unico architrave dato da un elemento prefabbricato in cemento armato e, al di sopra di esso, due filari di mattoni in cotto pieni. Un leggero sporto della copertura a doppia falda, termina in sommità l’edificio, con medesimi elementi in cemento, tavelle e manto di coppi. Sull’opposto prospetto, a sud, pilastri in cemento sostengono quattro archi ribassati realizzati in mattoni forati e la soluzione in copertura è la medesima. Gli spazi interni sono regolari, articolati su un corridoio che si dispone parallelamente a tali portici.
Le scuole di Pratobello
 L’edificio che avrebbe dovuto ospitare le Scuole di Pratobello ricopre una superficie totale di circa trecento metri quadrati e si dispone planimetricamente assemblando tre rettangoli che ne dovevano accogliere le varie funzioni. Una sua parte si sviluppa su due livelli, mentre la maggior parte della struttura presenta un solo piano. Nella parte esposta a sud est si disponeva un loggiato che si trovava antistante allo spazio interno in cui vi sono le scale. La copertura è a doppia falda, e si articola seguendo la conformazione degli spazi. Le murature in pietrame di granito sono ricoperte da intonaco superficiale e pittura superficiale. Una zoccolatura in granito costituiva l’unico elemento di finitura, mentre le soluzioni adottate sono altrove molto semplici. Gli orizzontamenti erano dati da elementi in cemento armato prefabbricati e tavelle. Nelle murature interne, ma anche in parte in quelle esterne, si ritrova la posa in opera di blocchi di cemento. La copertura presenta manto in coppi, e palombelli in cemento armato che sorreggono il breve sporto realizzato con tavelle laterizie.
L’edificio che avrebbe dovuto ospitare le Scuole di Pratobello ricopre una superficie totale di circa trecento metri quadrati e si dispone planimetricamente assemblando tre rettangoli che ne dovevano accogliere le varie funzioni. Una sua parte si sviluppa su due livelli, mentre la maggior parte della struttura presenta un solo piano. Nella parte esposta a sud est si disponeva un loggiato che si trovava antistante allo spazio interno in cui vi sono le scale. La copertura è a doppia falda, e si articola seguendo la conformazione degli spazi. Le murature in pietrame di granito sono ricoperte da intonaco superficiale e pittura superficiale. Una zoccolatura in granito costituiva l’unico elemento di finitura, mentre le soluzioni adottate sono altrove molto semplici. Gli orizzontamenti erano dati da elementi in cemento armato prefabbricati e tavelle. Nelle murature interne, ma anche in parte in quelle esterne, si ritrova la posa in opera di blocchi di cemento. La copertura presenta manto in coppi, e palombelli in cemento armato che sorreggono il breve sporto realizzato con tavelle laterizie.
La caserma dei Carabinieri

 L’edificio che avrebbe dovuto ospitare la Caserma dei Carabinieri di Pratobello si compone di tre edifici accorpati, due hanno una parete in comune, la terza si unisce sul cantonale, strutture che occupano una superficie complessiva di circa trecentocinquanta metri quadrati. La copertura segnava tale composizione planimetrica, con due coperture a doppio spiovente e una a unica falda. Privo di finiture di pregio, presenta la parte centrale con un portico. Il corpo principale ha un corridoio centrale che connette tutte le stanze, e ordina gli spazi che ben si intuiscono dalla disposizione delle bucature. Le murature in pietrame granitico sono ricoperte da intonaci, e tecniche costruttive tradizionali sono accompagnati dalla posa in opera di prefabbricati in cemento. La copertura è mista, con manto in coppi, e palombelli in cemento armato che sorreggono il breve sporto. Le bucature non sempre rispettano l’allineamento verticale con le relative sottostanti mentre si rispetta l’ordine orizzontale.
L’edificio che avrebbe dovuto ospitare la Caserma dei Carabinieri di Pratobello si compone di tre edifici accorpati, due hanno una parete in comune, la terza si unisce sul cantonale, strutture che occupano una superficie complessiva di circa trecentocinquanta metri quadrati. La copertura segnava tale composizione planimetrica, con due coperture a doppio spiovente e una a unica falda. Privo di finiture di pregio, presenta la parte centrale con un portico. Il corpo principale ha un corridoio centrale che connette tutte le stanze, e ordina gli spazi che ben si intuiscono dalla disposizione delle bucature. Le murature in pietrame granitico sono ricoperte da intonaci, e tecniche costruttive tradizionali sono accompagnati dalla posa in opera di prefabbricati in cemento. La copertura è mista, con manto in coppi, e palombelli in cemento armato che sorreggono il breve sporto. Le bucature non sempre rispettano l’allineamento verticale con le relative sottostanti mentre si rispetta l’ordine orizzontale.
Il cimitero di Pratobello
Circa seicento metri più avanti, in direzione sud occidentale, lungo la SP2 si trovano i resti di quello che doveva essere il Cimitero di Pratobello. Non essendo mai stato usato, oggi appare come un semplice campo delimitato da un muretto.
Proseguiamo la visita dei dintorni di Orgosolo
Dopo aver visitiato i resti del piccolo borgo di Pratobello, possiamo proseguire la visita dei dintorni do Orgosolo.
La Dida di Olai che ha formato il lago omonimo

 Da Pratobello con la SP2, subito dopo l’abitato, al primo svincolo prendiamo verso sinistra la strada verso Nuoro e, passati sotto il viadotto sopra il quale passa la SS389 di Buddusò e del Correboi, prendiamo la prima deviazione a destra nella strada che porta da Pratobello alla Diga sul Rio Olai. Si tratta di una strada che porta verso est e ci fa raggiungere l’altopiano sul quale troviamo la Diga di Olai, il località Perdusale. Si tratta di una diga a gravità ordinaria in calcestruzzo, dell’altezza di 51,6 metri, realizzata su progetto dell’ingegner Giancarlo Tomasi. I lavori per la sua realizzazione sono iniziati nel 1989 e sono stati portati a termine nel 2002. La diga forma il Lago di Olai un invaso con una capacità utile di circa 15mila metri cubi d’acqua per uso principalmente potabile.
Da Pratobello con la SP2, subito dopo l’abitato, al primo svincolo prendiamo verso sinistra la strada verso Nuoro e, passati sotto il viadotto sopra il quale passa la SS389 di Buddusò e del Correboi, prendiamo la prima deviazione a destra nella strada che porta da Pratobello alla Diga sul Rio Olai. Si tratta di una strada che porta verso est e ci fa raggiungere l’altopiano sul quale troviamo la Diga di Olai, il località Perdusale. Si tratta di una diga a gravità ordinaria in calcestruzzo, dell’altezza di 51,6 metri, realizzata su progetto dell’ingegner Giancarlo Tomasi. I lavori per la sua realizzazione sono iniziati nel 1989 e sono stati portati a termine nel 2002. La diga forma il Lago di Olai un invaso con una capacità utile di circa 15mila metri cubi d’acqua per uso principalmente potabile.
I resti del Nuraghe Talasuniai
Col riempimento del bacino artificiale del lago di Oliai, il nuraghe Talasuniai di tipologia indefinita, edificato in granito a 945 metri di altezza, è rimasto sulla sommità di un piccolo isolotto, che si trova all’interno dell’invaso. Ed il Nuraghe, costruito migliaia di anni fa, ennesima testimonianza del misterioso popolo nuragico che visse in Sardegna nell’antichità, si trova ora sopra un isolotto, in completa solitudine.
L’area archeologica di Sirilò

 Torniamo ora sulla SP48. Evitando la deviazione a destra sulla SP2bis, proseguiamo verso sud lungo la SP48 e, percorsa appena una ciquantina di metri, svoltiamo a sinistra nella strada per Ventosu, che seguiamo per settecento metri, fino a vedere partire a sinistra una sterrata che procede in salita e, in quasi un chilometro e mezzo, porta all’area archeologica di Sirilò, che occupa la cima e le pendici di un monte alto oltre un migliaio di metri che custodisce le tracce di frequentazioni antichissime, con una storia ancora da rivelare e raccontare. Il sito comprende un Nuraghe, i resti di un villaggio nuragico, una necropoli con diverse Domus de Janas, un tempietto che delimita l’ingresso di una Domus de Janas, particolare, quest'ultimo, abbastanza singolare ed interessante, ed un Dolmen. Il tutto sorge in una bellissima foresta di lecci. L’area archeologica di Sirilò è stata oggetto di scavi dal 2002 al 2003.
Torniamo ora sulla SP48. Evitando la deviazione a destra sulla SP2bis, proseguiamo verso sud lungo la SP48 e, percorsa appena una ciquantina di metri, svoltiamo a sinistra nella strada per Ventosu, che seguiamo per settecento metri, fino a vedere partire a sinistra una sterrata che procede in salita e, in quasi un chilometro e mezzo, porta all’area archeologica di Sirilò, che occupa la cima e le pendici di un monte alto oltre un migliaio di metri che custodisce le tracce di frequentazioni antichissime, con una storia ancora da rivelare e raccontare. Il sito comprende un Nuraghe, i resti di un villaggio nuragico, una necropoli con diverse Domus de Janas, un tempietto che delimita l’ingresso di una Domus de Janas, particolare, quest'ultimo, abbastanza singolare ed interessante, ed un Dolmen. Il tutto sorge in una bellissima foresta di lecci. L’area archeologica di Sirilò è stata oggetto di scavi dal 2002 al 2003.
Sulla sommità del monte si trovano i resti del nuraghe Sirilò, di tipologia indefinita, è stato edificato usando grossi conci di granito a 1105 metri di altezza, e si conserva per i primi tre filari. Se ne individua l’ingresso trapezoidale con architrave ancora in situ. Dalla sua posizione si gode di un panorama mozzafiato, con il Supramonte di Oliena a est, verso sud il massiccio del Gennargentu, a ovest si scorge l’abitato di Fonni, mentre a nord, oltre Orgosolo, la vista si apre su Nuoro. Attorno al Nuraghe si trovano i resti di un villaggio nuragico, che conta almeno una quindicina di capanne, che era stato abitato già in età prenuragica.
Allo stesso periodo del villaggio nuragico risale la necropoli di Sirilò, della quale erano state individuate inizialmente otto Domus de Janas, con sette tombe scavate in una roccia granitica, poste in forte pendio, che degradano pericolosamente verso il canalone sottostante, attorno al quale si estende un bosco di lecci, mentre la ottava si trova una cinquantina di metri più a nord rispetto ad esse. Successive ricerche hanno portato ad aumentarne il numero che ad oggi conta tredici Domus de Janas.
Le tombe presentano planimetrie molto semplici e sono costituite per lo più da una o due celle di forma rettangolare, pseudo circolare, reniforme, ellittica. Tali forme talvolta si ritrovano associate nei vani dello stesso ipogeo, secondo lo sviluppo planimetrico consentito dalla roccia, infatti la forma dei vani è condizionata dalle dimensioni e dalla forma della roccia della quale i costruttori seguivano i contorni irregolari. Alcune Domus de Janas risultano prive di copertura, crollate per la elevata escursione termica a causa dell’altitudine della zona posta a mille metri e oltre, che provoca lo sgretolamento di un particolare tipo di granito degradato molto vulnerabile agli agenti esterni. Si vedono sepolture sviluppate secondo una planimetria semplice e condizionata dalla forma del pendio, con uno o due vani a pianta variabile. Le tombe più piccole monocellulari sono prive di corridoio e presentano una particolare cura nella realizzazione dei portelli di ingresso con riseghe per il rincasso del chiusino. Un ipogeo composto da due soli vani presenta due ingressi distinti. Alcune tombe sono arricchite all’interno da particolari architettonici costituiti da alcove funerarie molto sopraelevate dal piano di calpestio e delimitate da una cornice in rilievo. Vi sono, inoltre, piccoli banconi e scanalature in corrispondenza dei portelli che collegano tra loro gli ambienti. Alcune tombe sono più elaborate dal punto di vista architettonico, con alcove funerarie in posizione sopraelevata rispetto al pavimento, cornici, scanalature nei portelli di collegamento tra gli ambienti, piccoli banconi e piccole fossette, talvolta in coppia, scavate all’interno delle celle funerarie e nei padiglioni di accesso, destinate forse ad accogliere offerte per i defunti. Non sono stati individuati elementi decorativi simbolici e rituali, però si notano residue tracce di ocra rossa che è stata distrutta dalle muffe e dall’erosione delle pareti.
A nord rispetto alla necropoli è presente un tempietto a megarhon di Sirilò, costruito sfruttando una precedente sepoltura dato che delimita l’ingresso della ottava Domus de Janas, particolare quest’ultimo abbastanza singolare ed interessante. La Domus de Janas fino a pochi anni fa era tutta ancora interrata, e dalla piccola entrata si accede alla stanza grande nella quale si trovano altre tre entrate per altre tre camere diverse. Il tempietto rappresenta una variante nella tipologia dei cosiddetti templi a megaron, che si compone di un corpo cilindrico e di un vestibolo, che conserva tracce delle panchine addossate alle pareti.
 all’estremo sud orientale dell’area archeologica, quasi mimetizzato tra il granito delle capanne del villaggio ed il bosco circostante, sono presenti anche i resti del Dolmen di Sirilò, ossia di un monumento megalitico preistorico costituito da una tomba a camera singola, composto da grandi pietre verticali che sostenevano una pietra orizzontale. Quello di Sirilò è stato un abitato persistito dall’età prenuragica sino ai tempi del dominio romano nell’Isola. A differenza di altre strutture religiose e funerarie, il villaggio ha restituito materiali che testimoniano una continuità d’uso, anche con oggetti d’importazione etrusca e greca, il che testimonierebbe, quindi, il cambiamento culturale in atto agli inizi dell’età del Ferro, con abbandono dei precedenti valori simbolici. Le tracce proseguono fino a epoca romana, per alcuni forse il sito sarebbe stato un avamposto della resistenza indigena alla conquista imperiale. La posizione impervia, più agevole da difendere che da occupare, l’assenza nell’area di templi, cippi o iscrizioni latine e il fatto che nel territorio non vi siano toponimi di origine romana avvalorerebbero questa tesi. E viene da pensare a quanto fosse sacra questa zona, l’importanza di questo luogo, che si può immaginare come centro di cerimonie, e poi di scambi, di incontri, di paci e accordi. Un sito diversificatosi nel tempo, per uso ed impiego.
all’estremo sud orientale dell’area archeologica, quasi mimetizzato tra il granito delle capanne del villaggio ed il bosco circostante, sono presenti anche i resti del Dolmen di Sirilò, ossia di un monumento megalitico preistorico costituito da una tomba a camera singola, composto da grandi pietre verticali che sostenevano una pietra orizzontale. Quello di Sirilò è stato un abitato persistito dall’età prenuragica sino ai tempi del dominio romano nell’Isola. A differenza di altre strutture religiose e funerarie, il villaggio ha restituito materiali che testimoniano una continuità d’uso, anche con oggetti d’importazione etrusca e greca, il che testimonierebbe, quindi, il cambiamento culturale in atto agli inizi dell’età del Ferro, con abbandono dei precedenti valori simbolici. Le tracce proseguono fino a epoca romana, per alcuni forse il sito sarebbe stato un avamposto della resistenza indigena alla conquista imperiale. La posizione impervia, più agevole da difendere che da occupare, l’assenza nell’area di templi, cippi o iscrizioni latine e il fatto che nel territorio non vi siano toponimi di origine romana avvalorerebbero questa tesi. E viene da pensare a quanto fosse sacra questa zona, l’importanza di questo luogo, che si può immaginare come centro di cerimonie, e poi di scambi, di incontri, di paci e accordi. Un sito diversificatosi nel tempo, per uso ed impiego.
La necropoli ipogeica di Oreharva

 Non molto lontano dall’area archeologica di Sirilò, è possibile visitare la Necropoli ipogeica di Oreharva, situata a circa cinquecento metri di distanta in direzione sud est. La necropoli si compone di almeno diciannove Domus de Janas, di cui due incompiute e una quasi completamente interrata. Non sono tutte vicine tra loro e ci sono dei tratti abbastanza scoscesi per raggiungere alcune di esse. La necropoli si sviluppa negli affioramenti rocciosi situati nella parte alta di un costone, mentre più a monte rispetto al complesso funerario una cospicua dispersione di frammenti di ossidiana potrebbe essere indizio dalla presenza di un villaggio neo eneolitico pertinente all’area funeraria, del quale non sono state perà rinvenute tracce. Tre Domus de Janas sono state scavate su massi erratici, mentre la maggior parte di esse si apre su costoni rocciosi digradanti verso valle.
Non molto lontano dall’area archeologica di Sirilò, è possibile visitare la Necropoli ipogeica di Oreharva, situata a circa cinquecento metri di distanta in direzione sud est. La necropoli si compone di almeno diciannove Domus de Janas, di cui due incompiute e una quasi completamente interrata. Non sono tutte vicine tra loro e ci sono dei tratti abbastanza scoscesi per raggiungere alcune di esse. La necropoli si sviluppa negli affioramenti rocciosi situati nella parte alta di un costone, mentre più a monte rispetto al complesso funerario una cospicua dispersione di frammenti di ossidiana potrebbe essere indizio dalla presenza di un villaggio neo eneolitico pertinente all’area funeraria, del quale non sono state perà rinvenute tracce. Tre Domus de Janas sono state scavate su massi erratici, mentre la maggior parte di esse si apre su costoni rocciosi digradanti verso valle.
Nel settore meridionale della necropoli si trovano due tombe. La prima è la tomba I, nella quale tracce di strutture murarie racchiudono un’area semicircolare e segnano l’area antistante l’accesso, ed è l’unica che si localizza ad occidente rispetto al presunto villaggio, sul pianoro in posizione più elevata rispetto alle altre. Anche la tomba XVII, che si apre negli affioramenti rocciosi situati nella parte alta di un costone digradante dall’altopiano, appare defilata rispetto alle restanti e rappresenta il limite sud orientale della necropoli stessa.
A nord rispetto a queste prime due tombe, si trovano le tombe del settore centrale. Tra queste, la tomba II e la tomba III sono monocellulari, scavate su massi erratici ad un’altitudine simile. La tomba IV, la tomba V, la tomba VI e la tomba VII sono monocellulari, ed oltre a queste è presente anche la tomba XIX, che è interrata e non è qui documentata, tombe che sono scavate nello stesso affioramento granitico nella parte alta del costone digradante dall’altopiano verso oriente rispetto al possibile insediamento.
Ancora più a nord si trovano le tombe del settore settentrionale della necropoli. La tomba IX, la tomba VIII, la tomba XVI, ed anche la tomba XVIII che non è qui documentata, tutte monocellulari, sono scavate a mezza costa, mentre le altre tombe sono raggruppate nel medesimo costone ad una quota più bassa rispetto a tutte le altre e rappresentano il limite orientale della necropoli.
Si trova tra queste la tomba XI che è attualmente interrata. Le tombe più grandi e complesse, sulle cui pareti sono state individuate gli elementi decorativi inediti, sono la tomba X, composta da quattro celle, la tomba XII, composta da due celle nella quale tracce di strutture murarie racchiudono un’area semicircolare segnano l’area antistante l’accesso, e la tomba XIII, composta da tre celle. Gli ingressi sono tutti preceduti da un padiglione, la cella principale appare in tutti i casi di forma quadrangolare e reca al centro una grande coppella quasi imitare un focolare e probabilmente funzionale ad accogliere delle offerte durante i rituali connessi alle sepolture. Le altre celle, alle quali si accede attraverso portelli aperti ad una quota leggermente più elevata in questo primo vano, erano probabilmente funzionali ad ospitare i corpi dei defunti. Sulle pareti delle celle principali sono presenti tracce di colorazione dal giallo senape al rosso, che vanno a costruire delle vere e proprie decorazioni ancorché di non chiara e immediata lettura.
Vanno, infine, citati il tentativo di scavo della tomba XIV, e per ultima la tomba XV, pluricellulare, molto distante dalle altre, che è provvista di bancone ai due lati della cella più grande, con un arco ben levigato che inquadra il padiglione in cui poi si apre il portello di accesso.
La Domus de Janas di S’Ingardu
Torniamo ora sulla SP48. Evitando la deviazione a destra sulla SP2bis, avevamo proseguito verso sud lungo la SP48 e, percorsa appena una ciquantina di metri, avevamo trovato la deviazione a sinistra nella strada per Ventosu. Evitiamo questa deviazione e proseguiamo verso sud con la SP48, percorso circa un chilometro e mezzo e, appena passato il ponte S’Ingardus sotto il quale passa il ruscello che si immette nel laghetto balneabile di lothorgoai, si vede alla destra della strada un grande masso con, alla base, la Domus de Janas di S’Ingardu.
Il Supramonte di Orgosolo
Il Supramonte è un complesso montuoso di altopiani carbonatici che occupano la parte centro orientale della Sardegna, che si estende per trentacinquemila ettari nei territori di Oliena, Orgosolo, Urzulei, Baunei e Dorgali, paesi situati ai piedi delle alte pareti calcaree che delimitano, appunto, i confini dell’altopiano. In realtà, quello che noi definiamo Supramonte non esiste dal punto di vista geografico, nel senso che questo termine è una traduzione in italiano di un modo di dire sardo ad indicare I monti sopra, che in realtà sta ad indicare tutti quelli più alti rispetto a dove tu ti trovi. Costituito da rocce di dolomie e calcari e incorniciato da montagne carsiche tra le più alte della Sardegna, seconde in altezza solo a quelle del Gennargentu, è pressoche inaccessibile a chi non ne conosca i segreti. Si sconsiglia di avventurarsi da soli nel Supramonte e si raccomanda di chiedere informazioni all’Ispettorato Forestale di Nuoro.
Caratteristiche del Supramonte di Orgosolo
 Ad sud est del paese di Orgosolo, si sviluppano i selvaggi territori del Supramonte di Orgosolo che si originano dai contrafforti settentrionali del massiccio del Gennargentu. Il Supramonte di Orgosolo, impervio ed inaccessibile, è stato per secoli rifugio di banditi e pastori, nel cuore selvaggio della Sardegna e della Barbagia. Per chi non conoscesse il supramonte, esso può essere definito come un vasto territorio selvaggio e incontaminato, che si estende per quasi tremilacinquecento ettari, nel cuore della Sardegna. La superficie del Supramonte è profondamente modellata dal processo carsico, e percorrendolo si capisce la sua natura selvatica e incontaminata, infatti al suo interno sono evidenti le varie fasi geologiche. Si incontrano profonde gole, grotte e anfratti, e gli spettacolari tacchi calcarei di Monte San Giovanni e Monte Fumai. Nel Supramonte la fauna è molto varia ed è composta principalmente da cinghiali, volpi e mufloni, anche se non mancano specie meno comuni come martore, ghiri e gatti selvatici, e dove trovano il loro habitat anche numerose specie di volatili, principalmente rapaci come l’aquila reale, l’aquila del Bonelli, la poiana, il Falco Pellegrino, il gheppio e l’astore.
Ad sud est del paese di Orgosolo, si sviluppano i selvaggi territori del Supramonte di Orgosolo che si originano dai contrafforti settentrionali del massiccio del Gennargentu. Il Supramonte di Orgosolo, impervio ed inaccessibile, è stato per secoli rifugio di banditi e pastori, nel cuore selvaggio della Sardegna e della Barbagia. Per chi non conoscesse il supramonte, esso può essere definito come un vasto territorio selvaggio e incontaminato, che si estende per quasi tremilacinquecento ettari, nel cuore della Sardegna. La superficie del Supramonte è profondamente modellata dal processo carsico, e percorrendolo si capisce la sua natura selvatica e incontaminata, infatti al suo interno sono evidenti le varie fasi geologiche. Si incontrano profonde gole, grotte e anfratti, e gli spettacolari tacchi calcarei di Monte San Giovanni e Monte Fumai. Nel Supramonte la fauna è molto varia ed è composta principalmente da cinghiali, volpi e mufloni, anche se non mancano specie meno comuni come martore, ghiri e gatti selvatici, e dove trovano il loro habitat anche numerose specie di volatili, principalmente rapaci come l’aquila reale, l’aquila del Bonelli, la poiana, il Falco Pellegrino, il gheppio e l’astore.
Nel Supramonte di Orgosolo raggiungimo la località Funtana Bona
Per raggiungere il Supramonte di Orgosolo, percorsi circa cinque chilometri e mezzo dall’uscita dal paese, invece di svoltare a destra sulla SP2bis, proseguiamo dritti in direzione sud lungo la SP48 e, dopo circa un chilometro e mezzo, si vede alla destra della strada un grande masso con, alla base, la Domus de Janas di S’Ingardu. Passata questa Domus de Janas, proseguiamo e, dopo circa duecento metri, a un bivio proseguiamo dritti per rimanere su SP48. Dopo poco più di sette chilometri e mezzo, raggiungiamo l’ampio parcheggio della località denominata Funtana Bona (altezza metri 1072, distanza 16.7 chilometri), con la caserma dei Forestali. Nel passato a Funtana Bona, oltre alla caserma dei Forestali, c’erano anche i Carabinieri, nel periodo in cui Orgosolo era molto controllato dalle forze dell’ordine e c’erano caserme sparse in tutto il suo territorio.
Il Centro Servizi dell’Ente Foreste della Sardegna di Montes
In localtà Funtana Bona si trova l’ex Caserma della Forestale Ilodei Malu, che in lingua significa Il luogo cattivo o Il luogo oscuro, dove è stato realizzato il Centro Servizi dell’Ente Foreste della Sardegna di Montes, nel quale è stato allestito ed è possibile visitare un Museo Naturalistico.
La foresta demaniale di Montes
Nella Foresta demaniale di Montes in una delle aree più belle del parco nazionale del Gennargentu, si trovano lecci secolari, con una circonferenza anche di 15 metri ed un’altezza di 30, che in alcune aree non hanno mai subito il taglio. È presente anche un bosco di ginepri scheletriti a causa di un incendio che nel 1931 sconvolse tutto il Supramonte. L’accesso alla foresta, su una strada sterrata percorribile solo in fuoristrada, è consentito solo ai mezzi autorizzati, quindi è necessario farne richiesta all’azienda foreste demaniali.
Della foresta di Montes e della località Funtana Bona scriveva, nel 1840, il generale Alberto Ferrero della Marmora con queste parole: «C’è una Regione detta fontanabona, con alcune capanne di pastori, quasi tutti banditi del villaggio di Orgosolo, ... fui ricevuto con più di dodici fucili puntati sulla mia persona, con l’ingiunzione di non fare un passo in più ... ».
Passato l’ingresso della miniera di Fontana Bona raggiungiamo la sorgente di Funtana Bona ai piedi del monte Fumai
Dalla caserma della Forestale, considerata la porta del Supramonte, si prende sulla destra, verso sud in salita, la strada sterrata che collega Funtana Bona con il Monte San Giovanni. Questa ci porta a vedere dopo circa un chilometro alla sinistra della strada l’ingresso della miniera di Fontana Bona, fino ad arrivare dopo circa altri cinquecento metri in prossimità della sorgente di Funtana Bona, nella quale è presente una piccola area parcheggio adatta solo per automezzi o piccoli pulmini. La sorgente ha origine dal contatto delle rocce calcaree, molto permeabili, con gli strati scistosi impermeabili, e da essa ha inizio il corso del Fiume Cedrino, il quinto fiume della Sardegna.
Passato il monte Fumai raggiungiamo il monte Novo San Giovanni
La strada si snoda ai piedi del tacco calcareo chiamato Monte Fumai, un torrione calcareo dalla forma vagamente piramidale la cui cima, con i suoi 1316 metri di altezza, supera di poco l’altitudine di monte Novo San Giovanni, e costituisce una delle cime più alte del Supramonte di Orgosolo. Ripreso il cammino, ci si addentra sempre più nel bosco, fino ad arrivare alla base dell’altro tacco calcareo chiamato Monte Novo San Giovanni, alto poco quasi 1316 metri, uno dei monumenti naturali tra i più paesaggistici dell’intera Sardegna, particolarmente interessante dal punto di vista naturalistico per le sue guglie calcaree alte fino a settanta metri. Qui si può prendere il sentiero sulla sinistra che, con una serie di tornanti, porta ai piedi dei torrioni calcarei, a circa tre chilometri e mezzo dalla caserma della Forestale. Superato il cancello di legno, si può salire una scalinata ricavata sulla roccia, di possibile origine preistorica, per raggiungere la sua sommità, dove è presente una casetta in legno, riparo per gli escursionisti, che viene utilizzata d’estate per tutta la campagna antincendio come vedetta. Si tratta di un punto dal quale si vede la sottostante foresta di Montes e lo sguardo spazia dal mare fino ai monti del Gennargentu ed a quasi tutto il Supramonte di Orgosolo e Urzulei.
Lasciato alle spalle il monte Novo San Giovanni, si può riprendere la sterrata percorrendola sulla sinistra, per circa tre chilometri, fino ad arrivare al Cuile di Su Badu ’e S’Eni, ossia della valle del tasso. Nella foresta sono presenti numerosi Cuiles, gli ovili dei pastori, con le caratteristiche Pinnette che costituiscono ricoveri per gli abitanti, costruiti su base di pietra e copertura in legno e frasche.
Verso l’area di Sa Senipida
Per portarsi verso la gola di Su Gorropu, dalla caserma della Forestale prendiamo non la strada sterrata in salita sulla destra, ma quella in senso opposto, in discesa, che è la strada per Ottulu e Sa Senipida. Dalla caserma si percorrono circa sette chilometri e mezzo di saliscendi, fino ad arrivare nell’area picnic di Sa Senipida, un’area attrezzata e recintata all’interno della quale si trovano dei tavoli in legno, ed anche la fontana di Sa Sepida, dalla quale sgorga acqua potabile.
Se non si dispone di un fuoristrada, conviene parcheggiare in quest'area l’auto e continuare nel nostro viaggio proseguendo a piedi lungo la strada per il Nuraghe Mereu e Gorropu.
Sull’ampio altopiano di Campu Su Murdegu
La strada per il Nuraghe Mereu e Gorropu prosegue dapprima in discesa per poi, dopo aver attraversato un ruscello, risale in prossimità del Cuile di Sa Senepida e passa in mezzo a due grossi massi che lo fiancheggiano. Poi si inoltra all’interno della foresta di Sos Campidanesos. Usciti dalla foresta, si arriva sull’ampio altopiano di Campu Su Murdegu, ossia Hampu Su Mudelhu, di un’altezza di circa 939 metri, attorniato ai margini da lecci ginepri e in particolare dal cisto, che viene chiamato in lingua Su Mudelhu.
Su questo altopiano si sviluppa una brulla prateria, dato che l’altopiano ha avuto origine nei primi del novecento per via di un incendio, ed è stato percorso più volte in passato dal fuoco, come testimoniano i cespugli di asfodelo che predominano ed i pochi ginepri che evocano l’originario paesaggio boscoso.
L’inghiottitoio carsico di Su Disterru
 A circa 3.750 metri dall’area attrezzata, troviamo una biforcazione, svoltando nel sentiero a destra, ci inoltriamo all’interno del bosco fino ad arrivare a Campu Su Disterru, un’area vasta e pianeggiante, in parte boschiva, all’interno della quale si trova l’inghiottitoio carsico di Su Disterru, una grande voragine dall’ingresso molto ampio che scende con una serie di pozzi in profondità nel ventre della terra, fino a circa 240 metri sotto la superficie dell’imboccatura. L’inghiottitoio si apre a lato della dolina di Campu Su Disterru, in mezzo al bosco. La voragine è stata originata dallo sprofondamento della volta a causa dell’azione delle acque nel supramonte di Orgosolo, e merita senz’altro una deviazione dal nostro percorso.
A circa 3.750 metri dall’area attrezzata, troviamo una biforcazione, svoltando nel sentiero a destra, ci inoltriamo all’interno del bosco fino ad arrivare a Campu Su Disterru, un’area vasta e pianeggiante, in parte boschiva, all’interno della quale si trova l’inghiottitoio carsico di Su Disterru, una grande voragine dall’ingresso molto ampio che scende con una serie di pozzi in profondità nel ventre della terra, fino a circa 240 metri sotto la superficie dell’imboccatura. L’inghiottitoio si apre a lato della dolina di Campu Su Disterru, in mezzo al bosco. La voragine è stata originata dallo sprofondamento della volta a causa dell’azione delle acque nel supramonte di Orgosolo, e merita senz’altro una deviazione dal nostro percorso.
La lecceta di Sas Baddes nel cui sottobosco vive anche la rosa peonia
A circa 3.750 metri dall’area attrezzata, trovata la biforcazione, svoltiamo, invece, nel sentiero a sinistra, e si raggiunge la zona denominata Sas Vaddes, una zona molto ampia che prende il nome dalle due valli che la caratterizzano, ossia S'Ulihe e Sa Ihu. Qui si trova la lecceta di Sas Baddes, la più importante foresta di lecci primaria dell’intero bacino del Mediterraneo, in cui non è raro trovare alcuni giganti secolari abbattuti dal vento o dalla folgore. I lecci secolari convivono con grandi alberi di fillirea, acero minore, tasso, agrifoglio e arbusti di corbezzolo.
Tra le specie che vivono nel sottobosco è riconoscibile anche una peonia che viene chiamata rosa peonia per la sua bellezza, una pianta perenne erbacea dai fiori grandi di colore rosso porporino e dalle magnifiche e spettacolari fioriture rosee all’inizio della primavera.
I resti del Nuraghe de Mereu
 Proseguendo fino ad arrivare ad un altro bivio, a 4.750 metri dall’area attrezzata, si prende a destra e ben presto ci si inoltra all’interno del bosco. Arrivati alla fine della strada, si prosegue a piedi su un sentiero che si stacca sulla destra, ben segnalato da frecce arancioni e gialle dipinte sugli alberi e sulle rocce. Occorrono da circa venti a trenta minuti per raggiungere, a poco più di sette chilometri dall’area attrezzata, l’altura sulla quale si trova l’area archeologica di Gorroppu o Presethu Tortu, allinterno della quale sorge il nuraghe de Mereu situato in una zona montuosa di difficile penetrazione. Per chi non dispone di un fuoristrada, è possibile arrivare al Nuraghe de Mereu anche dalla SS125 Orientale Sarda provenendo da sud. Superato il bivio per Urzulei, poco prima del chilometro 183, nei pressi del Passo di Genna Silana, si prende una strada sulla sinistra verso Campos Bargios. Si prosegue per gli ovili di Sedda ’e Accas, dove si lascia la macchina per proseguire a piedi. Si scende, si attraversa il rio Flumineddu, si raggiunge l’ingresso della Gola di Su Gorropu, e da qui si risale fino a raggiungere il Nuraghe de Mereu.
Proseguendo fino ad arrivare ad un altro bivio, a 4.750 metri dall’area attrezzata, si prende a destra e ben presto ci si inoltra all’interno del bosco. Arrivati alla fine della strada, si prosegue a piedi su un sentiero che si stacca sulla destra, ben segnalato da frecce arancioni e gialle dipinte sugli alberi e sulle rocce. Occorrono da circa venti a trenta minuti per raggiungere, a poco più di sette chilometri dall’area attrezzata, l’altura sulla quale si trova l’area archeologica di Gorroppu o Presethu Tortu, allinterno della quale sorge il nuraghe de Mereu situato in una zona montuosa di difficile penetrazione. Per chi non dispone di un fuoristrada, è possibile arrivare al Nuraghe de Mereu anche dalla SS125 Orientale Sarda provenendo da sud. Superato il bivio per Urzulei, poco prima del chilometro 183, nei pressi del Passo di Genna Silana, si prende una strada sulla sinistra verso Campos Bargios. Si prosegue per gli ovili di Sedda ’e Accas, dove si lascia la macchina per proseguire a piedi. Si scende, si attraversa il rio Flumineddu, si raggiunge l’ingresso della Gola di Su Gorropu, e da qui si risale fino a raggiungere il Nuraghe de Mereu.
Il Nuraghe è conosciuto come Nuraghe de Mereu, dal nome del pastore che probabilmente un tempo pascolava le capre nella zona, e ad Orgosolo è conosciuto anche come Nurahe intro de padente, ovvero in mezzo al bosco, infatti non è visibile da lontano poiché circondato dagli alberi. Situato nei pressi della gola di Gorroppu, il Nuraghe Mereu si erge su un’altura che domina il territorio circostante. Il Nuraghe è costruito con blocchi di calcare bianco di medie dimensioni rinvenuto sul posto a 832 metri di altezza, ed è un Nuraghe di tipologia indefinita, si trattava forse di un Nuraghe complesso, costituito da un mastio centrale e due torri secondarie raccordate da cortine, una delle quali è però completamente crollata.
Rimangono in piedi la torre principale con la copertura a tholos, integra e alta circa cinque metri, e il bastione del lato ovest. L’ingresso originale si trovava sul lato sud e immetteva in un corridoio in parte ancora percorribile, al termine del quale si trova un ambiente di collegamento tra il mastio e una delle torri, oggi parzialmente crollata. La terza torre, invece, è oggi un rudere dato che è caduta intorno alla metà del nel novecento minata dai tombaroli. Si conserva in parte anche il vano scala, a sinistra dell’ingresso, che conduce alla terrazza superiore. Le torri laterali sono protette da bastioni rettilinei.
Constatata la presenza di evidenti e numerosi crolli delle mura perimetrali, soprattutto verso la scarpata sud orientale, a seguito del sopralluogo e della valutazione dello stato dell’area archeologica del Nuraghe de Mereu e del monumento che la caratterizza, si è reso necessario vietare l’accesso al sito e al monumento per il serio pericolo di crollo, oltre che vietare l’arrampicata lungo il sottostante costone e la salita alla terrazza.
I resti del Nuraghe de Gorropu o Presethu Tortu
 Per raggiungere l’insediamento nuragico di Su Gorropu, dall’ingresso del Nuraghe de Mereu si prosegue in discesa per il sentiero segnalato da delle pietre, che in circa quindici minuti porta al nuraghe de Gorropu, il cui nome esatto dovrebbe essere Nurahe Presethu Tortu. Viene così chiamato poiché in zona probabilmente si trovavano dei presethos nel calcare, che venivano coperti con sassi a piattabanda per impedire l’inquinamento da parte del bestiame, i quali venivano puliti dai pastori, lasciati riempire d’acqua con le piogge, e ricoperti limitando l’evaporazione per essere poi usati come riserva d’acqua. Erano l’unica fonte idrica del pastore e, quando si esaurivano, occorreva scendere al paese.
Per raggiungere l’insediamento nuragico di Su Gorropu, dall’ingresso del Nuraghe de Mereu si prosegue in discesa per il sentiero segnalato da delle pietre, che in circa quindici minuti porta al nuraghe de Gorropu, il cui nome esatto dovrebbe essere Nurahe Presethu Tortu. Viene così chiamato poiché in zona probabilmente si trovavano dei presethos nel calcare, che venivano coperti con sassi a piattabanda per impedire l’inquinamento da parte del bestiame, i quali venivano puliti dai pastori, lasciati riempire d’acqua con le piogge, e ricoperti limitando l’evaporazione per essere poi usati come riserva d’acqua. Erano l’unica fonte idrica del pastore e, quando si esaurivano, occorreva scendere al paese.
Si tratta di un Nuraghe di tipologia indefinita edificato in materiale indeterminato a 741 metri di altezza. Era probabilmente un Nuraghe semplice, la cui torre si conserva per una discreta altezza. Il Nuraghe, arroccato sui grandissimi canyon formati dal Rio Titione, si trova in pessimo stato di conservazione per effetto delle numerose incursioni dei tombaroli. Oggi è inaccessibile perché ingombro di materiale di crollo.
Tra i Nuraghi de Mereu e de Gorropu si trovano i resti del villaggio nuragico Presenthu Tortu
 Nel bosco di lecci tra il Nuraghe de Mereu ed il Nuraghe de Gorropu, ad est rispetto al primo ed ad ovest rispetto al secondo, sono presenti diverse tracce relative alle capanne del Villaggio nuragico di Presenthu Tortu, che sorge su uno sperone roccioso situato a sud ovest della gola omonima, all’interno di un insediamento fortificato naturalmente sul lato sud e protetto sul lato opposto da una notevole muraglia megalitica, che raggiunge un’altezza di oltre tre metri. Nell’insediamento fortificato si trovano numerose costruzioni a pianta quadrangolare.
Nel bosco di lecci tra il Nuraghe de Mereu ed il Nuraghe de Gorropu, ad est rispetto al primo ed ad ovest rispetto al secondo, sono presenti diverse tracce relative alle capanne del Villaggio nuragico di Presenthu Tortu, che sorge su uno sperone roccioso situato a sud ovest della gola omonima, all’interno di un insediamento fortificato naturalmente sul lato sud e protetto sul lato opposto da una notevole muraglia megalitica, che raggiunge un’altezza di oltre tre metri. Nell’insediamento fortificato si trovano numerose costruzioni a pianta quadrangolare.  Il villaggio, che è scomparso restituendo alla natura solo una miriade di sassi, si presenta ben protetto dai due nuraghi, lontani l’un l’altro solo ottocento metri, situati in posizione strategica per controllare tutte le vie di accesso ed a guardia dell’acqua nelle grotte vicine, tra le quali quella di Hapriles nella quale sono stati ritrovati resti di anfore votive. Inoltre, celate dentro il bosco, ci sono alcune Tombe di Giganti, riferibili allo stesso insediamento. Anche in questa zona si sono insediati i pastori infatti vicino al Nuraghe si trova l’Huvile Presethu Tortu, ossia l’ovile omonimo, che era utilizzato in passato da pastori che allevavano capre e maiali. L’area è molto grande caratterizzata dai resti di diverse capanne ossia pinnettas, e recinti ossia mandras.
Il villaggio, che è scomparso restituendo alla natura solo una miriade di sassi, si presenta ben protetto dai due nuraghi, lontani l’un l’altro solo ottocento metri, situati in posizione strategica per controllare tutte le vie di accesso ed a guardia dell’acqua nelle grotte vicine, tra le quali quella di Hapriles nella quale sono stati ritrovati resti di anfore votive. Inoltre, celate dentro il bosco, ci sono alcune Tombe di Giganti, riferibili allo stesso insediamento. Anche in questa zona si sono insediati i pastori infatti vicino al Nuraghe si trova l’Huvile Presethu Tortu, ossia l’ovile omonimo, che era utilizzato in passato da pastori che allevavano capre e maiali. L’area è molto grande caratterizzata dai resti di diverse capanne ossia pinnettas, e recinti ossia mandras.
La grotta Capriles o grotta di Hapriles
La Grotta Capriles, ossia Honchedda ’e Hapriles, si trova sulla destra orografica del canale che si immette da destra nel Rio Titione, poco lontana dalla loro confluenza. Il canale in questione si trova subito a nord est rispetto al Nuraghe de Mereu ed a nord ovest rispetto al Nuraghe de Gorropu. L’accesso all’interno della grotta è difficoltoso poiché bisogna infilarsi strisciando in uno stretto cunicolo. All’interno della grotta si può reperire l’acqua da una falda sotterranea, in tutto l’arco dell’anno.
La posizione della grotta è di difficile individuazione, a se si vuole visitarla è consigliabile farsi accompagnare da guide locali.
Le Tombe di Giganti tra il Nuraghe de Mereu ed il Nuraghe de Gorropu
Nell’area archeologica di Gorroppu o Presethu Tortu, dopo aver raggiunto il Nuraghe de Mereu, si trovano tre Tombe di Giganti, edificate tutte in materiale indeterminato. Si tratta della Tomba di Giganti di Presethu Tortu I, edificata a 762 metri di altezza; della Tomba di Giganti di Presethu Tortu II, edificata a 765 metri di altezza; e della Tomba di Giganti di Presethu Tortu III, edficata a 774 metri di altezza.
La prossima tappa del nostro viaggio
Nella prossima tappa del nostro viaggio, proseguiremo la visita dell’interno della Barbagia di Ollolai. Da Orgosolo, o addirittura da Nuoro, ci recheremo a Mamoiada famosa per la stele di Boeli e per il suo Carnevale con i Mamuthones, che rappresentano esseri tratti in schiavitù, e gli Issohadores, i loro dominatori.
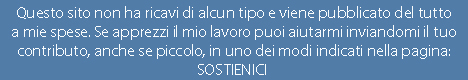
Tutte le foto e riprese sono state effettuate a scopo amatoriale per uso personale senza fini di lucro. Alle nostre foto se ne aggiungono altre inviateci da amici ed alcune tratte da Internet. Alcune informazioni sulle descrizioni dei comuni sono tratte da italiapedia.it, molte descrizioni e foto da wikimapia.org, informazioni sui siti archeologici da tharros.info, altre da siti differenti. È consentito scaricare testi, foto e riprese dell’autore per uso privato senza eliminare i riferimenti. Libri e filmati sono riprodotti per farli conoscere ma non è consentita la riproduzione delle foto di terzi, dei libri, dei filmati e di altro materiale non realizzato dall’autore. È vietato qualsiasi utilizzo commerciale del materiale in assenza di apposita autorizzazione. |
© Claudio de Tisi 2002-2026 - Codice Fiscale DTSCLD44M23F132W














































































































































